

SALVATORE CIPRESSA
L’identità, un processo in divenire
 er “identità” si intende la capacità del soggetto di auto-rappresentarsi e di percepirsi come soggetto unitario, con caratteristiche stabili e diverse da quelle altrui. Interrogarsi sulla propria identità significa, quindi, interrogarsi sul proprio io, sulla propria identità sessuale, sulla propria identità sociale, culturale. Si tratta di un processo in divenire che esige da parte della persona la consapevolezza di essere un soggetto umano e personale, ma anche sessuato.
er “identità” si intende la capacità del soggetto di auto-rappresentarsi e di percepirsi come soggetto unitario, con caratteristiche stabili e diverse da quelle altrui. Interrogarsi sulla propria identità significa, quindi, interrogarsi sul proprio io, sulla propria identità sessuale, sulla propria identità sociale, culturale. Si tratta di un processo in divenire che esige da parte della persona la consapevolezza di essere un soggetto umano e personale, ma anche sessuato.
Nel corso della vita l’identità viene messa in crisi e spesso subisce profondi mutamenti o viene ridefinita da vari fattori come la scelta della professione, il matrimonio, la maternità o paternità, i ruoli sociali, le scelte ideologiche e/o religiose, gli eventi personali. Insomma, l’identità non è una realtà immutabile acquisita una volta per tutte ma un processo in divenire, mai completamente compiuto e soggetto a continue ristrutturazioni. Essa si muove sull’orizzonte del già e del non ancora: è una realtà già data, ma anche un progetto da realizzare.
Identità sessuale, identità sessuata o identità di genere?
La persona umana deriva specifiche caratteristiche dal sesso che, sul piano biologico, psicologico e spirituale, la fanno uomo o donna. L’identità sessuale è inseparabile dalla percezione del proprio corpo, infatti, la persona tende ad identificarsi con il proprio corpo per integrare l’identità corporeo-biologica con quella psicologica. Quanto più l’integrazione è profonda, tanto più l’identità sessuale è confermata e tanto meno ha bisogno di essere rinforzata dal ruolo sociale.
A determinare l’identità sessuale di una persona non è un unico fattore, ma una molteplicità di fattori (genetici, ormonali, psicologici, sociali, ambientali, culturali, ecc.) che interagiscono tra loro e sono tutti necessari per la formazione e la strutturazione della sua identità1.
Oggi, più che parlare di identità sessuale o sessuata, si preferisce parlare di identità di genere intendendo «il senso di se stesso, l’unità e la persistenza della propria individualità maschile o femminile o ambivalente (di grado minore o maggiore), particolarmente come esperienza di percezione sessuata di se stessi e del proprio comportamento»2. Si tratta di una consapevolezza interiore, di una sensazione intima, privata, squisitamente psicologica che una persona ha del proprio genere sessuale. Se parlando di “identità sessuale” si corre il rischio di privilegiare la sola dimensione biologica, parlando invece di “identità di genere” si corre il rischio opposto di privilegiare la sola dimensione psicologica e socio-culturale. Pertanto, alcuni preferiscono parlare di identità sessuata3 facendo riferimento a tutte le dimensioni della persona (biologica, psicologica, spirituale, sociale) e all’interazione e non contrapposizione tra natura e cultura, ossia tra natura e ambiente biografico in cui la persona si sviluppa e cresce.
L’identità sessuale tra natura e cultura
Il dibattito in materia di formazione e strutturazione dell’identità sessuata ha visto contrapposti – a partire dagli anni ‘50 – due orientamenti: il determinismo biologico, e quindi anche genetico, e il determinismo socio-culturale o ambientale. Negli studi antecedenti agli anni ’50 è prevalsa la tesi del determinismo biologico, mentre dopo gli anni ’50 si è iniziato a riconoscere l’importanza anche del fattore culturale con l’inevitabile rischio, però, di cadere nel determinismo socio-ambientale.
Oggi si ritiene che «per quanto riguarda la differenziazione psicosessuale, è ormai superato il concetto della contrapposizione tra natura e cultura, tra il fattore genetico e quello ambientale, tra l’innato e l’acquisito, tra il biologico e lo psicologico o tra l’istinto e l’apprendimento. La teoria genetica moderna evita queste antiquate dicotomie e postula una norma genetica di interazione fra i vari fattori»4. L’opzione finale è per una posizione equilibrata, ovvero per la presenza di una reciproca interazione tra elemento naturale ed elemento socio-culturale, quasi una sorta di “compromesso” tra biologia, genetica, psicologia e sociologia.
L’identità sessuale, quindi, non è il risultato solo di fattori naturali o solo di fattori culturali ma di una interazione tra entrambi. Anche se è difficile determinare con precisione quanto e come questi fattori interagiscano tra loro, nel senso che non si conosce bene quale sia l’equilibrio modale tra i fattori costituzionali o innati e quelli educativi o acquisiti. Dal punto di vista scientifico non è possibile dare rilievo ad un fattore escludendo l’altro, così come radicalizzare il contrasto tra natura e cultura. Nello studio delle differenze individuali, i sociologi sono sempre più consapevoli dell’importanza dei fattori genetici, e i genetisti dell’importanza dei fattori sociali e culturali. La sessualità investe integralmente l’uomo: se da un lato lo radica saldamente nel datum della natura, dall’altra lo sospinge verso il novum della cultura5.
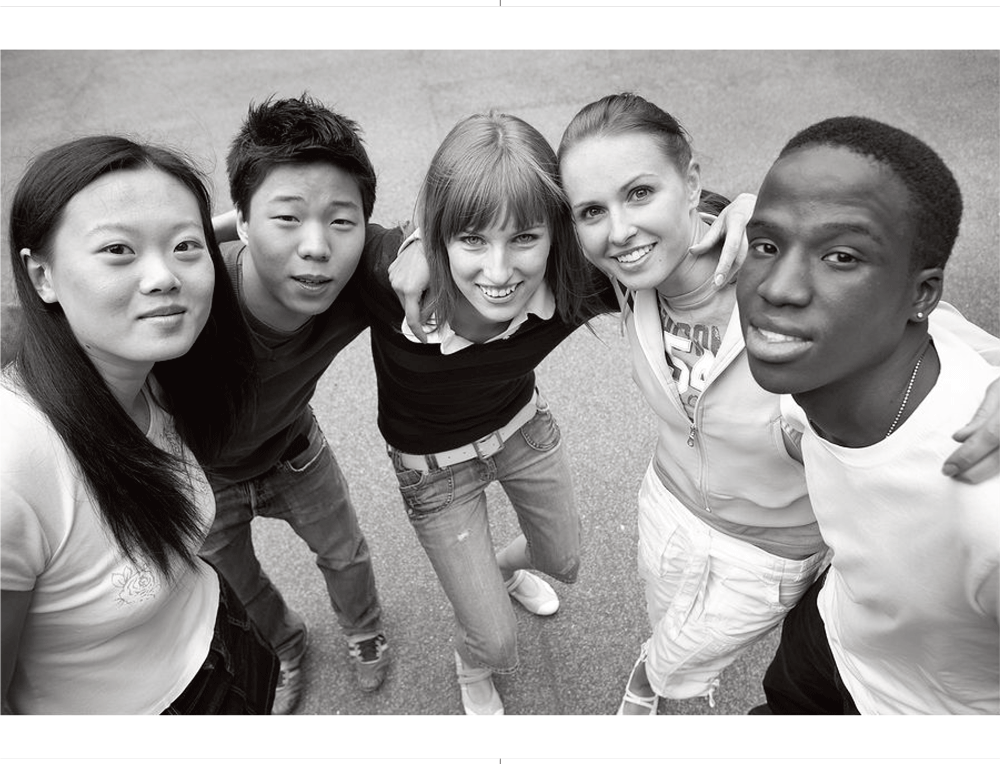
L’identità, che ha un fondamento biologico, si sviluppa mediante esperienze corporee, investimenti affettivi e riconoscimenti coscienti, a cui si sovrappongono modelli culturali elaborati dalla società.
Verso una educazione interculturale
Il concetto di «identità» rimanda necessariamente al concetto di «relazione». Contrariamente all’individuo, che è un essere chiuso in se stesso e totalmente autoreferenziale, la persona è soggetto costitutivamente relazionale che ha bisogno di entrare in dialogo fecondo con gli altri.
L’identità personale si definisce in rapporto all’alterità perché la misura del mio io mi è data dall’io che riconosco nel tu6. Nel dialogo con l’alterità, ogni persona trova nell’altro l’occasione per diventare sempre più se stessa e confermare la propria identità, ma nello stesso tempo percepire la sua non identificazione con l’altro. L’identità, infatti, è una conquista per autocoscienza e, insieme, una conferma che viene dall’altro, in un gioco di meccanismi d’identificazione e di differenziazione, sicché vi è un continuo “io mi riconosco/io mi distanzio”, “l’altro-come-me/l’altro-non-come-me”.
La persona è una struttura aperta che si costituisce e si costruisce sulla base della relazione interpersonale. Aprendosi agli altri, la persona cresce come persona umana. Si è se stessi grazie all’altro.
L’antropologia contemporanea tende quindi a individuare la ragione ultima dell’identità nella relazione interpersonale, anche se bisogna riconoscere che la categoria della relazione, pur essendo una categoria fondamentale dell’autocomprensione umana, non è l’unica categoria perché l’uomo trascende il suo farsi nella storia. Egli è identità personale in una soggettività aperta alla trascendenza7.
Le culture sono sistemi di significato e paradigmi ermeneutici per leggere, interpretare e dare significato alla realtà umana e sociale. L’uomo rappresenta e interpreta i mondi vitali, elabora il senso delle cose e ne codifica i significati nel linguaggio.
Se la realtà è molteplice, anche le culture sono molteplici. La multiculturalità, che considera la pluralità delle culture, deve diventare interculturalità, ossia incontro, dialogo e interazione tra culture. L’interculturalità favorisce il dialogo e promuove un confronto tra le diverse culture, che sono in funzione di una società umanamente più ricca. L’incontro con persone appartenenti ad altre culture e religioni struttura e plasma l’identità personale e sessuale. 
L’educazione interculturale è condizione strutturale della società multiculturale e multietnica. Tale educazione sviluppa il potenziale comunitario di ciascuna cultura e la impegna a costruire la convivenza delle diversità, nella democrazia delle differenze. Essa comporta non solo l’accettazione e il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione, di collaborazione, di arricchimento reciproco. «Il bene comune domanda anche che si mettano in atto iniziative orientate ad affrontare i problemi posti dalla società interculturale, verso cui il nostro Paese si sta ormai avviando. In primo luogo è da richiamarsi la responsabilità dei luoghi e delle forze educative, che devono proporre e aiutare la comprensione delle differenze, passando dalla “cultura dell’indifferenza” alla “cultura della differenza”, e da questa alla “convivialità delle differenze»8.
NOTE:
1 Cf. G. Cesari, M. L. Di Pietro, L’educazione della sessualità, La Scuola, Brescia 1996, p. 31.
2 Money, A.A. Ehrhardt, Uomo, donna, ragazzo, ragazza, Feltrinelli, Milano 19772, p. 18.
3 L. Di Pietro (a cura di), Educare all’identità sessuata, La scuola, Brescia 2000.
4 Money, A.A. Ehrhardt, Uomo, Donna Ragazzo, Ragazza, Feltrinelli, Milano 19772, 15.
5 G. Bof, «Uomo», in G. Barbaglio, S. Dianich (a cura di), Nuovo dizionario di teologia, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 19854, p.1859.
6 Cf. G. F. Zuanazzi, Temi e simboli dell’eros, Città Nuova, Roma 1991, pp. 9 - 34.
7 K. Demmer, Interpretare e agire. Fondamenti della morale cristiana, Paoline, Cinisello Balsamo 1989, pp. 127 – 130.
8 CEI, Educare alla legalità. Nota pastorale della Commissione ecclesiale giustizia e pace, Roma 4 ottobre 1991, n. 13.
 IT
IT  EN
EN 



















