

GIUSEPPE TRENTIN

 a alcuni decenni, in connessione con il movimento di “riabilitazione della filosofia pratica”1, sviluppatosi in Europa nella seconda metà del Novecento, assistiamo a un rinnovato interesse per l’etica applicata2. Non si tratta più, come nel Novecento, di affrontare problemi di natura prevalentemente metaetica, di analisi linguistica o dello statuto epistemologico e ontologico degli asserti a carattere morale. Tanto meno di imboccare, come nei secoli precedenti, la strada delle scienze positive adottandone strumenti teorici e metodologici. La tendenza oggi porta verso la ricerca di un’etica autonoma dotata di un suo statuto epistemologico, di un suo metodo di analisi, e dunque di una sua capacità di discernere e argomentare in modo rigoroso e convincente quando si tratta di valutare se una determinata scelta è moralmente corretta e perché. Di qui l’interesse non solo per il discernimento, ma anche per una verifica della validità o meno di argomentazioni etico-normative non sempre in grado di articolare in modo corretto fatti e valori, dati empirici e valutazioni morali.
a alcuni decenni, in connessione con il movimento di “riabilitazione della filosofia pratica”1, sviluppatosi in Europa nella seconda metà del Novecento, assistiamo a un rinnovato interesse per l’etica applicata2. Non si tratta più, come nel Novecento, di affrontare problemi di natura prevalentemente metaetica, di analisi linguistica o dello statuto epistemologico e ontologico degli asserti a carattere morale. Tanto meno di imboccare, come nei secoli precedenti, la strada delle scienze positive adottandone strumenti teorici e metodologici. La tendenza oggi porta verso la ricerca di un’etica autonoma dotata di un suo statuto epistemologico, di un suo metodo di analisi, e dunque di una sua capacità di discernere e argomentare in modo rigoroso e convincente quando si tratta di valutare se una determinata scelta è moralmente corretta e perché. Di qui l’interesse non solo per il discernimento, ma anche per una verifica della validità o meno di argomentazioni etico-normative non sempre in grado di articolare in modo corretto fatti e valori, dati empirici e valutazioni morali.
Carenze etiche nella formazione tecnico-scientifica e religiosa
Nella recezione di questa istanza era sembrato in un primo momento che i teologi avessero un certo vantaggio nei confronti dei cultori laici dell’etica applicata in quanto potevano attingere a una tradizione nella quale da molto tempo si praticava un metodo di analisi, comunemente definito casistico o casuistico, teso a ricercare “caso per caso” le risposte e le soluzioni più adeguate a problemi e interrogativi di carattere morale che si venivano ponendo sempre più di frequente all’interno di una società in continua evoluzione3. Ma si è trattato di un vantaggio di breve durata, in quanto i problemi e gli interrogativi morali che si pongono oggi sono in parte nuovi, in parte molto più complessi di quelli presi in considerazione dalla casistica o casuistica tradizionale. Anche per questo, forse, si guarda all’etica applicata con atteggiamenti e sentimenti diversi, se non contrapposti.
Vi è chi vede in essa l’opportunità di un ritorno al passato e chi al contrario si dedica alla ricerca di teorie e metodi di ricerca nuovi e più adeguati. Attualmente l’unica certezza e convinzione condivisa da tutti è la constatazione che non si può ulteriormente ignorare la preoccupante carenza di formazione etica di quanti operano nei vari ambiti dell’agire umano, dalla famiglia alla società, dall’economia alla politica, dalla ricerca scientifica alla pratica religiosa. Si è sempre più convinti che da questa formazione etico-normativa, oltre che tecnico-scientifica, dipenda il futuro di tanti giovani e il loro inserimento nella società come operatori competenti e responsabili.
La varie riforme della scuola e dell’università non possono ignorare ulteriormente il problema. Non si vuole qui entrare nel merito di riforme o progetti di riforma che non ci competono: si vuole solo richiamare l’attenzione sull’importanza e anche sull’urgenza di introdurre nei programmi di preparazione al mondo del lavoro, della professione, della pratica religiosa, una disciplina, l’etica normativa appunto, che per certi aspetti appare ineludibile e non ulteriormente procrastinabile per una formazione veramente adeguata e responsabile. Non a caso quando si parla di persona “non professionale” o “non all’altezza del compito” si fa riferimento sempre più spesso non solo a gravi lacune sul piano della competenza tecnico-scientifica, ma anche, e purtroppo sempre più spesso, a gravi offese e trasgressioni di valori e norme morali che sono alla base dei rispettivi codici deontologici.
Il motivo è semplice: nelle decisioni che siamo chiamati a prendere nelle più svariate situazioni della vita vi sono sempre due componenti strettamente legate fra di loro, anche se concettualmente distinte o comunque distinguibili: la padronanza della conoscenza tecnico-scientifica e il riferimento ai valori che si perseguono. E dal momento che su ognuno incombe il dovere di essere attento a entrambe queste componenti ne consegue il dovere di prepararsi ad affrontare con competenza e responsabilità le implicazioni tecnico-scientifiche, ma anche etico-normative, del lavoro, della professione, della pratica religiosa.
Oltretutto una maggiore preparazione e formazione etico-normativa non potrà che essere di beneficio al lavoratore, al professionista, all’operatore religioso, che nelle motivazioni dei valori e nelle indicazioni etiche troverà stimoli e criteri per un rinnovato impegno nell’applicazione di ciò che ha appreso e assimilato durante gli anni di studio. Si potranno così individuare e superare più facilmente errori o incoerenze morali che possono derivare da un modo piatto, abitudinario, tutto sommato formale, di concepire e di vivere il lavoro, la professione, la religione4.
Il fine giustifica i mezzi? Un problema sempre attuale
Una delle questioni che in ambito lavorativo, professionale, religioso, si pongono sempre più spesso è un problema antico e sempre nuovo: il fine giustifica i mezzi? Una domanda a cui solitamente si risponde in modo piuttosto categorico e assertivo affermando contro una certa spregiudicatezza che “il fine buono non giustifica i mezzi cattivi”. Affermazione, questa, che in sé non è né vera, né falsa. Per stabilire i casi nei quali questa affermazione è vera o falsa è necessario chiarire se i due aggettivi “buono” e “cattivo” hanno significato morale o non morale. E fintanto che non si chiarisce se parlando di fini e mezzi ci si pone a livello morale o non-morale ogni risposta sarà quanto meno inadeguata e solleverà obiezioni e contro-obiezioni a non finire.
Di qui l’opportunità di articolare meglio la domanda utilizzando uno schema logico che permetta di illustrarne il senso a partire da quattro possibili interpretazioni.
Prima interpretazione: nessun fine “moralmente buono” giustifica un mezzo “moralmente cattivo”. Alla base di questa formulazione s’intravede un presunto conflitto tra un valore/fine morale e un valore/mezzo ugualmente morale. Si parte cioè dal presupposto che vi siano situazioni nelle quali la moralità (valore morale) di una persona entri in concorrenza con la moralità di un’altra. Ma dal momento che la moralità (valore morale) di una persona si fonda esclusivamente sulla volontà del singolo, situazioni del genere sono semplicemente impossibili. Si può dare il caso che la vita (valore non-morale) di una persona entri in concorrenza con la vita di una o più persone, ma non che la moralità di un singolo vada a scapito della moralità di un altro. Nessuno è moralmente buono o cattivo a causa di un altro.
Seconda interpretazione: nessun fine “moralmente buono” giustifica un mezzo “non-moralmente cattivo”. Il conflitto qui è tra un valore/fine morale e un valore/mezzo non-morale. Si pensi a Tommaso Moro che ha preferito morire, rinunciare alla propria vita, piuttosto che tradire la sua coscienza. Si pensi anche a una persona che dalla spiaggia vede un bagnante in pericolo di annegare. La domanda è: se non sa nuotare ha il dovere di gettarsi in acqua e soccorrerlo? Evidentemente no, stante il rischio che muoiano entrambi. Ci sono però persone che sentono il dovere di farlo, anche a rischio di perdere la propria vita: come valutare la loro scelta? La difficoltà argomentativa in questo caso sta nel comprendere che vi sono azioni permesse, in sé lecite, ma non universalizzabili, e cioè obbligatorie per tutti. La casistica tradizionale parlava di opere “super-erogatorie”, e cioè azioni la cui moralità si valuta più in riferimento all’atteggiamento che al comportamento.
Terza interpretazione: nessuno fine “non-moralmente buono” giustifica un mezzo “moralmente cattivo”. Qui il conflitto è tra un valore/fine non-morale e un valore/mezzo morale. Si pensi a un capo di Stato che per difendere il suo paese decide di rendere più efficiente l’esercito e per ottenere ciò nega o reprime il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare. Non si ravvisa alcuna difficoltà argomentativa: un valore non-morale non prevale mai su un valore morale. Se poi in casi estremi, poniamo il rischio di distruzione dell’umanità, sia possibile pensare a una modifica di tale interpretazione è un problema che rimanda a un dibattito, che affronteremo più avanti, sulla validità o meno di argomentazioni che non tengano conto delle conseguenze di un’azione o tenendone conto si appellino a ulteriori istanze come la natura o la volontà di Dio.
Quarta e ultima interpretazione: nessun fine “non-moralmente buono” giustifica un mezzo “non-moralmente cattivo”. Il conflitto è tra un valore/fine non-morale e un altro valore/mezzo ugualmente non-morale. Si pensi a un malato che per non morire decide di sottoporsi a un’operazione chirurgica di asportazione di un organo o alla soppressione di una funzione corporea. Neanche qui si ravvisano difficoltà argomentative. La vita infatti è sì un valore non-morale, ma è più fondamentale dell’integrità di un organo o di una funzione corporea: logico quindi che in caso di conflitto il valore-vita prevalga sul valore-organo o il valore-funzione5.
A partire da queste quattro interpretazioni si possono comprendere due cose: quanto sia importante anche in campo etico un uso corretto, per quanto possibile univoco, del linguaggio; e quanto siano frequenti i conflitti di valore che nella vita siamo chiamati ad affrontare. Due problemi cui lo schema proposto offre una soluzione, ma da riprendere e analizzare introducendo ulteriori chiarificazioni e precisazioni.
Alla ricerca di un’argomentazione etica rigorosa e convincente
In riferimento al linguaggio la prima cosa da chiarire e precisare è la differenza tra due termini, “morale” ed “etica”, che per alcuni sono sinonimi, equivalenti, per altri no, veicolano significati diversi. Il fatto è che vi sono autori i quali preferiscono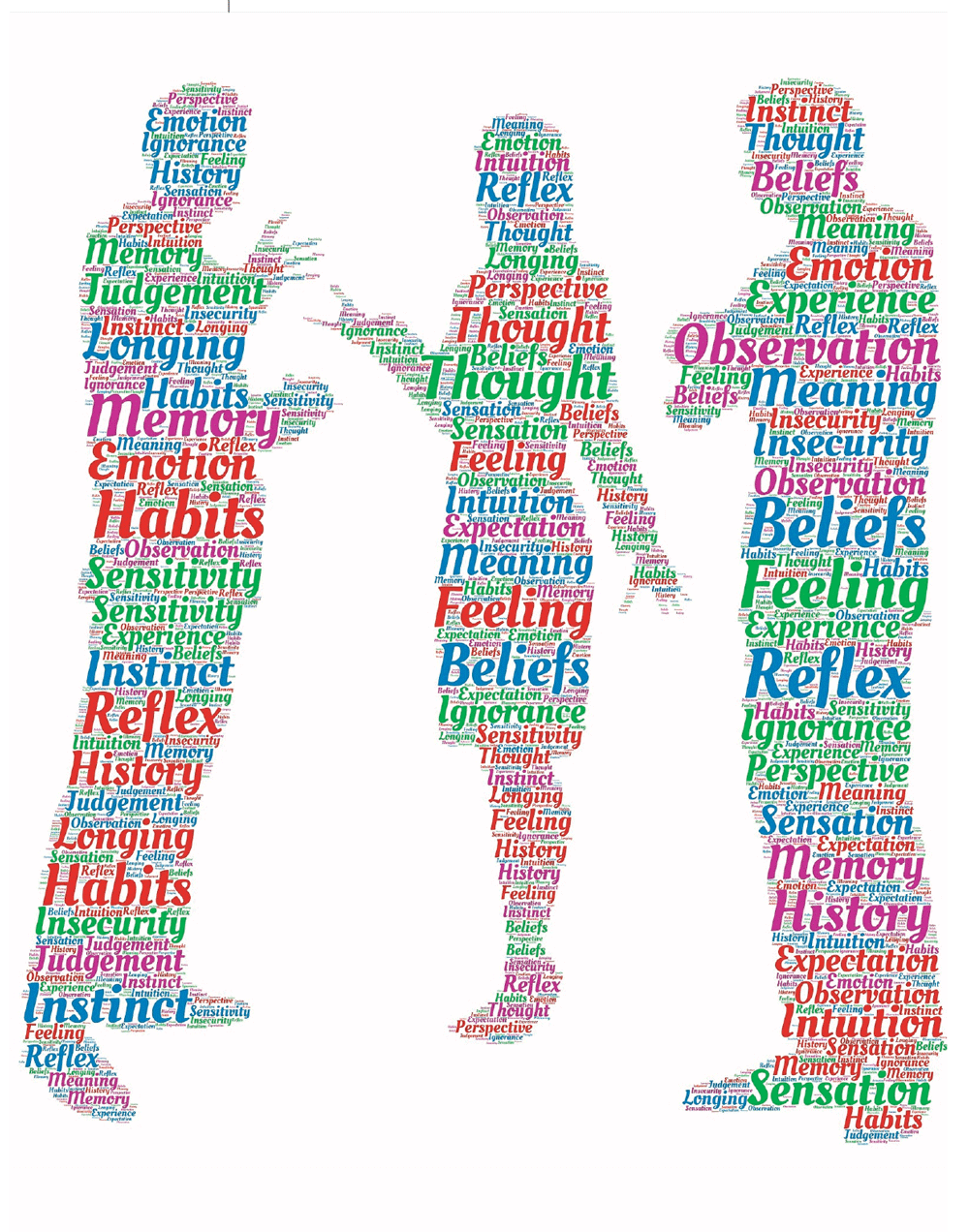 attingere all’etimologia latina “mores”, costumi, da cui deriva il termine morale, e autori che attingono all’etimologia greca “ethos”, costume, da cui deriva il termine etica. Non tutti avvertono però che attingendo alla lingua greca si può disporre di due termini: ethos, per indicare il costume, ed etica, per indicare la riflessione sul costume. Attingendo viceversa alla lingua latina si dispone di un solo termine, “mores”, costumi, che finisce per inglobare entrambi i significati ed esporsi a una certa ambivalenza, per evitare la quale è sempre bene chiarire, a meno che non risulti già chiara in riferimento al contesto di chi parla o scrive6.
attingere all’etimologia latina “mores”, costumi, da cui deriva il termine morale, e autori che attingono all’etimologia greca “ethos”, costume, da cui deriva il termine etica. Non tutti avvertono però che attingendo alla lingua greca si può disporre di due termini: ethos, per indicare il costume, ed etica, per indicare la riflessione sul costume. Attingendo viceversa alla lingua latina si dispone di un solo termine, “mores”, costumi, che finisce per inglobare entrambi i significati ed esporsi a una certa ambivalenza, per evitare la quale è sempre bene chiarire, a meno che non risulti già chiara in riferimento al contesto di chi parla o scrive6.
Ma al di là della terminologia ciò che importa chiarire e precisare è che il costume, il vissuto, è sempre impregnato di valori e norme che vengono interiorizzate in modo spontaneo, irriflesso, senza un’adeguata consapevolezza critica dei processi che li depositano. E’ un po’ come quando si respira: quasi mai si pensa al respiro, a meno che non si avvertano difficoltà di respirazione. In ambito morale avviene più o meno la stessa cosa: prendiamo decisioni, facciamo scelte, in modo relativamente spontaneo, irriflesso. Solo quando incappiamo in qualche contraddizione o conflitto ci poniamo il problema. Così ad esempio se una determinata azione o comportamento per alcuni è moralmente giusta e per altri moralmente sbagliata è inevitabile che se ne discuta, si apra un dialogo, un confronto, ci si chieda chi ha ragione e chi ha torto.
Si passa così dall’ethos all’etica, dal costume alla riflessione sul costume, sulla prassi, alla ricerca dei motivi giustificativi per cui in riferimento a una stessa azione o comportamento vi è chi afferma che è moralmente giusto e chi al contrario moralmente sbagliato. Ovvio che per arrivare a un chiarimento non è sufficiente affermare, dichiarare, ribadire il proprio punto di vista. E nemmeno esortare, ricorrere a minacce, ritorsioni, o a promesse, blandizie varie. Si deve ragionare, argomentare, portare ragioni, argomenti, che siano convincenti: impresa tutt’altro che facile in quanto oltre all’analisi dei dati e degli elementi moralmente rilevanti di un determinato contesto operativo si deve avere la consapevolezza di vivere in un mondo in cui un valore può entrare in conflitto con un altro e che a volte non si possono realizzare entrambi. In altri termini per ragionare o argomentare è necessario disporre di una teoria e di un metodo che permettano anzitutto di individuare dove si situa il problema, se a livello empirico o valoriale; e in secondo luogo quale dato sia moralmente rilevante o quale valore in caso di conflitto debba prevalere su altri.
Di qui l’opportunità di illustrare due metodi o modi di ragionare, di argomentare, che hanno alle spalle due teorie o concezioni della morale oggi relativamente diffuse e praticate.
La prima, definita deontologica (dal greco “deon”, dovere), viene adottata da quanti sostengono che la rettitudine o l’erroneità morale di un’azione non dipendono unicamente dalle conseguenze dell’azione, ma anche da altri elementi, come il riferimento alla natura o alla volontà di Dio. La seconda, definita teleologica (dal greco “telos”, fine), viene adottata da quanti sostengono che la rettitudine o l’erroneità morale di un’azione o comportamento dipendono esclusivamente dalle conseguenze dell’azione o comportamento da intendere in senso ampio. Da un punto di vista rigorosamente logico si può dimostrare che la seconda è più convincente della prima. In effetti se si interpreta la natura in senso puramente fisico/biologico s’incappa nella cosiddetta fallacia naturalistica, vale a dire nell’obiezione che imputa a chi argomenta a partire da una natura così intesa di compiere un salto, di passare dal dato al valore, dall’essere al dover essere. Se viceversa si interpreta la natura in senso metafisico/spirituale si evita il salto logico, ma da un punto di vista argomentativo s’incappa in una petizione di principio, secondo cui un’azione o comportamento è moralmente giusto perché corrisponde alla natura, alla dignità della persona, e corrisponde alla natura, alla dignità della persona, perché è moralmente giusto. Si deve dire più o meno la stessa cosa anche in riferimento alla volontà di Dio. Ci si può chiedere infatti: un’azione o comportamento è moralmente giusto perché corrisponde alla volontà di Dio o corrisponde alla volontà di Dio perché è moralmente giusto? Ma anche prescindendo da tali obiezioni si può dimostrare che l’argomentazione teleologica è l’unica praticabile all’interno di una società nella quale il riferimento alla natura e alla volontà Dio non è più condiviso e dunque non funge più, a ragione o a torto, come riferimento valido per tutti. Certo però che anche l’argomentazione teleologica, avendo alle spalle una teoria etico-normativa ben precisa, rimanda ad alcuni presupposti che ne determinano la validità ed è comunque opportuno richiamare ed esplicitare, per quanto sinteticamente7.
Il primo presupposto è una corretta analisi dei dati e degli elementi moralmente rilevanti che emergono da un contesto operativo ben determinato. Al riguardo sarà bene precisare che a partire da una teoria etico-normativa di matrice teleologica non sono da considerare elementi moralmente rilevanti le circostanze individuali, di tempo e di luogo: se lo fossero sarebbe pressoché inevitabile soccombere a un relativismo etico-normativo e metaetico che nega la possibilità di pervenire a un giudizio o a una norma morale valida per tutti.
Il secondo presupposto è una chiara distinzione tra valore morale e non-morale da una parte, e atteggiamento moralmente buono e comportamento moralmente retto dall’altra. Per valore morale s’intende qui la qualità di una persona che risulta esclusivamente dal suo atteggiamento, dal suo modo di porsi di fronte al punto di vista morale, costituito dalla cosiddetta regola d’oro recepita anche dal Vangelo o dall’imparzialità o universalizzabilità del giudizio morale. Per valore non-morale, viceversa, s’intende tutto ciò che in sé è un bene, ma la cui realizzazione non dipende esclusivamente dalla libertà della persona: pensiamo a valori come la vita, la salute, l’intelligenza, la ricchezza, la gioia, ecc., tutti valori non-morali che insieme al valore morale entrano nella determinazione concreta di un comportamento moralmente retto.
Terzo e ultimo presupposto è il riferimento a un mondo di valori variamente organizzato e articolato dal quale emergono come altrettante evidenze etiche non una, ma diverse scale di preferenza che rimandano a valori più o meno alti, più o meno fondamentali, più o meno urgenti. Ne deriva che in caso di conflitto il valore morale più alto della libertà di coscienza o di fede prevale sul valore non-morale meno alto della vita. Il valore non-morale più fondamentale della vita prevale su valori non-morali meno fondamentali come la salute, la ricchezza, l’onore, ecc. Il valore più urgente della cura, dell’assistenza, del soccorso a chi è in difficoltà prevale su valori meno urgenti, come partecipare a una cerimonia, un convegno, un evento sportivo, ecc.
In conclusione per un discernimento e un’argomentazione morale in etica applicata serve avere alle spalle una teoria etico-normativa condivisa: quella adottata nell’analisi del rapporto fine-mezzi è di tipo teleologico, non deontologico, e a noi sembra da  preferire per i motivi esposti. Serve poi un metodo di analisi che verifichi la congruità o meno del rapporto fine-mezzi a partire da quattro criteri generali: imparzialità o universalizzazione del giudizio morale; calcolo della possibilità o meno di un’azione; analisi delle conseguenze che ne derivano; ricerca del bene per sé, ma anche per gli altri. Nella pratica non sempre questo avviene: a volte si trascura un criterio, altre volte un altro. Di qui la difficoltà di pervenire alla formazione di un ethos condiviso, di un costume, di un modo di pensare e agire che al di là delle differenze culturali e religiose che lo connotano corrisponda di volta in volta, anche in campo morale, a un modo di discernere e argomentare ben fondato e convincente.
preferire per i motivi esposti. Serve poi un metodo di analisi che verifichi la congruità o meno del rapporto fine-mezzi a partire da quattro criteri generali: imparzialità o universalizzazione del giudizio morale; calcolo della possibilità o meno di un’azione; analisi delle conseguenze che ne derivano; ricerca del bene per sé, ma anche per gli altri. Nella pratica non sempre questo avviene: a volte si trascura un criterio, altre volte un altro. Di qui la difficoltà di pervenire alla formazione di un ethos condiviso, di un costume, di un modo di pensare e agire che al di là delle differenze culturali e religiose che lo connotano corrisponda di volta in volta, anche in campo morale, a un modo di discernere e argomentare ben fondato e convincente.
NOTE:
1 Il movimento della cosiddetta riabilitazione della filosofia pratica, nato in Germania agli inizi degli anni Sessanta con la formula di Rehabilitierung der praktischen Philosophie, si connota come un movimento di rinascita dell’interesse filosofico per le tematiche della morale, del diritto e della politica, affrontate da una prospettiva alternativa rispetto sia a quella tecnico-scientifica che a quella metafisico-trascendentale: cfr. in proposito M. Riedl, Rehabilitierung der praktischen Philosophie, 2 Bd., Rombach, Freiburg/Br., 1972-1974. Per un primo commento e una valutazione di tale movimento cf. F. Volpi, La rinascita della filosofia pratica in Germania, in: C. Pacchiani (ed.), Filosofia pratica e scienza politica, Francisci, Abano Terme (Pd) 1980, 11-97. Dello stesso autore: Tra Aristotele e Kant: orizzonti, prospettive e limiti del dibattito sulla “riabilitazione della filosofia pratica” in: C.A. Viano, Teorie etiche contemporanee, Bollati Boringhieri, Torino 1990.
2 È Aristotele a definire per primo la filosofia pratica, che è poi la matrice di quella che oggi chiamiamo etica applicata: “È giusto anche chiamare la filosofia scienza della verità, poiché di quella teoretica è fine la verità, mentre di quella pratica è fine l'opera ; se anche infatti i (filosofi) pratici indagano come stanno le cose, essi non considerano la causa per sé, ma in relazione a qualcosa ed ora”. Metafisica, II, 1, 993 b 19-23.
3 Non è un caso che i primi in Italia a interessarsi di etica professionale e del lavoro siano stati proprio i teologi. Ne sono una testimonianza i tre volumi, a cura di S. Privitera, Lineamenti di etica professionale; La professione fra ideale e realtà; L’etica nei comitati di bioetica, Edi Oftes, Palermo 1988, che riportano gli atti di altrettanti seminari, organizzati dalla Facoltà teologica della Sicilia, a cui fra gli altri ha partecipato a suo tempo anche il sottoscritto.
4 Espressione, ma anche sollecitazione di questo interesse per la formazione etica è la rivista quadrimestrale della Fondazione Lanza, Centro studi di etica applicata, Etica per le professioni, Proget Edizioni, Casalserugo, Padova.
5 Per ulteriori approfondimenti cfr. R. Ginters, Valori, norme e fede cristiana, Marietti, Casale Monferrato 1982, in particolare 130-133.
6 Per l’analisi di tale ambivalenza cfr. fra gli altri C.A. Viano, Etica, Enciclopedia filosofica ISEDI, Istituto Editoriale Internazionale, Milano 1975, 7-23. L’autore fa sua la critica secondo cui l’etica tende a costituirsi in codificazione dei comportamenti regolari imposti dal dominio economico e ideologico della classe dominante, per cui altro non sarebbe che una razionalizzazione della coattività dell’assetto sociale. Altri studiosi ovviamente non la pensano così e rivendicano all’etica una funzione critica della società in nome di una razionalità che attinge al mondo dei valori come dimensione ed espressione profonda dell’essere umano.
7 Solitamente a questo punto s’introduce il discorso sull’antropologia e la sua rilevanza o meno in etica normativa: cf. in proposito il bel saggio chiarificatore di P. Cognato, Antropologia etica fede cristiana. Prolegomeni di epistemologia teologico-morale, in: P. Carlotti (a cura di), La teologia morale italiana e l'Atism a 50 anni dal Concilio: eredità e futuro, Cittadella Editrice, Assisi 2017, 109-132. Per ulteriori analisi e approfondimenti cfr. A. Holderegger – W. Wolbert (edd.), Deontologie –Teleologie. Normetheoretische Grundlagen in der Diskussion, Verlag Herder, Freiburg-Wien 2012. Di tale opera miscellanea è attualmente a disposizione in lingua italiana solo un’ampia recensione del volume a cura del sottoscritto: cfr. G. Trentin, Deontologia e teleologia. Fondamenti teoretico-normativi in discussione in: Rivista di teologia morale 182(2014), 285-293.
NOTA EDITORIALE
Il testo è stato commissionato originariamente da OIKONOMIA ma la Rivista di Teologia lo ha pubblicato prima di noi per un accordo intercorso tra l'Autore e le riviste.
 IT
IT  EN
EN 



















