
 ANTONIO SACCO
ANTONIO SACCO
Etica delle virtù e giustizia
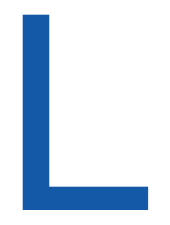 a giustizia è necessaria per la realizzazione del soggetto? E’ una qualità fondante perché quest’ultimo esplichi in pienezza quello che lo contraddistingue comesoggetto umano? La prospettiva che mi è sembrata più adatta per rispondere a queste domande, nel mio volume La Giustizia come Virtù, è stata quella dell’etica delle virtù.1 Ho affrontato come primo elemento il tema della giustizia acquisita dal soggetto, per giungere in seguito all’apporto teologico ed a comprenderne il significato in quanto virtù infusa di giustizia.
a giustizia è necessaria per la realizzazione del soggetto? E’ una qualità fondante perché quest’ultimo esplichi in pienezza quello che lo contraddistingue comesoggetto umano? La prospettiva che mi è sembrata più adatta per rispondere a queste domande, nel mio volume La Giustizia come Virtù, è stata quella dell’etica delle virtù.1 Ho affrontato come primo elemento il tema della giustizia acquisita dal soggetto, per giungere in seguito all’apporto teologico ed a comprenderne il significato in quanto virtù infusa di giustizia.
Comunemente la giustizia non viene individuata come una virtù, piuttosto sono le prospettive procedurali, ad esempio di tipo contrattualistico, che sono utilizzate per una comprensione det- tagliata della stessa. La giustizia si pensa senza un riferimento al soggetto agente: invece indi- viduare la giustizia come virtù significa proprio l’opzione contraria.
La prospettiva etica adottata è stata quella della “prima persona”: il soggetto agente nella “situazione pratica originaria” si indirizza al bene autentico.
Razionalità naturale della giustizia
1. Inclinazioni
Ho affrontato il tema della giustizia partendo dalla questione delle inclinazioni. Esse sono delle tendenze proprie dell’umano, delle costanti antropologiche. L’identificazione del valore delle stesse è un argomento che ha aperto il discorso dell’etica delle virtù all’ambito della legge natu- rale, nella comprensione tommasiana di S Th I II 94,2.
Ricordo tre passaggi:
a) Le tendenze naturali, lasciate a se stesse, non conducono direttamente ad un fine umano autentico; non realizzano direttamente un bene morale.
b) Le inclinazioni devono essere indiriz- zate dalla razionalità la quale si esprime con deicriteri – dei fini – che permettono di raggiungere le finalità dell’umano.
c) In un passaggio ulteri- ore – centrale per la virtù di giustizia – questi cri- teri, questi fini, non sono altro che i fini, o principi di indirizzo, delle stesse virtù. Il soggetto giunge alla vita buona nella sua condotta se è un soggetto guidato dalle virtù.
Questo schema generale è stato applicato alla giustizia. L’inclinazione che è legata a questa virtù è infatti quella della socialità.
Nessun soggetto può fare a meno di pensarsi come un essere sociale perché non potrebbe rag- giungere un compimento della sua umanità che sia espressivo della stessa. Spiegare un’incli- nazione legandola alla natura del soggetto im- pedisce di strumentalizzarla, di renderla disponibile ad una costruzione totalmente esteri- ore.
Una delle tesi di questo lavoro è la necessità della presenza della giustizia nell’indirizzo della socialità perché questa realizzi un bene umano autentico.
La giustizia è una qualità necessaria della so- cialità nel senso che una socialità ingiusta non è umana.
Ad esempio l’indirizzo della socialità, perché l’uomo si diriga in un compimento di sé che cor- risponda al suo bene autentico, non è il fatto di avere una certa relazionalità ma le modalità con cui questa relazionalità si esplicita e prende forma. Il soggetto non potrà vivere umanamente le dimensioni della socialità se queste avverranno attraverso modalità che, per esempio, implicano il prevaricare o il non dare quello che è dovuto agli altri. La socialità che porta alla felicità si re- alizza attraverso la giustizia.
Nel mio lavoro ho ridetto questa prospettiva classica – in particolare – attraverso la categoria dei “beni del benessere” che solo attraverso l’ar- ricchimento delle virtù possono condurre alla fe- licità. Un bene del benessere importante per l’uomo, cioè un bene “basilare”, è la dimensione sociale tuttavia una pienezza di questo bene avviene solo nell’azione della giustizia in esso.
2. Giustizia come virtù
L’ oggetto materiale della giustizia riguarda il bene dell’altro nell’ambito del processo intenzione, scelta e decisione che conducono all’azione giusta. Si comprendono meglio queste affermazioni ri- cordando come le virtù trasformano le facoltà op- erative del soggetto. La giustizia agisce sulla volontà.2 Quest’ultima, in modo spontaneo, aspira ad un bene che riguarda direttamente il soggetto.3 Non accade allo stesso modo per il volere “qualcosa” per l’altro. La giustizia è la virtù che rettifica il nostro relazionarsi con gli altri e compie quest’op- erazione agendo sulla volontà del soggetto. Essendo una disposizione permanente permette che l’indi- rizzarsi all’altro avvenga con una certa spontaneità e facilità.
3. Criteri di razionalità
Ho individuato dei criteri – principi – di gius- tizia che innanzitutto oggettivano questa virtù, identificano la sua presenza o la sua mancanza: nello specifico significa delineare delle “massime” di giustizia.
Come vengono definiti i criteri di razionalità che indirizzano la giustizia? L’analisi dei principi inizia dal primo principio della razionalità che conduce all’agire o detto altrimenti primo principio della ragion pratica. Da esso si possono elaborare altri principi – criteri o massime – che sono le determinanti delle singole virtù. Le massime sembrerebbero essere simili alle norme esteriori o regole di comportamento. Sono invece differenti perché sono anche gli scopi delle virtù: la giustizia in questo senso viene orientata da due principi razionali che le fanno da guida. La volontà diventa retta nella giustizia, secondo la razionalità dei principi, ampliando la prospettiva di bene che persegue fino al bene dell’altro. Nel soggetto le massime di giustizia corrispondono alle inten- zioni generali – scopi – che il medesimo si prefigge nel processo che prosegue nelle scelte e che sfocia nell’azione.
Essi sono: il principio di non maleficenza ed il principio di equità.Il primo può essere formulato nei termini seguenti: si constata dall’accadere di certe azioni che sono sempre una violazione dello stesso.
Il principio di non maleficenza non è solo una regola razionale che a priori appartiene alla capacità intellegibile del soggetto.4 Si riesce ad individuare come nucleo o contenuto formale da quelle azioni che se compiute sono sempre controil bene. Il principio permette di constatare la pre- senza della giustizia: “non fare del male all’al- tro”.
Un secondo principio è quello dell’uguaglianza. Esso può essere definito come “dare o rendere a ciascuno il suo dovuto”.5 Il principio di eguaglianza sintetizza la necessità della giustizia per la vita sociale. Ricordo che il principio ha un carattere formale.
Le sue caratteristiche si possono riassumere in quattro specificazioni: a) Il bene che la giustizia crea riguarda il dovuto e non l’eccedente; b) il dovuto è in relazione al bene proprio del soggetto;c) Il principio di eguaglianza non è la “regola d’oro”; d) la medietà della giustizia, espressa dal principio, è guidata da aspetti di imparzialità che non dipendono dalle qualità dei soggetti che in- tendono essere giusti.
4. Il valore dei principi di giustizia
Perché è stato così importante determinare dei principi di giustizia?
Il riconoscimento dei medesimi ha contribuito alla comprensione della stessa nel legame con il soggetto, ma in una valenza non soggettivistica, rispetto alla proposta morale. La virtù di giustizia da un lato trasforma la volontà del soggetto e dall’altro risponde a dei criteri che conducono alle eccellenze virtuose – le azioni eccellenti – che scaturiscono dalle intenzioni giuste del soggetto stesso.
5. Pluralità delle azioni di giustizia e ne- cessità di acquisizione della virtù
Dai principi di giustizia scaturisce l’individu- azione dell’insieme delle azioni giuste. Queste ultime tuttavia non sono omogenee in un senso universale. Esse presentano una pluralità di espres- sioni che deriva in parte dal fatto che la giustizia si identifica con una serie di modelli di azioni – azioni paradigmatiche – che la esprimono. Queste azioni dipendono anche da come vengono elaborate e colte dall’ambiente in cui sono riconosciute come azioni giuste all’interno di una tradizione etica.
6. Virtù di giustizia e decalogo
Infine c’è un ultimo argomento che ho discusso nel testo e che qui accenno: i principi, sempre at- traverso la categoria della legge naturale, consentono di discutere l’affinità tra giustizia ed i precetti del decalogo. Questi ultimi appartengono alla sferadella giustizia perché i principi di eguaglianza e non maleficenza valgono per entrambi.
Tradizioni e giustizia
1. La giustizia e le tradizioni
I principi di giustizia e l’inclinazione alla so- cialità necessitano di una modalità concreta di espressione che viene dettata dalla tradizione in cui prende forma la virtù di giustizia.Esiste però una tesi che è più radicale. Essa afferma che non esiste un’etica che non sia qual- ificata: non è possibile individuare alcuna virtù di giustizia generale ma solo virtù diverse che sono specificate da tradizioni diverse. Il mio lavoro ha voluto confrontarsi con questa tesi rifiutandola. Ho invece pienamente accolto il fatto che alcuni contenuti, e specificazioni pratiche della giustizia, possano essere diverse a seconda delle tradizioni e come queste ultime siano nec- essarie per la formazione delle virtù che si radicano sempre in una storia ed in una comunità.
2. Tradizione cristiana di giustizia
Il concetto di tradizione permette di analizzare come si caratterizza e quali contenuti possiede la virtù di giustizia in senso cristiano:a) la tradizione cristiana di giustizia vive del- l’ideale della fede; b) non esiste giustizia cristiana senza che la comunità cristiana sostenga ed incarni questa virtù.
3. Tradizione cattolica di giustizia
È possibile definire una tradizione cattolica di giustizia e quali caratteristiche la contraddis- tinguono? In particolare quest’analisi ha com- portato il recupero del pensiero sociale cristianonella forma della dottrina sociale della Chiesa secondo il concetto di tradizione utilizzato in precedenza.
La richiesta di eguaglianza espressa dalla giustizia deriva, nella tradizione sociale cattolica, dalle esigenze dell’amore cristiano.
La tradizione sociale cattolica ha elaborato una divisione della giustizia in tre specificazionidiverse: giustizia commutativa, distributiva e so- ciale.6 Queste tre differenziazioni sono espressioni della reciprocità e dell’uguaglianza appena ricordate.
4. Rivisitando le radici della tradizione sociale: le radici tommasiane della tradizione cattolica di giustizia
Un argomento finale ha indagato le radici della tradizione sociale individuandole nella pro- posta tommasiana in merito alla giustizia.Per Tommaso la giustizia è detta anche generale in un altro senso: perché è una caratteristica di tutte le virtù. Queste essendo ordinate al bene creano comunque una dimensione giusta, gli atti singoli ricadono a favore di tuti i soggetti.
5. Tradizione cattolica di giustizia oltre la virtù?
La tradizione cattolica di giustizia, sia nell’e- spressione del pensiero sociale che nella sua radice tommasiana di giustizia generale, in fondo ha mostrato una prospettiva in parte diversa sulla giustizia che sembra complementare all’osservare la giustizia come virtù.
In realtà questa differenza è più sfumata: la giustizia generale infatti è determinata da due componenti che appartengono anche alla giustizia come virtù o particolare.
La prima è il principio di eguaglianza. La giustizia distributiva e sociale richiamano delle istanze di reciprocità che si esprimono nel principio di eguaglianza. La seconda componente è la socialità. Tutto il discorso sul bene comune tutelato dalla giustizia generale non è solo un discorso funzionalistico, che serve per permettere e miglio- rare la convivenza sociale, ma riguarda la realiz- zazione della socialità come costante antropologica dei soggetti.
Virtù infusa di Giustizia
1. Grazia
È possibile affermare che lo studio delle virtù si compone di tre elementi: la natura personale del soggetto, l’apporto che proviene dall’ambiente, ciò che deriva dalla prospettiva teologica. Ho anal- izzato il contributo teologale riguardante la giustizia spiegandolo attraverso l’azione della grazia – della conseguente carità – sulla virtù stessa.
Come noto la prospettiva morale di Tommaso è strettamente legata all’azione della grazia. Solo con la presenza di quest’ultima il soggetto può giungere al fine ultimo beatificante: cioè Diostesso. Ma anche il fine imperfetto naturale necessita di un compimento attraverso il dono di grazia.
2. Azione delle virtù infuse
Come agisce la grazia abituale nel soggetto? Il concetto di virtù infuse permette di delineare questa azione.7
Il fatto di aver evidenziato che per stabilizzarsi nella vita virtuosa, per cioè raggiungere una beat- itudine imperfetta ma che abbia la possibilità teorica di essere raggiunta, il soggetto necessitasse della grazia si concretizza ora nell’azione delle virtù infuse.
L’azione della grazia attraverso le virtù non è solo un passaggio formale o nominale: significa ricordare l’importanza del soggetto perché le virtù, anche infuse, sono sempre trasformazioni che riguardano le sue dimensioni antropologiche ed in particolare trasformazioni delle facoltà op- erative. In particolare la carità – generata dalla grazia – è inerente la volontà anche attraverso la giustizia infusa.
La questione centrale è stata di tentare di definire l’apporto della carità in merito alla gius- tizia, il precisarne il legame profondo. Per rendere esplicita l’influenza della carità verso la giustizia ho analizzato le “proprietà” della carità ed ho cercato, attraverso di esse, di comprendere la trasformazione della giustizia come virtù infusa. In sintesi la dinamica delle virtù infuse è: Grazia→ carità→ giustizia.
3. Giustizia e carità
Le virtù infuse propongano solamente un cambiamento di fine rispetto a quelle acquisite, una modificazione nelle intenzioni ultime del soggetto agente attraverso l’orientamento a Dio, oppure si tratta di un cambiamento dei principi operativi e dunque delle modalità in cui si realizza il bene dato dal loro potenziale? La soluzione è ancora una volta duplice.
Da un lato la carità dirige il soggetto all’unione con Dio. L’indirizzo delle intenzionalità virtuose nei confronti del fine ultimo è la classica affer- mazione che la carità è forma di tutte le virtù e dunque anche della giustizia.8
Dall’altro – la carità – trasforma le virtù ed in particolare la giustizia infusa. Il fine ultimo è sempre compatibile con una serie di fini intermedi.
L’individuazione di principi razionali, che definiscono la carità, ha permesso di comprenderepiù analiticamente la modalità attraverso cui la carità trasforma i fini della giustizia. Detto altri- menti, con il concetto delle inclinazioni, la giustizia infusa indirizza la socialità ma nelle modalità arricchite dall’amore del prossimo.
4. Giustizia infusa
Ho usato una duplice definizione per la relazione tra carità e giustizia.
La prima è la carità “nella” giustizia: la virtù infusa di giustizia. La seconda è la carità “at- traverso” la giustizia che spiego in seguito.
La carità nella giustizia si sintetizza in due principi: quello di benevolenza e di gratuità.9
a) La benevolenza può essere affermata con la massima “volere il bene proprio dell’altro”. In fondo il senso positivo del principio di non malef- icenza. Alla benevolenza si aggiunge anche il legame affettivo verso l’amato: un volere un’unione con la persona amata.
La giustizia infusa sarà dunque indirizzata dalla benevolenza e da un’unione più profonda con il prossimo.
b) Un secondo principio è quello di gratuità. Esso nasce dalle eccellenze virtuose che Tommaso indica come espressioni della carità, la beneficenza in particolare. Il principio sottolinea uno dei modi con cui sono state comprese le virtù in questa tesi: esse sono anche sempre una serie di eccellenze virtuose che si possono individuare in azioni specifiche. Ugualmente il principio del supererogatorio o di gratuità può essere rappre- sentato con una massima: “dare all’altro non solo quello che gli è dovuto, ma quello che ne- cessita per il bene autentico e che non si può pre- tendere”. Sono le situazioni in particolare re- lazionali e quelle del campo economico dove è possibile individuare l’azione del principio di gratuità.
Infine la giustizia infusa si arricchisce del- l’aspetto propriamente teologico:
- l’amore per gli altri nasce dalla partecipazione comune all’amore di Dio;
- l’amore con il quale Dio ama è modello per l’amore umano che si intensifica.
Rimane ancora un’ultima precisazione, che cosa rimane della virtù di giustizia acquisita? E’ la seconda delle definizioni richiamate in prece- denza: la carità attraverso la giustizia. Significa che è possibile individuare un aspetto della carità che si esprime attraverso la giustizia. In una serie di relazioni, in un certo dominio – in parti- colare con i più vicini – la carità necessita semprela presenza della giustizia. Non c’è carità a pre- scindere dalle realizzazioni giuste.
5. Prospettive sintetiche
In uno sguardo di sintesi, a partire dalla prospettiva tommasiana seguita, metto in evidenza tre temi che, insieme, danno una prospettiva complessiva sulla virtù di giustizia in senso cris- tiano:
- la giustizia come virtù in se stessa nell’ambito della legge naturale;
- la tradizione cristiana nella quale si declina la giustizia;
- i doni della grazia e della carità, nella tradizione cristiana, che conducono alla presenza della virtù infusa di giustizia.
Questi passaggi hanno permesso, con gli ar- gomenti portati nel lavoro analitico compiuto, di sottolineare una necessità della virtù di giustizia per la realizzazione umana e cristiana del soggetto. La virtù di giustizia permette di giungere ad una pienezza umana e cristiana.
NOTE
1 A. SACCO, La Giustizia come Virtù, Effatà Editrice, Cantalupa (Torino) 2017.
2 Cfr. S Th II II 58.
3 Non significa che questo bene sia autentico. Sarà la razionalità che constata come la volontà di un bene si indirizza alla vita buona.
4 Cfr. S Th I II 100,5.
5 Cfr. S Th II II 57, 1; S Th II II 58,1.
6 Commutativa è il dovuto tra le parti, distributiva riguarda i beni collettivi che devono essere redistribuiti nella società, sociale è l’interesse dei singoli verso la collettività sociale ed anche il fatto che i singoli e le entità intermedie si possano essere parti costitutive della struttura sociale.
7 Cfr. S Th I II 55,4.
8 Cfr. S Th II II 23,8.
9 Cfr. S Th II II 27,2.
 IT
IT  EN
EN 












