

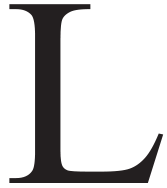 e epidemie sono come le guerre: periodicamente ritornano e tutti cercano di dimenticarle il più presto possibile.
e epidemie sono come le guerre: periodicamente ritornano e tutti cercano di dimenticarle il più presto possibile.
La epidemia detta spagnola la ricordava mia madre, allegramente, e mio padre, con amarezza. Entrambi nati nel 1910, lei aveva ricordi gioiosi di quando, ammalata in realtà di tifo, giocava con le sorelle sui letti di casa, lui di quando con suo padre erano andati a prendere la cassa da morto per la nonna Giovanna nel 1918.
Mia nonna Carolina, nata in Lombardia (Nord Italia) nel 1871, raccontava storie terrificanti delle ultime epidemie di colera e di difterite nel XIX secolo. Come quella del padre che sulla porta di casa si opponeva furiosamente, con la scure in mano, al trasferimento della propria figlia morente al lazzaretto.
L’edificio dove era attiva la falegnameria delle casse mortuarie è stato abbattuto solo pochi anni fa, ed il fatto, unito a quello della morte di mio padre con il suo ricordo, mi ha dato il senso realistico del passare degli anni, delle generazioni umane e dell’oblio dei dolori passati.
Non a caso per gli italiani tutti la peste bubbonica del 1630 narrata nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e quella nera del 1348 nel Decamerone di Giovanni Boccaccio, sono quasi ricordi di famiglia. Racconti mitici che, una volta demitizzati e depotenziati, sono diventati ricordi come quelli di avi scavezzacollo eppure cari.
Attualmente, nel turbine dell’evento, noi non possiamo invece né dimenticare né depotenziare il nostro Coronavirus. Ce lo dicono gli esperti virologi ed epidemiologi, e lo ribadiscono i politici.
I governanti però stanno programmando la Fase 2. Sia dal punto di vista medico che da quello economico. A differenza del passato le nostre infrastrutture tecnico-scientifiche pare che impediranno di arrivare a decine di milioni di morti delle “vecchie” pandemie, ma la nostra società globalizzata si regge sull’economia globalizzata e questa è a grave rischio di recessione.
Cosa questo significhi, lo cogliamo tutti, ma non dimentichiamo che questa certa recessione colpirà profondamente i paesi più deboli e i ceti più demuniti di qualsiasi Paese.
Nel fascicolo di febbraio 2020 avevamo proposto tre contributi sulla Agricoltura familiare, ed anche questa volta possiamo offrire due contributi sull’argomento. Quello panoramico di A. Crosthwaite sulla situazione negli Usa e quello di I. R. Marcano sull’Agricoltura Familiare in Mozambico. Il primo è proposto da un docente noto ai lettori di OIKONOMIA, mentre il secondo è parte (Cap. IV) di una buona tesi di dottorato in Scienze Sociali presentata lo scorso anno accademico e diretta dal nostro docente C. Colombi. Merita di essere presa in considerazione perché tratta di un aspetto dell’economia, e sociologia, africana della massima importanza. L’agricoltura famigliare può in effetti essere un ottimo mezzo per arrivare a sviluppi industriali e post-industriali senza distruggere le strutture sociali e senza le esperienze catastrofiche dell’inurbamento negli slum cui stiamo assistendo negli ultimi decenni. Per evitare di riprodurre molte pagine, si è rinunciato alle indicazioni bibliografiche di riferimento. Non ci sembra che questa danneggi eccessivamente la comprensione del testo, che resta comunque un invito a leggere il testo completo.
Gli altri contributi.
Innanzi tutto quello del nostro Docente I.V. Szaniszló sullo stato vegetativo persistente. La trattazione è significativa sia per l’argomento trattato, evidentemente di grande attualità, sia per le implicazioni di morale generale che esso sottende. Come anche come modello per la soluzione di conflitti simili nelle nostre società pluralistiche.
I. Danyliuk ha discusso in settembre 2015 con il Professor G. Casale, la sua tesi di Licenza in Scienze Sociali: Prospettive di implementazione del principio di sussidiarietà nella cultura dell’Ucraina, ed ora ci invia dall’Ucraina uno studio sul ruolo diplomatico della S. Sede nella risoluzione della crisi missilistica di Cuba del 1962.
I.M. Morariu, monaco ortodosso rumeno, ci offre una breve presentazione del documento ufficiale sulla dottrina sociale del Patriarcato di Mosca.
Nella pagina dedicata alle Recensioni abbiamo un’ampia presentazione critica del volume dei sociologi Giaccardi e Magatti, che in Italia ha fatto e fa discutere. Riguarda di fatto la presenza politica dei cattolici oggi. L’autore, il filosofo domenicano bolognese, Giovanni Bertuzzzi, è personalmente impegnato in questo processo.
Infine la rubrica Pagina Classica ci presenta un simpatico promotore della impresa agricola familiare di altri tempi, B. Franklin. Tempi, i suoi, lontani da noi ma che sono alla radice dei nostri. Il che ci fa pensare che nel crescere il nostro albero della modernità e post-modernità potrebbe aver perso qualche cosa di essenziale per la realizzazione della propria umanità.
Francesco Compagnoni
 IT
IT  EN
EN 











