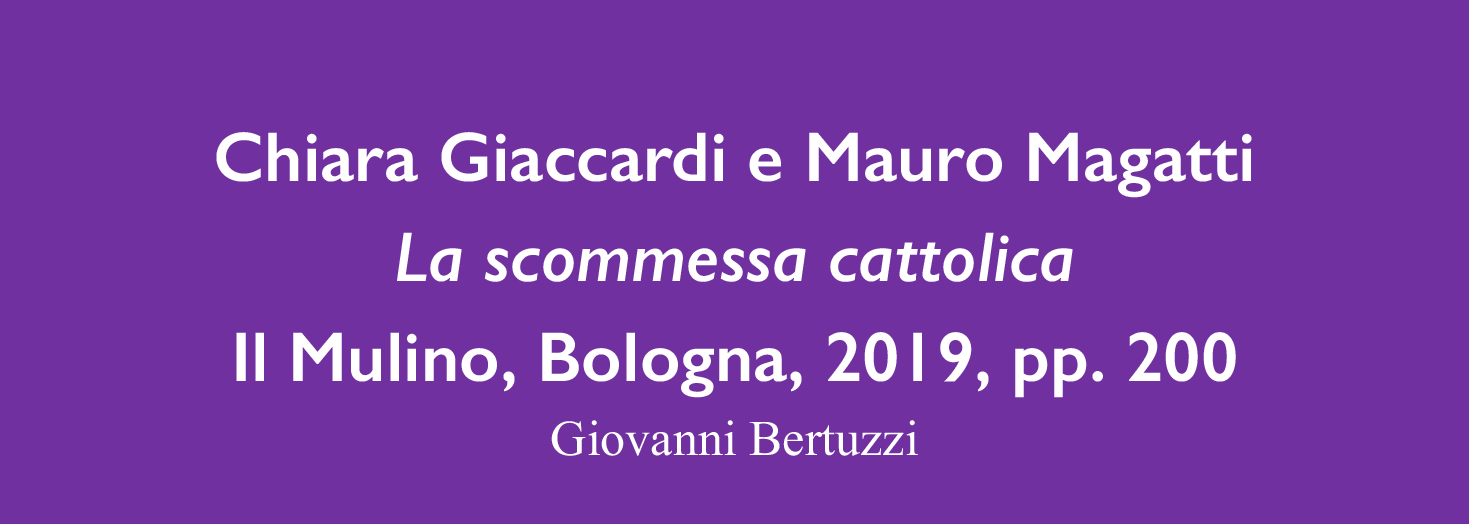
![]() l libro “La scommessa cattolica” dei due sociologi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti vuole rispondere alla seguente domanda di fondo: “c'è ancora spazio per la buona novella cristiana nel mondo di oggi?”. Di conseguenza, l’intento dei due autori è quello di ricercare le vie per un possibile riavvicinamento tra il cristianesimo (e la Chiesa cattolica in particolare) e modernità.
l libro “La scommessa cattolica” dei due sociologi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti vuole rispondere alla seguente domanda di fondo: “c'è ancora spazio per la buona novella cristiana nel mondo di oggi?”. Di conseguenza, l’intento dei due autori è quello di ricercare le vie per un possibile riavvicinamento tra il cristianesimo (e la Chiesa cattolica in particolare) e modernità.
Tale confronto viene impostato nel prologo sui seguenti tre pilastri:
- q
 uello dell’onnipotenza, che consiste nella rivelazione paradossale e scandalosa di un Dio che manifesta la sua “potenza”, incarnandosi in un bambino e facendosi appendere a una croce;
uello dell’onnipotenza, che consiste nella rivelazione paradossale e scandalosa di un Dio che manifesta la sua “potenza”, incarnandosi in un bambino e facendosi appendere a una croce; - quello della salvezza, che presenta le seguenti posizioni contrapposte e alternative: quella tra vita nell'al di là o successo mondano, tra salvezza dell'anima o benessere materiale, tra una salvezza che provenga dalle mani di Dio o dalla tecnica umana che promette addirittura l'immortalità;
- il terzo pilastro, infine, è quello dell’universalità, che mette a confronto l’universalità della ragione morale con quella tecnologico-strumentale della globalizzazione attuale.
Sulla base di questi tre pilastri ci sembra di poter distinguere nel contenuto del libro le seguenti parti:
- nel primo capitolo, intitolato: “Un nuovo crocevia storico”, viene impostato il rapporto tra modernità, fede e secolarizzazione, mettendo in evidenza l’esito secolaristico della modernizzazione e nello stesso tempo i fallimenti e le ambiguità a cui tale esito è andato e va incontro;
- nel secondo capitolo (“Perché continuiamo ad aver bisogno del paradosso cristiano”) vengono poste le basi per un superamento della contrapposizione tra salvezza cristiana e salvezza tecnico-secolaristica;
- il terzo capitolo (“Con gli scarti aperti al mistero”) affronta il problema del corretto esercizio del potere nella Chiesa, in attesa di un’autorità generativa;
- il quarto capitolo, infine, (“La questione dell’universalismo all’epoca della globalizzazione”) ripropone l’universalismo cattolico contro il monopolio della potenza tecnologica.
I fenomeni esaminati all’interno di questi capitoli e i problemi in essi affrontati sono quanto mai variegati e complessi.
Ora, chiediamoci, come viene impostato questo confronto tra il messaggio evangelico e la cultura attuale, ma, soprattutto, come viene ricercata e individuata la via del riavvicinamento della Chiesa alla modernità? Ci sembra di poter riconoscere, a tale proposito, i seguenti due punti di riferimento principali, che spiegano come gli autori del libro affrontano e risolvono i problemi in questione.
In primo luogo, l’analisi dei diversi fenomeni economici, politici, religiosi e sociali viene compiuta, ricorrendo soprattutto alla dottrina filosofica di Romano Guardini, alla sua teoria del concreto vivente e a quella dell’opposizione polare.
In secondo luogo la rivisitazione del rapporto tra Dio e l’uomo nella modernità, si ispira soprattutto alla parabola evangelica del Figliol prodigo, dove il padre si relaziona con il Figlio, rispettando la sua libertà e attendendo il suo ritorno a casa. Nel figliol prodigo viene identificata la modernità e la sua secolarizzazione; nel padre viene rappresentata la volontà del Padre celeste che rispettare la libertà del figlio e attende il suo ritorno.
Lo strumento teoretico scelto dagli autori per impostare i problemi suddetti è rappresentato, come abbiamo detto, dalla filosofia di Romano Guardini, così come viene espresso in particolare nella sua opera: “L’opposizione polare. Saggio per una filosofia del concreto vivente”.1 Da questo saggio viene tratta ispirazione per considerare i fenomeni relativi alla Chiesa e al mondo, non in modo astratto e frammentario, ma in modo concreto e contemporaneamente sistematico. Viene così ripresa la teoria guardiniana delle opposizioni polari, per mettere a confronto i diversi aspetti della vita della Chiesa e della modernità, che appaiono in contrapposizione o, come viene specificato, in tensione tra loro. Il presupposto guardiniano da cui si vuole partire è “l’uomo concreto, vivente e capace di coltivare e custodire i legami con gli altri, con il mondo e con il mistero che ci abita”.2 Questo corpo vivente, che non riguarda solo la singola persona, ma anche istituzioni umane come la stessa Chiesa, è caratterizzato da queste opposizioni polari che vanno interpretate non in base a contrapposizioni isolate astrattamente e separate tra loro, ma come distinzioni tra elementi che sono vicendevolmente in relazione e “in tensione” reciproca. Gli autori prendono in esame, in particolare, nove tensioni che chiedono di essere ripensate e risolte (cfr. pp. 85-103). E la prima tensione è proprio quella tra l’astrazione e la (con)fusione,3 tra la razionalistica tendenza a separare e contrapporre tra loro le diverse idee e la tendenza opposta a fondere e confondere l’altro in una indistinta fusione. Questi due elementi opposti sono entrambi incapaci di esprimere nella loro separatezza la realtà concreta, e vanno risolte nella concretezza della vita quotidiana, dove occorre compiere un lavoro “appassionato e intelligente, per tenere insieme i diversi piani e le diverse sfere della vita, riconoscendone l’intimo legame, in un dinamismo che permetta di vivere realizzando sé stessi insieme agli altri e a ciò che ci circonda”.4
La presentazione di queste tensioni ha la funzione di mostrare due elementi di vita contrapposti, che vengono superati e risolti non in una semplice sintesi dialettica, ma in un confronto che rimane aperto e che permette quello che viene chiamata una “eccedenza”, vale a dire un’esperienza viva di ciò che è al di là della norma, al di là della rigidezza delle istituzioni e delle strutture gerarchiche, senza cadere negli eccessi di vuote fughe in avanti. La settima tensione (cfr. pp.97-98) parla proprio dell’eccedenza come superamento della “norma e dell’eccesso” e lo applica al cristianesimo e alla Chiesa in questi termini: “il cristianesimo è l’esperienza del desiderio di Dio. Un’esperienza dell’eccedenza e non della regola e della misura. E la Chiesa, come la comunità di coloro che condividono l’esperienza della fede, è la levatrice di quel desiderio che per definizione non si può esaurire né irrigidire in schemi fissi da replicare”.5
Su questa impostazione i due autori affrontano i problemi culturali, religiosi e sociali che riguardano la Chiesa e il mondo contemporaneo: il tema dell’individualismo soggettivista che ha prodotto specialisti senza spirito e gaudenti senza cuore, quello del capitalismo che ha perduto le sue origini cristiane, quello della globalizzazione che si sta sviluppando senza limiti, senza controlli e senza un vero senso che lo regoli e l’orienti, e infine quello del transumanesimo tecnologico che si impone massimizzando le società, senza rispettare la libertà individuale delle persone. Tutti questi fenomeni e queste fughe in avanti son state causate, a giudizio dei due autori, dal modo astratto di affrontare i problemi, di separare e contrapporre gli elementi che hanno dato origine alla società moderna e alle culture, quella laica e quella cristiane, che la compongono.
Quali strade occorre percorrere per risolvere questi problemi, in particolari quelli relativi ai tre pilastri dai quali i due autori sono partiti: l’onnipotenza, la salvezza e l’universalità. Il capitolo terzo, che propone la realizzazione di una Chiesa “con gli scarti, aperta al mistero” (cfr. pp.111-151), affronta prima di tutto la perenne questione dei rapporti tra politica e religione e suggerisce di cercare “un nuovo equilibrio che, nel salvaguardare il pluralismo della sfera pubblica, riconosca altresì il valore e l’importanza della religione come fatto sociale e culturale collettivo”.6 Questo equilibrio non può essere ricercato riproponendo semplicemente modelli passati, ma affrontando la realtà presente e aprendosi al futuro, trasformandosi da Chiesa istituzione a Chiesa istituente (cfr. pp. 114-120). Ma riguardo al tema dell’onnipotenza la Chiesa deve affrontare, al di là del confronto con la sfera politica, quello con un’altra forza, ben più potente, che contende con lei il primato nel gestire la vita e la morte dell’uomo e nel risolvere i problemi della sua esistenza; questa potenza è quella della tecnocrazia. La tecnologia oggi promette di superare tutti i limiti che vengono posti alla natura umana, quei limiti che in passato venivano affrontati con la fede religiosa. Ma la condizione tecnologica pone l’uomo di fronte a due prospettive: quella della transumanità e quella della disumanità. Come può l’uomo superare sé stesso senza cadere nella disumanizzazione? La cultura dominante sostiene che i limiti umani potranno essere indefinitamente e immancabilmente risolti, ma intanto permangono o aumentano le condizioni di precarietà, di marginalità, di povertà, e gli “scarti” di questa società globalizzata e tecnologizzata. Ciò che viene sottratto a questo uomo “precario” è lo spazio della “prece” (cfr. p. 134), della preghiera e del mistero che solo la fede religiosa gli può restituire. All’idea del progresso tecnologico, incentrata sulla soggettività umana, va dunque affiancata quella di una salvezza che proviene da Dio, e che rende consapevole l’uomo della sua realtà nei confronti della natura, di Dio e degli altri uomini, e da questo confronto può nascere e svilupparsi uno spazio nuovo per la ragione, quella che Papa Benedetto XVI chiamava una ragione “allargata”, allargata rispetto a quella astratta della scolastica medioevale e della scienza matematica moderna, madre della tecnologia e dell’industrializzazione attuale. Questa ragione non si basa unicamente sull’intelligenza, ma si alimenta delle ragioni del cuore e delle relazioni vive e affettive con gli altri, sui sentimenti di compassione e di misericordia, come sta mettendo in luce Papa Francesco. È interessante che, per proporre l’incontro tra la Chiesa e la modernità, i due autori facciano riferimento a Papa Ratzinger e a Papa Bergoglio e alla continuità dei loro pontificati (cfr. pp.120-123). L’insegnamento di questi due pontefici viene proposto come esempio di realizzazione di quella “eccedenza”, che può aprire la strada per un incontro tra la tradizione della Chiesa e la modernità.
Così pure, per quanto riguarda la relazione tra la religione cristiana e l’universalità, la Chiesa deve confrontarsi con il mondo moderno, globalizzato ed emancipato, che rivendica la propria autonomia come il figliol prodigo della parabola evangelica. Anche in questo caso la Chiesa deve aprirsi al confronto con il pluralismo religioso, politico e culturale in cui viviamo, non per aspirare ad un monopolio teocratico, come è avvenuto nel passato, in nome dell’onnipotenza di Dio, ma per mettersi al servizio dell’uomo nel rispetto della sua libertà: “L’onnipotenza di Dio si mostra, infatti, per la prima volta nella storia delle religioni, nella forma della debolezza, del servizio, della misericordia, del sacrificio. Il Dio cristiano non travalica la libertà della sua creatura. È l’atteggiamento di un Padre nei confronti di ogni figlio: che non lo incatena, che lo lascia andare anche se non è d’accordo. Il Dio evangelico della misericordia è la forma “deponente” della onnipotenza di Dio, eccedenza non tirannica che non schiaccia ma solleva”.7
Queste parole riassumono molto bene lo spirito con il quale i due autori hanno condotto questa complessa analisi sulla Chiesa nel mondo moderno e con il quale indicano la strada che, a loro avviso, va seguita, affinché il cristianesimo possa riaffermare la propria identità evangelica nell’epoca in cui viviamo.
Giovanni Bertuzzi
NOTE
1 Romano Guardini, “L’opposizione polare. Saggio per una filosofia del concreto vivente”, Morcelliana, Brescia, 1997. Guardini distingue, a proposito del concreto vivente le opposizioni categoriali (pp.33-79) dalle opposizioni trascendentali (pp.79-88). All’interno delle opposizioni categoriali egli distingue una opposizione intraempirica da un'opposizione transempirica. Nella opposizione intraempirica individua: a) l'opposizione tra vita e stato (vita e struttura, vita e solidità, pp.38-42); b) opposizione tra forma e forza formatrice, pp.43-48, c) il singolo e il tutto, pp. 48-56. Nell'opposizione transempirica si distinguono a) produzione- disposizione. b) originarietà-regola, c) immanenza o in abitazione-sovrastare. L'opposizione trascendentale presenta a) affinità e particolarizzazione, b) unità e molteplicità, c) articolazione e contesto.
2 Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, op.cit. p.23.
3 Op. cit., pp.85-88. Le tensioni qui esaminate e risolte sono le nove seguenti:
astrazione e (con)fusione tramite la concretezza;
sacro e religione tramite la fede;
libertà e controllo tramite l'affezione;
gerarchia e anarchia tramite la rete;
perfezione e lassismo tramite l'incarnazione;
istituzione e massa tramite il popolo;
norma ed eccesso tramite l'eccedenza;
intransigenza e indifferenza tramite la tenerezza;
immortalità e morte tramite la vita.
4 Op, cit. p.86.
5 Op. cit. p.98.
6 Op. cit., p.114.
7 Op. p. 177.
 IT
IT  EN
EN 











