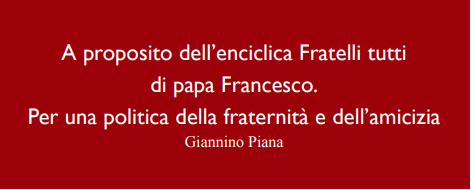![]() L’enciclica «Fratelli tutti. Sulla fraternità e l’amore sociale» di papa Francesco non è un documento di facile lettura. Si tratta di un testo complesso il cui impianto non appare, ad un primo accostamento, del tutto organico. La riflessione che il pontefice offre all’attenzione non solo di «tutti i fratelli e le sorelle» ma anche di «tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose», si sviluppa attraverso un percorso non lineare ma circolare — non è questo del resto il significato etimologico di «enciclica»? — anzi più propriamente «a spirale», nel senso che le tematiche esposte vengono di continuo riprese — il che comporta necessariamente qualche inevitabile ripetizione — dando vita a progressivi approfondimenti che mettono a fuoco sempre nuove prospettive.
L’enciclica «Fratelli tutti. Sulla fraternità e l’amore sociale» di papa Francesco non è un documento di facile lettura. Si tratta di un testo complesso il cui impianto non appare, ad un primo accostamento, del tutto organico. La riflessione che il pontefice offre all’attenzione non solo di «tutti i fratelli e le sorelle» ma anche di «tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose», si sviluppa attraverso un percorso non lineare ma circolare — non è questo del resto il significato etimologico di «enciclica»? — anzi più propriamente «a spirale», nel senso che le tematiche esposte vengono di continuo riprese — il che comporta necessariamente qualche inevitabile ripetizione — dando vita a progressivi approfondimenti che mettono a fuoco sempre nuove prospettive.
Il tema dominante dell’enciclica, che si inscrive all’interno dell’attuale contesto sociale contrassegnato da processi di interconnessione e di interdipendenza dovuti allo sviluppo della globalizzazione — la pandemia ha reso trasparente in maniera efficace questa situazione — è il tema della fraternità universale e dell’amicizia sociale, due modalità diverse e complementari di vivere la carità. La prima — la fraternità universale — riguarda il vincolo che ci unisce come fratelli all’intera umanità e ci rende responsabili del destino di tutti gli uomini; la seconda — l’amicizia sociale — ha come oggetto le persone con cui si è direttamente in contatto e con le quali si sviluppano relazioni immediate nei vari ambiti della vita associata.
Queste rapide note si propongono di far emergere le strutture portanti dell’enciclica papale, percorrendone alcune fasi salienti. Si partirà dall’analisi socioculturale della situazione (1), per cogliere gli aspetti antropologico-etici e l’orizzonte teologico (2), fermando successivamente l’attenzione sulla questione politica (3), per concludere con alcune rapide osservazioni sul ruolo delle religioni, e in particolare della chiesa cattolica (4).
1. Gli ostacoli odierni ai valori in gioco
Papa Francesco introduce la riflessione con una serie di spunti di analisi sulla situazione attuale, denunciando gli ostacoli che si oppongono al riconoscimento della fraternità universale e dell’amicizia sociale. Si tratta di una lunga rassegna di fenomeni che — come l’enciclica afferma — costituiscono veri segni di un «ritorno all’indietro» (n. 11): dai nazionalismi chiusi ed esasperati ai populismi demagogici e di pura propaganda (su questi si tornerà nel capitolo dedicato alla politica); dalle nuove forme di xenofobia e di razzismo al mancato riconoscimento dei diritti umani; dalle crescenti diseguaglianze sociali tra i popoli e le classi sociali alle derive della comunicazione digitale che provocano dipendenza e isolamento; e, infine, dalla presenza di conflitti anacronistici — lo scenario delle guerre tende ogni giorno a dilatarsi — alla colonizzazione culturale delle aree geografiche più povere (nn. 11–14).
Ma, al di là dei gravi fenomeni denunciati, l’enciclica risale soprattutto alle radici culturali e socio-politiche, che sono alla base dell’affermarsi dei nuovi egoismi di massa e della perdita del senso sociale, mettendo l’accento su alcuni processi che hanno inciso (e incidono) sulle coscienze modificandole nel profondo. Sul primo versante — quello culturale — particolare attenzione è riservata alla perdita della coscienza storica (n. 13) da cui scaturisce una forma di decostruzionismo caratterizzato dall’assenza di riferimenti stabili ereditati dal passato; assenza che conduce allo svuotamento dei valori e all’impossibilità di elaborare progetti per il futuro (n. 15). E questo in un momento nel quale la stessa percezione del presente appare largamente illusoria, in quanto, grazie alle nuove tecnologie della comunicazione, siamo spinti a sostituire il «reale» con il «virtuale», perdendo il gusto e il sapore della realtà (nn. 42–43).
Sul secondo versante — quello socio-politico — la critica dell’enciclica si appunta anzitutto sull’incapacità del sistema economico capitalista di far fronte ai bisogni delle persone, soprattutto a quelli delle classi più povere, e sulla debolezza della politica asservita in larga misura ai poteri oggi egemoni, quelli dell’economia e dell’informazione. Il che alimenta, da un lato, pesanti forme di ingiustizia (n. 22); e trasforma, dall’altro, la politica da luogo di elaborazione di progetti a lungo termine in rincorsa dei bisogni immediati con l’attenzione privilegiata a quelli dei più forti e la mancata considerazione di quelli dei più deboli.
Le conseguenze di questi processi e di queste scelte sono ben note: si va dall’ampliamento dei confini della povertà — aumenta la ricchezza ma senza una vera equità distributiva — alla distruzione dell’ambiente, fino alla riduzione della persona umana ad oggetto. Ad avere, in definitiva, il sopravvento è una cultura dell’immediatezza e della ricerca degli interessi individuali che conduce a l'affievolirsi della tensione etica o al suo «deterioramento», la cui «cifra» più immediatamente trasparente è il rifiuto dei migranti (n. 29).
Papa Francesco non si limita tuttavia a denunciare gli ostacoli alla fraternità universale e all’amicizia sociale. Non manca di segnalare anche alcuni segni positivi. La pandemia in corso ha reso infatti evidente l’esigenza di un nuovo modo di vivere, improntato alla riscoperta del legame che abbiamo con gli altri. Il Covid-19 non ha smascherato soltanto le nostre false sicurezze denunciando la nostra vulnerabilità, ma ha messo anche in luce la nostra comune appartenenza, la consapevolezza che tutto è nel nostro mondo connesso e che nessuno si salva da solo (n. 32).
Si fa strada così il dovere dell’esercizio di una forma di corresponsabilità nei confronti dell’intera famiglia umana; mentre l’esperienza negativa del dolore, dell’incertezza e del timore «fa risuonare l’appello a ripensare i nostri stati di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza» (n. 33). E fa rinascere, anche nel cuore di una situazione difficile, la speranza, la quale — è papa Francesco a ricordarlo — «è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi ai grandi ideali che rendono la vita più bella e più dignitosa» (n. 55).
2. Le categorie antropologiche e l’orizzonte teologico
La prospettiva della proposta di papa Francesco è di carattere antropologico, con riferimento diretto al personalismo di matrice cristiana. La persona umana è un essere relazionale, il quale «non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri» (n. 87 ed è chiamata a trascendere sé stessa aprendosi agli altri.
 Tale apertura si fonda sul riconoscimento della dignità umana, la quale affonda le sue radici nel valore del proprio essere. «Il mondo esiste per tutti — rileva l’enciclica — perché tutti noi esseri umani nasciamo su questa terra con la stessa dignità. Le differenze di colore, religione, capacità, luogo di origine, luogo di residenza e tante altre non si possono anteporre o utilizzare per giustificare i privilegi di alcuni a scapito dei diritti di tutti» (n. 118).
Tale apertura si fonda sul riconoscimento della dignità umana, la quale affonda le sue radici nel valore del proprio essere. «Il mondo esiste per tutti — rileva l’enciclica — perché tutti noi esseri umani nasciamo su questa terra con la stessa dignità. Le differenze di colore, religione, capacità, luogo di origine, luogo di residenza e tante altre non si possono anteporre o utilizzare per giustificare i privilegi di alcuni a scapito dei diritti di tutti» (n. 118).
Fraternità universale e amicizia sociale hanno pertanto le loro basi in questo essenziale dato costitutivo. Da esso trae origine l’esigenza — affiora qui la dimensione etica — dell’esercizio della solidarietà, la quale non si riduce al compimento di alcuni atti di generosità sporadici, ma implica la lotta costante contro i meccanismi socio-economici ispirati ai soli criteri della libertà di mercato e l’impegno a valutare il proprio agire in rapporto al criterio del bene comune (n. 108).
La dimensione sociale — aggiunge poi giustamente l’enciclica — ha oggi una valenza universalistica. Ma l’universalità non deve essere interpretata come una omogeneizzazione che elimina le differenze e distrugge le peculiarità di ogni persona e di ogni popolo; va invece concepita come un’unità nella e della differenza. «La vera qualità dei diversi Paesi del mondo – scrive papa Francesco – si misura da questa capacità di pensare non solo come Paese, ma anche come famiglia umana, e questo si dimostra specialmente nei periodi di crisi» (n. 141).
Conseguenza di questi presupposti è, da un lato, il diritto di tutti a fruire dei beni della terra per la soddisfazione dei propri bisogni e, dall’altro, l’importanza della promozione dei diritti sociali oggi in particolare di quelli delle culture. Sul primo versante l’enciclica riprende gli insegnamenti dei papi precedenti, in particolare di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, mettendo l’accento sul principio della destinazione universale dei beni come principio dell’ordinamento etico-sociale e subordinando ad esso il diritto di proprietà, che va gestito con attenzione alla sua funzione sociale (nn. 118–120). Sul secondo il documento papale assegna ampio spazio ai diritti dei popoli e delle culture e sollecita la creazione di una nuova rete di relazioni internazionali (n. 126).
Il nodo critico che in proposito si propone come una vera sfida è la questione già accennata dell’accoglienza dei migranti che il papa affronta suggerendo l’adozione di alcuni atteggiamenti riconducibili a quattro verbi: «accogliere, proteggere, promuovere e integrare» (n. 129). Condizione per la messa in atto di questi orientamenti non è la rinuncia alla propria identità culturale e religiosa, ma il riconoscimento dell’importanza delle differenze che vanno valorizzate come espressione della ricchezza dello spirito umano, creando le premesse per l’attuazione di una «cittadinanza» basata sull’uguaglianza dei diritti e dando vita a politiche solidali con progetti capaci di favorire l’integrazione (nn. 130–131).
A complemento di queste motivazioni e come risposta alla domanda di senso ultimo, che non ci si può non porre, papa Francesco rinvia — facendo riferimento al carattere trascendente dell’esperienza umana nel mondo — alla parabola del buon samaritano, la quale conferisce ai concetti di fraternità e amicizia una effettiva concretezza. A venire contrapposti sono qui due comportamenti che riflettono due stili di vita: da un lato, l’indifferenza — quella del levita e del sacerdote — dall’altro, la prossimità — quella del samaritano.
L’etica del samaritano è l’etica della fraternità che crea le basi di una civiltà della prossimità, incentrata sulla «vittima» — come ricorda Luigino Bruni (cfr. Sempre dalla parte della vittima amando le umane diversità, «Avvenire», 6 ottobre 2020) — il cui contenuto fondamentale è la carità. Essa coincide con la ricerca senza condizioni del bene dell’altro, superando pregiudizi, interessi, barriere storiche e culturali. La vera fraternità va perciò oltre la vicinanza; comporta che ci facciamo vicini a coloro che sono in stato di difficoltà senza domandarci se fanno parte della nostra cerchia di appartenenza (capitolo secondo).
3. La politica come via privilegiata
Il terreno privilegiato per dare attuazione alla fraternità universale e all’amicizia sociale è per l’enciclica quello della politica. Il ricupero della centralità che va ad essa riconosciuta è legato al superamento di tre scogli: l’economia neocapitalista, il populismo e la tecnocrazia. Il primo — l’economia neoliberista — è dall’enciclica fatta oggetto di critiche severe. Il papa denuncia con forza i rischi dell’ideologia neoliberista: «Il mercato da solo — scrive — non risolve tutto, benché a volte vogliono farci credere questo dogma di fede neoliberale» (n. 168). Il pericolo (non puramente ipotetico) è che la politica si trasformi in variabile dipendente dell’economia, anziché conservare la funzione di perno di conduzione della vita associata.
Il secondo scoglio è rappresentato dal populismo, una vera degenerazione della politica, dove ad avere il predominio è la ricerca del consenso a tutti i costi in vista della permanenza al potere. L’enciclica non manca di distinguere il populismo dal popolarismo, rilevando come quest’ultimo implichi la consapevolezza di essere parte del popolo condividendo i legami sociali e culturali comuni e sviluppando azioni che esigono il coinvolgimento di tutti attorno ad obiettivi condivisi. Quando la capacità di interpretare il sentire di un popolo si muta nella ricerca dell’interesse immediato — osserva papa Francesco — si cade inevitabilmente in una forma di clientelismo che fa passare la politica da ambito di promozione del bene comune a luogo della tutela e della promozione di interessi particolaristici.
Infine, il terzo (e ultimo) scoglio è legato all’assunzione del paradigma efficientista della tecnocrazia. L’enciclica ritorna con frequenza anche in altri documenti (si veda in particolare la Laudato sì) sulla rilevanza assunta da questa visione della realtà che permea di sé le coscienze e che si sviluppa nei vari campi in cui si svolge la vita sociale. L’enorme successo acquisito dalla tecnica nella società attuale, mentre alimenta una sorta di prometeismo che si traduce nell’esercizio di un dominio incondizionato sulla realtà, conferisce alla politica un carattere del tutto pragmatico e contingente, impedendole di proiettarsi con progetti a lunga scadenza nel futuro (n. 177).
 Le tre tentazioni segnalate esigono, per essere superate, — sottolinea il documento papale — l’acquisizione dei valori della carità e della verità nelle loro reciproche implicazioni. La carità, di cui la politica è l’espressione più alta, si esercita con l’assunzione di un atteggiamento di piena disponibilità verso i bisogni delle persone, soprattutto di quelle — individui e categorie sociali — che vivono in situazioni di ingiustizia: si va dai piccoli gesti all’impegno a cambiare le strutture che creano condizioni di diseguaglianza. Ma l’esercizio della carità – osserva papa Francesco — non può avvenire senza che essa si lasci guidare dalla verità, evitando di cadere nella tentazione di opinioni contingenti o di stati emozionali: «Senza la verità — si legge nell’enciclica — l’emotività si vuota di contenuti relazionali e sociali. Perciò l’apertura alla verità protegge la carità da una falsa fede che resta “priva di respiro umano universale”» (n. 184).
Le tre tentazioni segnalate esigono, per essere superate, — sottolinea il documento papale — l’acquisizione dei valori della carità e della verità nelle loro reciproche implicazioni. La carità, di cui la politica è l’espressione più alta, si esercita con l’assunzione di un atteggiamento di piena disponibilità verso i bisogni delle persone, soprattutto di quelle — individui e categorie sociali — che vivono in situazioni di ingiustizia: si va dai piccoli gesti all’impegno a cambiare le strutture che creano condizioni di diseguaglianza. Ma l’esercizio della carità – osserva papa Francesco — non può avvenire senza che essa si lasci guidare dalla verità, evitando di cadere nella tentazione di opinioni contingenti o di stati emozionali: «Senza la verità — si legge nell’enciclica — l’emotività si vuota di contenuti relazionali e sociali. Perciò l’apertura alla verità protegge la carità da una falsa fede che resta “priva di respiro umano universale”» (n. 184).
L’insistenza sulla «verità» — termine che ricorre ben 69 volte — è dovuta in particolare al fatto che essa costituisce l’antidoto a una forma di relativismo imperante che, negando l’esistenza di principi universali, riduce le leggi a mere «imposizioni arbitrarie e ad ostacoli da evitare» (n. 206). L’attuale crisi della politica — l’enciclica lo ribadisce con frequenza — non può trovare soluzione mediante il semplice ricorso a procedure formali; ha bisogno come presupposto imprescindibile di un ethos culturale condiviso.
In questo contesto papa Francesco inserisce la questione della pace cui sono dedicate pagine tra le più belle dell’enciclica. La sua promozione è un compito laborioso, frutto di un patto sociale teso a bandire ogni forma di ostilità preconcetta e di violenza: «Ogni violenza commessa contro un essere umano — si legge nel documento papale — è una ferita nella carne dell’umanità; ogni morte violenta ci ‘diminuisce’ come persone […]. La violenza genera violenza, l’odio genera altro odio, e la morte, altra morte. Dobbiamo spezzare questa catena che appare ineluttabile» (n. 227).
La condizione perché la pace si renda efficacemente presente, tanto nell’ambito delle relazioni interpersonali quanto di quelle sociali, è lo sviluppo di una «cultura del dialogo» (o del «confronto»). Una cultura, che concorra a sviluppare il senso della tolleranza e della collaborazione reciproca, favorendo forme di convivenza ordinata. Ora il dialogo si costruisce con la pazienza e con la gentilezza (n. 222), legando tra loro istanze diverse, cercando punti di contatto, gettando ponti e progettando soluzioni in comune. A renderlo possibile è la pratica di due virtù: la riconciliazione e il perdono. Se la prima — la riconciliazione — è frutto di un intenso lavoro di mediazione con il ricorso al negoziato e all’arbitrato; il secondo — il perdono — implica l’irruzione della gratuità, la quale infrange la spirale della vendetta. Non si tratta di assentire a una forma di «riconciliazione generale», che pretende di chiudere le ferite per decreto o di coprire le ingiustizie con un manto di oblio, ma di cercare la giustizia e il diritto, evitando la ritorsione che alimenta l’odio e la violenza. «Quando i conflitti non si risolvono ma si nascondono o si seppelliscono nel passato — scrive papa Francesco — ci sono silenzi che possono significare il rendersi complici di gravi errori e peccati. Invece la vera riconciliazione non rifugge dal conflitto bensì si ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, sincera e paziente» (n. 144).
L’enunciazione dei valori tuttavia non basta. Occorre dare vita a scelte concrete, volte ad affrontare alcune grandi emergenze — dalla fame e dalla mancanza di una terra in cui versano milioni di persone al riconoscimento dei diritti di tutti a partire da quelli delle categorie più povere — e aprirsi a forme sempre più ampie di collaborazione internazionale (n. 172). La constatazione che al produrre la violenza è spesso la presenza — come si è ricordato — di strutture ingiuste, rende evidente la necessità di un impegno costante a dare vita a una società che superi le inequità esistenti, a partire dalla mancata inclusione dei poveri, che rifiuti per principio che si possa parlare di «guerra giusta», e che bandisca decisamente la pena di morte come misura del tutto anacronistica.
4. Il contributo delle religioni
In questo itinerario di costruzione della fraternità universale e dell’amicizia sociale, l’enciclica assegna un ruolo importante alle religioni. Lo stimolo alla stesura del testo dell’enciclica è venuto del resto a papa Francesco dall’incontro nel febbraio 2019 ad Abu Dhabi con il grande imam Ahmad Al-Tayyeb per ricordare che Dio «ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità e li ha chiamati a convivere come fratelli tra loro» (n. 5). La consapevolezza che la fraternità si fonda sulla coscienza di essere figli dello stesso Padre, le conferisce un carattere trascendente che ne avvalora la portata e fa delle religioni un bene per la intera società.
Per questo l’enciclica insiste nel sottolineare la necessità che esse vengano riconosciute come una componente essenziale della realtà sociale e, pur affermando il rispetto che devono avere per l’autonomia della politica, non manca di rivendicare il diritto a una loro presenza nel dibattito pubblico, difendendo la loro libertà di espressione (nn. 272–275). Fondamentale, anche in vista dell’esercizio di questa funzione è il dialogo e la collaborazione tra di esse: un dialogo che deve condurre a una reciproca conoscenza e al rifiuto di ogni forma di fondamentalismo. Un dialogo che non esclude certo per i cristiani un’attenzione specifica alla peculiarità del vangelo in quanto sorgente della dignità di ogni essere umano e come stimolo a vivere nel segno dell’amore universale. L’incontro e lo scambio interreligioso suppongono, perché si pervenga a un reciproco arricchimento, una solida acquisizione della propria identità e insieme la convinzione di essere posseduti da una parte limitata di verità e di poterne, conseguentemente, ricevere preziosi segmenti dal confronto con gli altri (nn. 277–280).
Conclusione
Il tracciato percorso dall’enciclica ci riporta a considerare, in una prospettiva più completa, il significato dei due termini ricorrenti ed intrecciati — qualche volta sovrapposti — che costituiscono il tessuto connettivo delle diverse proposte offerte dal documento papale. Fraternità universale e amicizia sociale sono due poli, dialetticamente compresenti, che rinviano alle due dimensioni dell’amore, il quale implica nello stesso tempo profondità (intensità) ed estensione (dilatazione). La carità va infatti esercitata nei confronti di ciascuno e nei confronti di tutti.
Queste due dimensioni interdipendenti e reciprocamente interagenti ritornano di fatto con insistenza nel testo dell’enciclica, dove «universale» e «particolare» sono concepiti come realtà co-necessarie: il vero universale — non l’universalismo astratto e omologante cui si è accennato — è quello che fa spazio al particolare che, anzi, lo assume e lo valorizza, mentre, a sua volta, il vero particolare è quello che, riconoscendo la propria parzialità, si apre all’universale. A questo ci si riferisce quando si parla di «glocale», il quale non comporta rinuncia a una precisa collocazione spaziale, ma, partendo da questa collocazione che definisce la propria appartenenza (e dunque in parte anche la propria identità), si dispone ad accogliere ciò che trascende i propri confini, fino al perseguimento dell’universalità.
Questo significa che la «prossimità» non esaurisce la «fraternità», la quale ha un orizzonte molto più ampio, in quanto si estende all’intera umanità; occorre allora trovare il giusto equilibrio tra i due livelli. È quanto ha messo in evidenza con grande lucidità Paul Ricoeur, il quale, andando oltre il personalismo classico, introduce, accanto al rapporto io-tu, il «terzo», colui con cui non si è in contatto diretto (e presumibilmente non lo si sarà mai), ma che non è per questo un anonimo, bensì un soggetto con un nome e un volto precisi, che reclama l’assunzione di una precisa responsabilità. È questo il compito fondamentale della politica, la quale proprio per questa ragione diviene — come già si è ricordato — il modo più alto di vivere la carità.
L’enciclica si muove in questa direzione, non accontentandosi di fornire degli orientamenti teorici, ma misurandosi concretamente con le questioni oggi sul tappeto e offrendo indicazioni operative di grande interesse. Redatta con un linguaggio evocativo e immaginifico, che non disdegna il ricorso alla narrazione poetica e alla metafora del sogno, con l’intento di sollecitare accanto alla ragione il cuore e i sentimenti, essa costituisce, in un momento difficile come l’attuale, un importante messaggio di speranza.
Giannino Piana
 IT
IT  EN
EN