Edoardo Mattei
Cristiani nel digitale. Sfide e proposte per una cultura digitale cristiana,
Edizioni IDS, Roma 2019
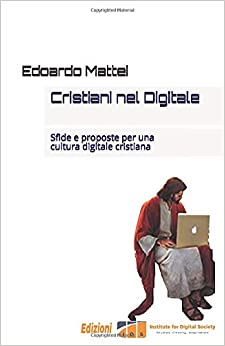
![]() I credenti, infatti, avvertono sempre più che se la buona notizia non è fatta conoscere anche nell'ambiente digitale, potrebbe essere assente nell'esperienza di molti per i quali questo spazio esistenziale è importante. L'ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani. [...] La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non tanto per essere al passo coi tempi, ma proprio per permettere all'infinita ricchezza del Vangelo di trovare forme di espressione che siano in grado di raggiungere le menti e i cuori di tutti. (Benedetto XVI, 2013).1
I credenti, infatti, avvertono sempre più che se la buona notizia non è fatta conoscere anche nell'ambiente digitale, potrebbe essere assente nell'esperienza di molti per i quali questo spazio esistenziale è importante. L'ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani. [...] La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non tanto per essere al passo coi tempi, ma proprio per permettere all'infinita ricchezza del Vangelo di trovare forme di espressione che siano in grado di raggiungere le menti e i cuori di tutti. (Benedetto XVI, 2013).1
Sono passati ormai sette anni dal discorso di Benedetto XVI e si sono moltiplicati nel frattempo i documenti, gli studi e le esperienze di coloro che cercano di portare il messaggio cristiano nelle attuali culture e società digitalizzate, in particolare nel mondo occidentale. Manca tuttavia un sentire comune, troppi ancora sono i detrattori o coloro che temono che le trasformazioni del sociale, causate — almeno in parte — dalla rivoluzione tecnologica e digitale, siano poco compatibili con la fede cristiana, con la sua attualizzazione nel vivere quotidiano, con la liturgia e con la catechesi.
Per questo è interessante il contributo di quest'ultimo lavoro di Edoardo Mattei: Cristiani nel Digitale. Sfide e proposte per una cultura digitale cristiana. L'autore è un laico domenicano, professionista del digitale, docente presso l'ISSR Mater Ecclesiae di Roma. Il libro può essere considerato come una collezione di brevi saggi che toccano diversi aspetti della contemporaneità, ciascuno con il compito di offrire elementi storici, filosofici e sociologici in grado di illuminare e meglio interpretare le complessità contemporanee e le sfide alla fede; un ricco apparato bibliografico permette ai lettori di approfondire le parti di maggiore interesse.
Il volume si compone di 12 capitoli, che affrontano altrettanti temi:
1. Evoluzione storica – Il primo capitolo ripercorre a grandi passi le grandi rivoluzioni tecnologiche del passato: dalla prima rivoluzione industriale (XVIII secolo), alla seconda (con l'avvento dell'elettricità e le sue conseguenze nella vita sociale, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo), alla terza (la nascita dell'informatica, a partire dai primi elaboratori degli anni 40 del secolo scorso fino all'alba del XXI secolo, con gli sviluppi dei software e le molteplici applicazioni) fino all'attuale quarta rivoluzione industriale caratterizzata dal cosiddetto «Internet delle cose» (IoT) in cui gli oggetti — come le persone — sono collegati in una rete globale, attraverso la quale fluiscono i dati e le informazioni raccolte da sensori e programmi, che vengono a loro volta interpretate da algoritmi ed intelligenze artificiali. Qual è il ruolo della persona in questo contesto? Qual è il rapporto con i «decisori» automatici? Quali relazioni hanno valore? Quali valori vengono veicolati e quali di questi sono alla base dei sistemi di scelta automatica? Quali sono le responsabilità in gioco? E di chi sono?
2. Fondamenti ontologici – Il secondo capitolo si propone di definire una ontologia del digitale, a partire dal pensiero di filosofi e sociologi contemporanei. Che cosa intendiamo quando parliamo di digitale? E che cos'è (o piuttosto cosa diventa, come viene percepita) la realtà nell'era digitale? Nella prima parte vengono esposte in sequenza diverse teorie che contrappongono il virtuale al reale, o che identificano il virtuale con il falso o l'illusorio. Al contrario Pierre Levy afferma che il virtuale non si oppone al reale, ma è spazio di possibilità e quindi di creatività. D'altra parte il gesuita Antonio Spadaro osserva come sia necessario ritrovare una sintesi e ricomporre la separazione tra esperienza digitale ed esperienza «reale» (a volte indicate rispettivamente come on-line e off-line); dello stesso parere è Nathan Jurgenson che propone di considerare l'esperienza virtuale come un ampliamento, un potenziamento della realtà. Si pongono diversi interrogativi sulle conseguenze psichiche e neurologiche che tutto questo comporta (a forza di delegare attività cognitive alle macchine «intelligenti» rischiamo di perdere le corrispondenti capacità cerebrali... ma contemporaneamente ne acquisiamo altre). D'altra parte, la nostra specie ha già più volte attraversato fasi in cui queste trasformazioni sono avvenute, come è avvenuto ad esempio con l'introduzione della scrittura. Il capitolo si conclude con una riflessione di tipo antropologico: che tipo di umanità e di società abbiamo davanti? L'autore ci ricorda — con un salto nel passato — come la rivoluzione copernicana abbia contribuito a modificare il rapporto dell'umanità con il cosmo, così come in seguito è avvenuto con le teorie darwiniane (rapporto tra umanità e mondo animale) e con la psicoanalisi e le neuroscienze (rapporto con la propria mente). Siamo forse giunti ad un ulteriore passaggio in cui i confini dell'umano cambiamo? Le attuali teorie cyborg si stanno interrogando su questi temi: come cristiani, che cosa abbiamo da dire su tutto questo?
3. Teologia e rapporto con il digitale – Il terzo capitolo si interroga sul ruolo della teologia e sulla necessità di una riflessione teologica sul digitale. Tecnica e tecnologia sono da sempre (si pensi agli artigiani) categorie teologiche: capacità messe a disposizione da Dio per il benessere dell'umanità. Qual è dunque il problema a considerare il software — e le realizzazioni che questo rende possibili — in tale prospettiva? Eppure, «su Internet non ci sono sacramenti»2, perché le esperienze virtuali del mondo digitale non riescono a sostituirsi alla materialità dei segni. D'altra parte come potremmo confrontare la partecipazione alla liturgia di una comunità in carne ed ossa con la partecipazione a eventi e a gruppi virtuali su internet, dove parole come prossimità o amicizia assumono significati del tutto diversi all'usuale? Inoltre, ci fa notare l'autore, il digitale entra pervasivamente nella nostra esperienza in un momento in cui era già in crisi il senso del divino, in cui sembra venire meno il pensare a Dio come l'originatore di senso e dei fini, in cui il problema non è più l'ateismo, ma l'indifferenza. Eppure, nel momento in cui è sempre più raro affidarsi a Dio, ci si affida al digitale come ad un nuovo oracolo, si va nel luogo dove è possibile trovare tutte le risposte, e non importa se invece che risposte di senso si tratta di probabilità e di correlazioni basate su quantità di dati memorizzati: tutto ciò che conta è che alla fine «funzioni»! Ma è davvero sufficiente? Forse, se la teologia trovasse nuovi linguaggi e si aprisse ai nuovi contenuti, potrebbe illuminare il cammino dell'umanità in questo passaggio epocale.
4. Comprendere la tecnologia – Il quarto capitolo sviluppa la questione del cosiddetto «re-incanto tecnologico». Un secolo fa Max Weber aveva parlato di «disincanto del mondo»3: per effetto della razionalità scientifica e dell'intellettualizzazione, l'uomo moderno non ricorre più a potenze superiori, è con la sua sola ragione che vuole sviluppare sé stesso e i suoi progetti, in autonomia; tuttavia, scienza e tecnica non riescono da sole a riempire il vuoto esistenziale e la ricerca di senso. Dal difficile equilibrio tra il voler controllare con la ragione la realtà e l'esperienza quotidiana del limite, ci troviamo oggi catapultati in un mondo in cui sembra che siano le macchine (il software) a controllare la complessità dell’esistente: il digitale media la conoscenza del mondo esterno e modifica l’esperienza, al punto da far perdere ogni interesse per la ricerca delle cause e dei fini. Si giunge così ad un nuovo incanto — re-incanto — tecnologico, si cade in una sorta di «medioevo digitale», in cui si preferisce accettare il mondo come il software lo propone, rinunciando non solo al suo controllo, ma soprattutto alla sua comprensione. Dall’altro lato, in completa opposizione, si situano tutti coloro che per reazione non accettano questo stato di cose e rifiutano in-toto il digitale. Ma non è demonizzando il progresso tecnologico e/o limitandosi ad evidenziarne i difetti che potremo costruire una società migliore: come dice l’autore, forse dovremmo «smettere di pensare a quello che il digitale fa a noi ed iniziare a pensare a quello che noi potremmo fare con il digitale». La sfida è quella di governare i processi, accettando la complessità.
5. Paradiso in terra? – Nel quinto capitolo l'autore si confronta con le filosofie «trans-umaniste», che, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, hanno sviluppato una visione e un uso delle tecnologie in grado di superare la finitezza degli esseri umani — dall'invecchiamento ai principali limiti fisici e mentali — in una visione ultra-ottimista, salvifica e trascendente, che sembra auspicare la possibilità di un nuovo paradiso in terra. Dall'altro lato, già a partire dalla scuola di Francoforte, diversi studiosi avevano già messo in guardia dai rischi della tecnologia e dell'alto prezzo da pagare in termini di alienazione, del senso di inferiorità dell'umano rispetto alle macchine. Ma la sola capacità tecnica può davvero determinare il futuro che ci attende? E i diversi mondi virtuali resi possibili dalle tecnologie sono davvero in grado di annullare la realtà? Forse l'elemento mancante è ancora una volta il progetto di Dio su di noi, un progetto di salvezza, di valorizzazione, di riscoperta della dignità di ciascuno. Il problema allora non è nella tecnologia, quanto nella vecchia tentazione di poter fare a meno di Dio.
6. Digitale e partecipazione – Il sesto capitolo affronta alcuni temi di attualità che riguardano la «Chiesa nel digitale»: la comunicazione e la partecipazione a liturgia e sacramenti. Per quanto riguarda gli aspetti collegati ai mass-media e più in generale alla comunicazione digitale, l’autore osserva come, a partire da un primo periodo di diffidenza e di timore per le difficoltà di controllo di contenuti e forme sempre più pervasive, siamo nel tempo passati ad un utilizzo sempre più ampio e consapevole di questi strumenti, sia a scopo informativo che formativo, da parte della Chiesa e delle istituzioni ad essa collegate. Quella che manca è una riflessione approfondita e la capacità di individuare linee guida condivise per quanto riguarda la possibilità — e le forme — per una partecipazione «mediata dal digitale» dei fedeli alle azioni liturgiche e ai sacramenti. Questo tema è salito prepotentemente alla ribalta a seguito della recente pandemia da COVID, ma non ha trovato per il momento una soluzione. L'autore suggerisce di ripartire da una lettura coraggiosa dei «segni dei tempi» per individuare forme concrete per una «actuosa partecipatio» aperta ai nuovi mezzi che la tecnologia oggi ci offre.
 7. Famiglia nel digitale – Il settimo capitolo è dedicato alla famiglia e alla sua evoluzione, sia come istituzione umana che alla luce della rivelazione cristiana. Dopo aver passato in rassegna alcuni dei passaggi fondamentali dell'evoluzione storica e sociale di questa istituzione, dal Medioevo alla rivoluzione industriale ed oltre, vengono qui ricordati gli aspetti salienti del Magistero sulla famiglia e sul matrimonio. Nell’ultimo paragrafo l’autore si interroga su alcuni impatti del digitale sulla famiglia, in particolare su un aspetto che riguarda la privacy a seguito dell’ormai diffusa abitudine di tante persone di pubblicare foto dei propri figli e di eventi familiari importanti, accumulando così una quantità di dati e di informazioni che rimarranno disponibili negli anni a seguire, anche quando i figli saranno cresciuti, le condizioni familiari mutate e alcune informazioni potrebbero diventare un bagaglio ingombrante…
7. Famiglia nel digitale – Il settimo capitolo è dedicato alla famiglia e alla sua evoluzione, sia come istituzione umana che alla luce della rivelazione cristiana. Dopo aver passato in rassegna alcuni dei passaggi fondamentali dell'evoluzione storica e sociale di questa istituzione, dal Medioevo alla rivoluzione industriale ed oltre, vengono qui ricordati gli aspetti salienti del Magistero sulla famiglia e sul matrimonio. Nell’ultimo paragrafo l’autore si interroga su alcuni impatti del digitale sulla famiglia, in particolare su un aspetto che riguarda la privacy a seguito dell’ormai diffusa abitudine di tante persone di pubblicare foto dei propri figli e di eventi familiari importanti, accumulando così una quantità di dati e di informazioni che rimarranno disponibili negli anni a seguire, anche quando i figli saranno cresciuti, le condizioni familiari mutate e alcune informazioni potrebbero diventare un bagaglio ingombrante…
8. Lutto e morte nel digitale – L‘ottavo capitolo ci parla del lutto e di come la morte sia stata affrontata dai singoli e dalle comunità umane durante la storia. Anche se è questo un tema ampiamente rimosso nelle nostre società contemporanee, l’autore ci fa osservare come le applicazioni digitali ci pongono ulteriori problemi: le applicazioni digitali non contemplano la morte dei soggetti, i dati possono ben sopravvivere ai loro padroni, e non è ad oggi prevista la possibilità di ereditarli, trasferirne la proprietà, o anche semplicemente di cancellarli. Le persone defunte possono davvero continuare «a vivere» nel digitale?
9. Esegesi dei testi nel digitale – Il nono capitolo si/ci interroga sull'ermeneutica, sulle possibilità di esegesi nel digitale. Già nel passaggio dalla conoscenza orale a quella scritta (si pensi alla Bibbia nella tradizione) si sono aperte nuove possibilità di fruizione e di comprensione dei testi, dopo una iniziale diffidenza. Le tecnologie degli ipertesti — che consentono di leggere un testo e consultare contemporaneamente approfondimenti tematici che permettono di ampliarne la comprensione — si sono largamente diffuse negli ultimi sessant’anni. Quali ulteriori possibilità ci offrono oggi i social network, per intercettare le tante narrazioni esistenziali e portare lì la lieta novella dell’annuncio cristiano?
10. Comunità digitali – In questo capitolo l'autore riprende nuovamente e approfondisce il tema delle comunità umane, avvalendosi del pensiero di alcuni autori quali Buber, Illich e Bauman; prosegue poi nel secondo paragrafo trattando delle comunità religiose e della loro evoluzione dai primi secoli della cristianità, ai grandi riformatori del Medioevo, fino alle novità introdotte con il Concilio Vaticano II. Il suo intento è quello di capire se nelle comunità digitali vi sia spazio per quei valori e quelle prassi che avevano caratterizzato le comunità umane nel corso della storia. Il digitale permette l'apertura a dimensioni spaziali prima impensabili, creando comunità di vicini tra persone fisicamente distanti; il digitale poi rende particolarmente evidente l'appartenenza di ciascuno a gruppi molteplici e la necessità di mantenere vivi i rapporti, in una dinamicità che rende conto della continua evoluzione e di cambiamenti sociali. A fronte quindi di queste possibilità e della rilevanza delle comunità digitali nella vita privata e pubblica di ciascuno, egli auspica la presenza di una Chiesa locale, anzi l'attuazione di una prelatura personale per il digitale, di una organizzazione della Chiesa specifica, in grado di operare in un ambiente sovra-territoriale con una cultura ed un linguaggio proprio, per poter essere presente ed efficace nel digitale, nella fedeltà al proprio mandato.
11. Medicina e digitale – Sono innegabili gli esiti positivi introdotti dalle innovazioni tecnologiche e dalle applicazioni digitali alla medicina, con l'uso sempre più spinto dei dati e degli algoritmi predittivi per la diagnosi e la prevenzione, e delle tecnologie robotiche di supporto alla chirurgia. A fronte di tutto questo, stanno emergendo grandi interrogativi di natura etica: chi prende le decisioni, e su quali basi di ragionamento? Chi ha l'accesso ai dati dei pazienti e che utilizzo ne può fare (si pensi ad esempio ai datori di lavoro o alle assicurazioni...)? Vi è infine un ulteriore interrogativo, secondo l'autore: sempre più spesso siamo portati a pensare alla morte come all'esito di una malattia non curata, piuttosto che ad una destinazione naturale, come distinguere dunque il sostegno alla vita da un accanimento terapeutico? Abbiamo bisogno di sviluppare nuove consapevolezze e nuovi sviluppi dell'etica.
12. Lavoro ed economia nel digitale – Quest'ultimo capitolo sviluppa l'evoluzione del lavoro umano e della sua organizzazione, in particolare negli ultimi cento anni. A fronte dell'aumento di produttività dovuto alle nuove tecnologie è evidente che non vi è stata una analoga capacità distributiva della ricchezza: la circolarità consumo-lavoro-benessere si è spezzata, come ci fa notare l'autore, e a nulla sembrano finora servire gli interventi governativi messi in campo; la ricchezza prodotta e sottratta dai luoghi di produzione si accumula nelle mani di pochi. Contemporaneamente, questa evoluzione sta estromettendo le persone dal mondo del lavoro, aprendo nuovi problemi sociali ed antropologici. L'economia nell'era digitale è priva di confini spazio-temporali, ma è assai difficile ipotizzare sistemi e politiche fiscali sovra-nazionali. Servono nuove politiche economiche, come ad esempio l'introduzione di un reddito di base per tutti, per poter superare così i problemi connessi con la disoccupazione strutturale; ma sarebbe necessario allora sviluppare contestualmente una nuova cultura del lavoro che modifichi il concetto di lavoro, da quello di lavoro salariato al lavoro volontario di cura per il bene comune.
Complessivamente è un libro assai denso di contenuti, di stimoli e di riferimenti. La necessità di rappresentare in meno di trecento pagine le principali sfide presentate dall'avvento del digitale ha costretto l'autore a sintetizzare idee e concetti in maniera non sempre facile alla loro comprensione. In taluni casi la sintesi ha prodotto delle scelte storiche non sempre condivisibili, perché mancanti di alcuni elementi utili alla valutazione. D’altra parte, gli esempi e i suggerimenti per azioni ed interventi volti a sviluppare una più consapevole cultura del digitale avrebbero probabilmente richiesto un maggiore spazio di approfondimento. Il ricco impianto bibliografico sopperisce in gran parte a queste mancanze, anche se avremmo apprezzato una maggiore presenza delle fonti del magistero di papa Francesco, che ad esempio ha dedicato il messaggio per la 53ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (2019) al tema delle comunità sulle reti sociali4. In ultima analisi rimane comunque un testo utile per farsi un'idea sugli sviluppi e le implicazioni della cultura digitale nella vita delle persone e delle comunità cristiane.
Marina Russo
NOTE
1 Benedetto XVI, 2013, Messaggio per la XLVII giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Citazione riportata nel testo.
2 Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, 2002, La Chiesa e internet.
3 Max Weber, La scienza come professione, 1917, conferenza pubblicata nel 1919.
4 Messaggio per la 53ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali: Siamo membra gli uni degli altri. Dalle social network communities alla comunità umana, 2019.
 IT
IT  EN
EN 












