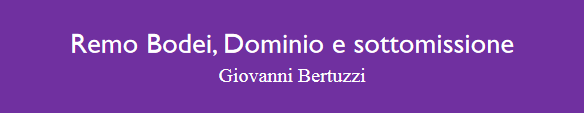Remo Bodei
Dominio e sottomissione
Il Mulino, Bologna, 2019

![]() È davvero sorprendente come Remo Bodei si sia mosso con competenza e abilità nei diversi campi del sapere e nei vari contesti storici, per analizzare ed approfondire una problematica così vasta e complessa come quella relativa alle diverse forme di dominio e sottomissione, che hanno segnato il corso della storia. Solo uno studioso della sua statura ha potuto adoperare la filosofia come osservatorio interdisciplinare, rigoroso dal punto di vista scientifico senza essere pedante, e ha saputo usare un linguaggio accessibile a tutti, anche ai non specialisti: virtù questa rara nel proscenio della odierna cultura scientifica e filosofica. Pertanto, la caratteristica principale di quest’opera è individuabile in quello che egli stesso afferma nell’introduzione: «In questo volume non ho inteso separare la dimensione teorica da quella storica, le idee dai dati, gli elementi di universalità da quelli di particolarità…» (p. 24).
È davvero sorprendente come Remo Bodei si sia mosso con competenza e abilità nei diversi campi del sapere e nei vari contesti storici, per analizzare ed approfondire una problematica così vasta e complessa come quella relativa alle diverse forme di dominio e sottomissione, che hanno segnato il corso della storia. Solo uno studioso della sua statura ha potuto adoperare la filosofia come osservatorio interdisciplinare, rigoroso dal punto di vista scientifico senza essere pedante, e ha saputo usare un linguaggio accessibile a tutti, anche ai non specialisti: virtù questa rara nel proscenio della odierna cultura scientifica e filosofica. Pertanto, la caratteristica principale di quest’opera è individuabile in quello che egli stesso afferma nell’introduzione: «In questo volume non ho inteso separare la dimensione teorica da quella storica, le idee dai dati, gli elementi di universalità da quelli di particolarità…» (p. 24).
Cerchiamo, allora, di gettare anche noi uno sguardo su questo ampio campo di indagine, passando rapidamente in rassegna i tre temi principali che vi sono stati trattati: 1) la schiavitù (antica e moderna), 2) le macchine, 3) il lavoro e l’uso del tempo della vita.
1) Bodei inquadra prima di tutto il fenomeno della schiavitù nel suo contesto storico e lo analizza nelle diverse forme che ha assunto in epoche differenti, dall’antichità greca alle sue diverse realizzazioni in Europa, in America e in Asia. Egli riconosce, che si è trattato di una condizione di vita che ha lasciato gli schiavi in una condizione di subumanità o disumanità (cfr. p. 12). Nello stesso tempo, però, egli constata che la schiavitù ha assunto anche forme di dominio che non contemplavano necessariamente la brutalità e il lavoro coatto, ma «essa è stata anche il terreno da cui sono germogliate la fedeltà, la dedizione, l’abnegazione e l’affetto nei confronti dei padroni» (ibid.).
Filosoficamente e teoricamente Bodei affronta il rapporto servo-padrone, confrontandosi in particolare per l’antichità con Aristotele, con la sua Politica e con l’Etica a Nicomacheo, mentre per la modernità molti sono i punti di riferimento, soprattutto la Fenomenologia dello spirito di Hegel, che Bodei tratta e discute in rapporto e in polemica con l’interpretazione che ne ha data il Kojève. Hegel ha impostato il rapporto servo-padrone in modo tale da spiegare la nascita dell’autocoscienza moderna (cfr. p. 185), ma secondo lui questo rapporto non sfocia nel capovolgimento delle gerarchie per cui il padrone diventa servo, come pensa Kojève, ma nella condizione di quella che egli chiama «la società civile», in cui ciascuno è padrone e servo nello stesso tempo (p. 184).
2) Il tema della civiltà delle macchine viene anch’esso considerato in continuità con gli argomenti precedenti, perché grazie alle macchine le condizioni dell’antica schiavitù sono state superate, ma sono subentrate nuove forme di dominio e di servitù. Col sorgere delle macchine, infatti, la schiavitù di massa cessa per gradi di essere conveniente, tanto da permettere la sua virtuale abolizione. Ma accanto ai grandi vantaggi che la produzione industriale presentava, occorre riconoscere i risvolti negativi di questo fenomeno, che Bodei ricorda con Sismondi e David Ricardo: in primo luogo l’allargamento della forbice tra sovrapproduzione e consumo, che genera disoccupazione, e in secondo luogo lo squilibrio tra domanda e offerta, che apre le porte alle diverse forme di miseria delle masse della società industriale (sfruttamento, ubriachezza, prostituzione, ecc.) (pp. 249-253).
Nei capitoli decimo e undicesimo Bodei passa in rassegna le diverse forme di dipendenza e servitù, che hanno caratterizzato la civiltà delle macchine, dalla schiavitù dei negri nelle piantagioni di cotone degli Stati Uniti, alla schiavitù salariata della società industriale moderna. Marx sostiene una sostanziale continuità tra la schiavitù antica, la servitù medievale e la moderna «schiavitù salariata» (p. 266).
 La parte dell’opera di Bodei più attuale e stimolante, tuttavia, è quella che porta il titolo significativo: «E il verbo si fece macchina» (pp. 207-320). Ciò che caratterizza, infatti, la nostra civiltà attuale è la rivoluzione informatica e tecnologica, la cosiddetta quarta rivoluzione, che ha prodotto macchine capaci come l’uomo di pensare e parlare, macchine che hanno permesso al «logos» di riprodursi in un prodotto artificiale, di sostituire l’uomo anche nella facoltà di decidere e di trasformare comandi digitali in realtà (la 3D). Viene così a cessare, aristotelicamente parlando, «la separazione tra il logos e la poiesis, tra ragione e produzione, tra la mente e il braccio» (p. 304). L’autore avverte, prima di tutto, che non bisogna contrapporre frontalmente l’uomo alle macchine, perché la tecnica, anche la più progredita, è figlia del sapere umano e dipende ontologicamente dall’uomo. Di conseguenza egli non assume un atteggiamento pessimista nei confronti del progresso tecnologico, e della robotica come sua fase più avanzata, non avanza previsioni sicure sul futuro, ma indica la strada che l’uomo deve seguire per riuscire a realizzare processi che connettano il lavoro umano alle nuove tecnologie. Tale strada, secondo lui, è quella dell’educazione, cioè di una educazione che richiede il contributo di tutti: istituzioni, tecnici, scienziati, industriali uomini di cultura e cittadini, in modo che tutti assieme si possano raggiungere, come diceva Aristotele, risultati apprezzabili (p. 327).
La parte dell’opera di Bodei più attuale e stimolante, tuttavia, è quella che porta il titolo significativo: «E il verbo si fece macchina» (pp. 207-320). Ciò che caratterizza, infatti, la nostra civiltà attuale è la rivoluzione informatica e tecnologica, la cosiddetta quarta rivoluzione, che ha prodotto macchine capaci come l’uomo di pensare e parlare, macchine che hanno permesso al «logos» di riprodursi in un prodotto artificiale, di sostituire l’uomo anche nella facoltà di decidere e di trasformare comandi digitali in realtà (la 3D). Viene così a cessare, aristotelicamente parlando, «la separazione tra il logos e la poiesis, tra ragione e produzione, tra la mente e il braccio» (p. 304). L’autore avverte, prima di tutto, che non bisogna contrapporre frontalmente l’uomo alle macchine, perché la tecnica, anche la più progredita, è figlia del sapere umano e dipende ontologicamente dall’uomo. Di conseguenza egli non assume un atteggiamento pessimista nei confronti del progresso tecnologico, e della robotica come sua fase più avanzata, non avanza previsioni sicure sul futuro, ma indica la strada che l’uomo deve seguire per riuscire a realizzare processi che connettano il lavoro umano alle nuove tecnologie. Tale strada, secondo lui, è quella dell’educazione, cioè di una educazione che richiede il contributo di tutti: istituzioni, tecnici, scienziati, industriali uomini di cultura e cittadini, in modo che tutti assieme si possano raggiungere, come diceva Aristotele, risultati apprezzabili (p. 327).
3) la quinta parte dell’opera è dedicata ai radicali cambiamenti che l’ultima grande rivoluzione informatica e tecnologica sta producendo e produrrà nella vita dell’uomo, soprattutto nei rapporti di lavoro e nell’uso del tempo (pp. 343 ss.).
Per quanto riguarda il lavoro, i problemi principali sono quelli della disoccupazione e dei nuovi tipi di occupazione, resi necessari per gestire macchine sempre più avanzate, in quanto gli strumenti dell’IA non hanno più soltanto una funzione «ausiliatrice», ma «sostitutrice» dei lavoratori (p. 351). Questo comporta (e comporterà) inevitabilmente che si ridurranno i posti di lavoro e che ci sarà sempre più bisogno di persone qualificate, che sappiano usare e governare queste tecnologie sempre più avanzate.
Ma l’aspetto più interessante di questa sostituzione dell’uomo con le macchine è il diverso impiego del tempo. Ci si chiede: che cosa fa sì che siano le macchine al servizio dell’uomo e non viceversa? Bodei risponde che se le tecnologie spingono ad accelerare sempre di più il ritmo della vita, l’uomo deve decelerare quanto più gli è possibile lo scorrere del suo tempo, per approfondire il senso di quello che accade e di quello che egli fa, in modo da poter essere sempre sé stesso e di non perdere la propria identità. Il capitolo finale dell’opera raccoglie così un insieme di riflessioni e considerazioni sapienziali sul buon uso del tempo, sulla necessità di rientrare in sé stessi, di fermarsi nella meditazione e nel lasciare scorrere la vita, per recuperare autenticamente le trame della propria esistenza, collegando armonicamente il presente con il passato e il futuro. Tra le molteplici riflessioni sapienziali, che occupano questa parte finale dell’opera, due ci sembrano particolarmente significative: la prima riguarda la capacità da parte dell’uomo di costruire la propria personalità non individualisticamente ma assieme agli altri: «Il suo compito non si limiterà perciò al ‘conosci te stesso’, ma si amplierà al conosci il ‘noi’ di cui siamo composti nell’unica e inimitabile ‘corda’ che continuiamo consapevolmente o inconsapevolmente a tessere lungo la nostra vita» (p. 381). La seconda considerazione, che compare proprio nella conclusione del libro, riguarda la verità, una verità necessaria alla democrazia, per evitare che le opinioni si contrappongano equivalendosi relativisticamente in modo tale che alla fine tutti hanno ragione. Pur se il nesso dominio-sottomissione continuerà ad esistere, potrà essere correttamente affrontato se viene conservato il rispetto per una verità che non degrada a semplice opinione, e se si manterranno vivi e non snaturati valori come libertà, eguaglianza, dignità, emancipazione, umanesimo, pluralismo e misericordia, (pp. 286–287).
Concludendo ci sembra che quest’opera sia un esempio ben riuscito di come una tematica vada seguita nella sua evoluzione storica e possa servire per «srotolare» la storia, interpretandola. Da Aristotele a Hegel e a Marx, Bodei ha cercato di spiegare come l’evoluzione del pensiero filosofico abbia seguito l’evoluzione dei rapporti tra servo e padrone, e abbia ben individuato il ruolo che le macchine hanno avuto in questo processo.
Giovanni Bertuzzi
 IT
IT  EN
EN