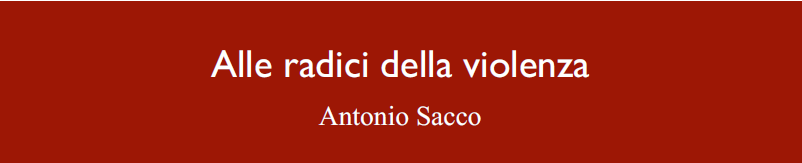
Quale violenza?
![]() La violenza è definita come ogni atto o comportamento che faccia uso della forza che rechi un danno ad un altro nella sua persona, nei suoi beni – materiali e spirituali - o nei diritti.1 Questa definizione è in parte problematica perché se, ad esempio, prendiamo il riferimento alle virtù morali,2 la relazione con le medesime cambia la definizione stessa di violenza fino a trasformarla in qualcosa di altro.3
La violenza è definita come ogni atto o comportamento che faccia uso della forza che rechi un danno ad un altro nella sua persona, nei suoi beni – materiali e spirituali - o nei diritti.1 Questa definizione è in parte problematica perché se, ad esempio, prendiamo il riferimento alle virtù morali,2 la relazione con le medesime cambia la definizione stessa di violenza fino a trasformarla in qualcosa di altro.3
Infatti non tutto quello che è esercizio della forza, in senso anche coercitivo, è violenza, ma è la relazione tra quell’atto di forza e le virtù morali, ad esempio la giustizia, a dire propriamente un atto violento. Non appartiene alla violenza quell’atto con il quale, con la forza, ci si difende o quell’altro con il quale, per fare giustizia, si punisce da parte dell’autorità costituita qualcuno. Tali atti non sono violenti perché l’intenzionalità della loro esecuzione - per difendere la libertà, la giustizia, la socialità e simili – cambia la natura dell’atto stesso.4
Questa stessa questione però ne riflette un'altra: usando il termine forza si sottolinea non un agire qualsiasi, ma si offre un riferimento all’entità della violenza che non è neutrale per la natura dell’atto.5 Ovvero la misura, e la “qualità”, della violenza è sempre anche determinante per dire se l’atto sia violento o meno.
H. Arendt ribadisce che la violenza è sempre un mezzo, mai originaria. La violenza è strumentale: ha bisogno di giustificazione per essere usata in vista di qualche fine. Quindi non è assoluta: questo significa che non è sostanza, non è in sé primaria.6
Proprio questa qualifica della violenza come strumento comporta il fatto che il mezzo non sia neutrale per dire se un atto è violento o meno. Ovvero l’intensità del mezzo, della determinazione fattuale e concreta di come la violenza prende forma, ne determina la natura.7 Un atto anche legato ad una virtù morale, un atto in sé giusto, può diventare violento se prende forma in una modalità senza proporzione, con una forza senza misura. Precisiamo che la proporzione non è in riferimento all’ingiustizia subita, o agli scopi da raggiungere (utilitarismo), ma sempre per il bene di tutti i soggetti coinvolti, per raggiungere un compimento vitale possibile.
Abbiamo individuato due dei possibili fondamenti per definire la violenza, per determinarne il carattere: il primo è il riferimento alla prospettiva morale, in fondo la mancanza di giustizia, il secondo all’intensità, in particolare quando la violenza è senza proporzione nel suo esercizio. Non-giustizia e proporzionalità sono gli elementi che distinguono la natura stessa della violenza.
Una sintesi che metta insieme intenzionalità morale ed azione, può essere tentata indicando a monte un criterio teorico, un principio, per individuare la violenza. Lo definiamo come principio di non maleficenza:8 questo principio può essere sintetizzato dalla massima «non fare del male» oppure «non nuocere ad alcuno».9 La violenza è sempre manifestazione della violazione di questo principio. Il principio emerge non solamente nella sfera dell’intellegibile del soggetto, una via di confronto tra le massime, ma dalla comparazione di una serie di azioni che rappresentano una violazione dello stesso e diventa il criterio della ragion pratica per individuare le situazioni violente. Possiamo esprimerlo dicendo che se osserviamo una serie di azioni, le medesime possono essere sempre individuate come violente, perché infrangono il principio di non maleficenza.
La violenza è un qualcosa che provoca del male all’altro sia per la mancanza di giustizia che per l’intensità della stessa. La visione morale sarà determinante per dirne la natura: dobbiamo sempre astenerci da certi mali nei confronti degli altri perché inconsistenti con il significato ed il valore della vita umana.10 Ma accanto ad essa emerge il concreto di quella forza impiegata che determina l’atto violento.
Sarà il principio stesso che ci aiuta a distinguere, nell’indagine della ragion pratica, quali azioni ricadono nel dominio dello stesso e quali invece ne sono escluse nell’insieme di due elementi: il grado di giustizia che viene affermato con la forza, anche coercitiva, e la sua espressione fattuale. La risultanza sarà un atto come violenza o meno. Se infatti nel perseguire una virtù si attua una forza senza proporzione si violerà il principio di “non maleficenza” e l’azione risulterà violenta. Tanto più se tale atto di forza provoca direttamente un male: sempre alcune azioni sono violente se l’intenzionalità perseguita è di provocare il male, nella violazione del principio.
La violenza e la guerra
La questione del comprendere la violenza come un problema grave è recente.11 Questa è una percezione che deriva dalle guerre mondiali: la violenza, quella in particolare sostenuta dalle ideologie, è diventata “infernale”.12 Tuttavia c’è stato un affievolimento di questa attenzione contro la violenza nel lungo periodo di pace che ci conduce ai nostri giorni, e da cui risulta, a nostro giudizio, anche la guerra che ci stiamo ritrovando in Europa e le innumerevoli guerre nel mondo.
Segnaliamo invece come la questione della violenza abbia il suo culmine nell’espressione della medesima proprio nell’ambito della guerra. Un modo di concepire la guerra è quello che vede la stessa come espressione della violenza assoluta. M. Walzer lo ribadisce con chiarezza: la violenza, nella guerra, può attribuirsi una sorta di “necessità” che la sottrae ad ogni discorso politico ed etico.13 Ne è esempio notevole un episodio di guerra dell’antichità: il massacro di Meli da parte degli ateniesi. In esso il regno della violenza costituisce un mondo a sé, dotato di indiscutibilità secondo l’interpretazione di Tucidide.14 Hobbes intende così Tucidide, la guerra prevede una violenza spietata, vi è una necessità di natura della violenza in relazione alla guerra.
La tesi di Walzer, in Guerre giuste ed ingiuste, è contraria a questa interpretazione. Proprio la violenza nella guerra deve avere un limite.15 Essa è ammessa primariamente a partire da quelle situazioni che classicamente definiamo come jus ad bellum.16 Secondo l’interpretazione precedente l’intenzionalità della giustizia – difendersi come azione di giustizia – cambia l’essenza stessa della violenza che è inevitabile in una guerra difensiva.17
La violenza giustificabile della guerra è sottoposta al dettame etico: è sempre solo un mezzo per difendere dei valori morali e politici che sono imprescindibili quali libertà, democrazia, socialità diffusa, dignità personale e simili.18 Ne è controprova il fatto che per giustificare il suo contrario, la violenza e la guerra ingiuste, si ricorra, praticamente sempre, ad un’affermazione di fare guerra per un qualche valore.19
Accanto a questa prima argomentazione ne emerge una seconda che riguarda lo jus in bello. Esiste una violenza nella guerra che deve essere sempre limitata, una “classe” degli atti inammissibili che va mantenuta come azioni violente impossibili.20
Questi divieti sono soprattutto nel diritto all’intangibilità di chi non è parte attiva del conflitto, nel diritto alla resa da parte dei combattenti salva la vita, nel diritto alla neutralità, nei diritti dei prigionieri e simili.
Violenza originaria?
Questa necessità della violenza nella guerra, e la questione del suo limite, rimanda ad una tripartizione dell’idea stessa di violenza che ha attraversato il pensiero. Esiste una visione arcaica della violenza che è eroica, attraversata da un connotato metafisico, una della modernità che la racchiude nella sfera politica ed una terza della fine della modernità e del contemporaneo che riprende la dimensione metafisica della violenza.21
Affermare una metafisica della violenza significa attribuire ad essa un ruolo originario, ovvero la violenza appartiene alla realtà – sia da parte degli uomini che degli dei – e addirittura ne è il fondamentale aspetto. Il modello dell’eroe guerriero mostra che la virtù per eccellenza è la forza che si tramuta in violenza. Pensare una dimensione metafisica della violenza significa proporne l’ineluttabilità. Se la violenza è originaria, sta alla radice di quello che accade dopo, allora è ingenuo pensare ad una limitazione che sarà sempre parziale e incerta.
Nella visione moderna – già anticipata però nella visione della classicità greca, che è diversa da quella “eroica”, e nel medioevo – la violenza da “affare degli dei” diventa una questione legata all’umano.22 È soprattutto il passaggio ad un esercizio della violenza da privato e strutturale ad un esercizio sociale e collettivo, in particolare nell’esercizio della violenza da parte dell’autorità. Una violenza che è esercitata per un fine comune e non arbitrario. Lo stato – al di là delle innumerevoli teorie politiche e morali che ne giustificano l’esistenza – è autorizzato ad esercitare la violenza, come espresso nella classica tesi di Max Weber: lo stato è quella comunità umana, che nell'ambito di un determinato territorio, riesce a conquistare e a detenere il monopolio della violenza legittima.23 È centrale questa idea di legittimo: la violenza per lo stato ricade sempre nella questione della giustizia e della proporzionalità.
La tesi di H. Arendt, sul rapporto tra potere e violenza, è paradigmatica: non è la violenza la questione originaria, ma è il potere. È il potere – dello stato in questo caso - che utilizza la violenza come mezzo per mantenere la coesione, per conservare la sua realtà associata e per i fini comuni, tuttavia è sempre un potere che non è mai autosufficiente ma si deve basare sul consenso e non sulla sola violenza.24 La filosofa tedesca propone una formula sintetica che è illuminante «L’estrema forma di potere è Tutti contro Uno. L’estrema forma di violenza è Uno contro Tutti».25
Questa affermazione mostra come la violenza non sia originaria, è più mezzo che fine, e dunque in qualche modo pericolosa ma controllabile. Il potere può anche opprimere, esercitare la violenza, quando tutti sono contro uno solo, ma la violenza assoluta ed incontrollabile è piuttosto la forza dell’uno contro tutti, della violenza che non trova ostacolo.26 La tesi della Arendt è tuttavia che proprio questa forma non ha possibilità di durata, di permanenza. Non può essere originaria. Anche se sembra affermarsi per un periodo indefinitamente lungo non può che crollare, la violenza da sola non regge ma si deve richiamare al potere ed al consenso che è preteso da questo.
Le tesi contemporanee sulla visione della violenza come essenza del reale, che riprendono quelle del mondo arcaico ed eroico,27 scontando l’impronta nietzschiana, rimettono al centro la violenza come qualcosa di assoluto e invincibile appartenente propriamente alla cultura umana e alla vita politica.28
Avvertiamo che questo ritorno di una visione originaria della violenza è speculare alla questione della violenza rispetto alla guerra. Se la violenza è assoluta ed originaria, potremo dire che appartiene di per sé alla natura ed alla cultura specie nella valenza politica, e allora niente può arrestarla.
Se invece la violenza è qualcosa di minore, di strumentale ad esempio al potere, è possibile porre un limite morale e culturale per arrestarla.
Radici della violenza
M. Henaff ritorna su questi argomenti sottolineando una violenza che è “al fondo dei tempi”.29 Le figure dell’eroe bambino, innocente e violento contemporaneamente,30 che emergono dalle narrazioni dell’antropologia culturale dicono una forza primordiale della violenza legata all’ira come sentimento che appartiene alla condizione umana.31 Se ira, e la violenza conseguente, sono primordiali niente le può arrestare. Henaff tuttavia critica questo paradigma ed introduce l’idea di relazione:32 la violenza, e l’ira da cui scaturisce, sono una risposta. A monte si ritrova un motivo dell’ira, e della violenza conseguente; sono dovute a qualcosa e a qualcuno: un’offesa che è mancanza di riconoscimento a partire da un contrasto fattuale o di pensiero.
Lo stesso meccanismo della vendetta segnala questa dimensione di reciprocità.33 Il meccanismo che genera la violenza è nella mancanza di riconoscimento: chi si incammina nella vendetta violenta dice la necessità di essere riconosciuto come offeso e solo l’offensore è in grado di ammettere questa dinamica.34
Le suggestioni di Henaff conducono ancora una volta a uscire dall’idea di una violenza assoluta e primordiale e tentano di rispondere invece ad una dimensione antropologica dello scaturire della violenza che è seconda, che nasce in questo caso dai meccanismi di offesa ed ira, richiedente un confronto e riconoscimento tra soggetti. La violenza ancora una volta può essere inserita entro dei limiti a partire da un’elaborazione ed interpretazione dei motivi che la generano.
Questa ricerca del limite alla violenza, che è opera della ragion pratica, si arricchisce di un ultimo sguardo che è quello della tradizione cristiana.35
Violenza e tradizione cristiana
Riprendiamo il principio di “non maleficenza” come criterio di individuazione dell’evento della violenza e modalità di contrasto della stessa. Il “non fare del male ad alcuno” ritrova nella tradizione cristiana uno specifico forte. Infatti questo non fare del male – ed il rifiuto conseguente della violenza - scopre la sua fonte nell’economia trinitaria. Ne offre una profonda sintesi contenutistica il documento della CTI, Dio Trinità degli uomini, che ricorda come il Figlio nella passione patisce violenza, non ne è artefice. È il peccato del mondo che corrompe la religione e acceca la compassione;36 vi è un superamento della violenza nel Figlio, nel Getzemani Gesù interdice ai discepoli un’analoga reazione violenta: allo stesso tempo li sottrae al partecipare forzatamente alla sua condanna, cfr. Gv 18,10-11;37 ed ancora Gesù disinnesca il conflitto violento, che potrebbe incoraggiare, per un’autentica rivelazione di Dio. Si affermano la giustizia e l’amore di Dio: Gesù non rende legittima la violenza ma testimonia l’amore crocifisso del Figlio in favore dell’uomo.38 Ricordiamo come l’intero documento dimostra la tesi che a partire dall’intrinseco della rivelazione, in questo caso dal crocifisso innocente, la violenza in nome di Dio è la massima corruzione della religione e nello specifico della fede cristiana.
Queste affermazioni ricordano come la violenza sia per il cristianesimo sempre un male da vincere.39 Essa è sempre problematica a partire dalle parole paradigmatiche di Paolo in Rm 12,21: «non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male». 40
In queste pagine abbiamo sostenuto attraverso l’apporto di alcuni pensatori che se la violenza è assoluta, è metafisica, allora è invincibile. Invece se è qualcosa di meno centrale ed originario può essere limitata. Sembra quasi paradossale di fronte alla violenza, in particolare nella guerra, indicare un’etica del bene possibile – in questo caso però possiamo dire propriamente quella del male minore – perché l’ideale cristiano è sempre elidere ogni violenza. La tradizione cristiana, ad esempio sempre riaffermando lo jus in bello, e spesso sostenendolo con la sua etica, ha cercato di porre questo limite alla violenza.41
È sufficiente questo per dire un rifiuto radicale della violenza insito nel cristianesimo? Sicuramente no.
Si è andata affinando infatti, nella tradizione, un’etica della pace dove la rinuncia della violenza esprime la grandezza di chi rifiuta la violenza sopportando ingiustizia: un agire che si mostra come comunicazione provocante l’avversario, agire che spera, in senso teologale, di fermare ogni violenza ed indurre proprio nell’avversario una sorta di inibizione alla violenza stessa.42
Infine, ancora una volta solo in un orizzonte di senso per il mondo, il discorso cristiano sull’abbandono di ogni violenza trova la sua esplicazione centrale. Come sostiene G. Piana il progetto di costruire un mondo sulla violenza conduce a proporre prima o poi la guerra, più in generale a non trovare alternative al violare il principio di non maleficenza: lo sforzo di eliminare la violenza deve richiamarsi ad un bene comune nel profondo legame tra affermazione di diritti civili e politici; superamento degli squilibri economici, sociali e culturali; dignità personale, giustizia internazionale.43
La pace è il bisogno umano di fermare il male della violenza ovvero una risposta al bisogno di sopravvivere, la necessità di tutela della vita. Essa conduce ad affermare altri bisogni, ugualmente espressioni del bene. Non è mai la violenza che porta a sopravvivere ma sempre la pace.
La tradizione cristiana invita dunque da un lato ad arginare la violenza, di proporre sempre un limite quando la violenza è presente, ma, accanto a questo limite, a guardare alla possibilità che si affermi radicalmente il principio di non maleficenza in tutto il suo valore e sorretto dall’insieme della forza “non maleficente” della fede cristiana.
Antonio Sacco
NOTE:
1 «Violenza», in Vocabolario della lingua italiana, Istituto dell’Enciclopedia Italiana - Treccani, Roma, 1994, Vol. IV, S-Z, 1189. Specificando questa definizione, dicendo “un danno”, si introduce la questione della mancanza di bene ovvero della presenza del male. La violenza è una forza che produce il male altrui.
2 Intendiamo con virtù le disposizioni operative dei soggetti che si esprimono in una serie di azioni buone e toccano le intenzionalità: habitus che rimandano poi a delle esperienze “agite” del bene medesimo, scelte dai soggetti.
3 S. Cotta, Perché la violenza? Una interpretazione filosofica, Scholé, Brescia 2018, 87. Cotta usa il concetto di valori morali, mentre in questo articolo proponiamo quello di virtù.
4 S. Cotta ribadisce che anche il riferimento ai valori per individuare la violenza è problematico. Occorrerebbe non solo un accordo sul riconoscimento dei medesimi in via storico-sociologica o giuridico-formale, ma in un’ontologia fondata in sé. Mi sembra di poter aggiungere che quest’ontologia dei valori, tuttavia, non è mai totalmente indipendente dal piano storico e fattuale e si determina nella ricerca secondo saggezza pratica degli stessi in sintonia con la prospettiva aristotelico-tommasiana: la prospettiva delle virtù è preferibile proprio per questa capacità di meglio esprimere la questione della ricerca, opera di ragion pratica, del bene nella prassi.
5 Ivi, 89.
6 H. Arendt vede ad esempio un legame tra violenza e potere, cfr. infra: “Violenza originaria?”, che sub-ordina la prima al secondo. H. Arendt, Sulla violenza, U. Guanda, Parma 1996, 55.
7 H. Arendt precisa - sulla scia delle riflessioni di G. Anders sulla forza della tecnica e sul potenziale delle armi del XX secolo che accrescono a dismisura le capacità umane in merito all’esercizio della violenza - che questa idea di mezzo non è più neutrale, ma rischia di imporsi da sé, di divenire, come ogni potenza tecnica, ineluttabile. Ivi, 95
8 Cfr. A. Sacco, La giustizia come virtù, Effatà, Cantalupa (To), 2017, 156-161. In quelle pagine il riferimento alle considerazioni espresse sul principio da J. Porter in Moral action and Christian ethics, Cambridge University Press, New York 1995.
9 Un’espressione di questo principio è presente in Tommaso: cfr. S Th I II 100,5.
10 Cfr. J. Porter, Moral Action, 55.
11 O. Aime, «Convinzione e Violenza», Archivio Teologico Torinese XXIV (1/2018), 392.
12 Il legame tra violenza e ideologia è uno degli elementi centrali che hanno favorito la violenza senza limiti. Cfr. R. Guardini, «Il Salvatore», in M. Nicoletti (ed.), Scritti Politici, Opera omnia. 6, Morcelliana, Brescia 2005, 332-340.
13 M. Walzer, Guerre giuste ed ingiuste, Editori Laterza, Bari 2009 (orig. ingl.1977), 8-9.
14 Ivi, 11.
15 Cfr. Ivi, 281-290.
16 Non mi soffermo sull’eidetica della tradizione morale sulla guerra. Rimando per un'interpretazione contemporanea ad esempio a L. Sowle Cahill, «La tradizione cristiana della guerra giusta», Concilium XXXVII (2/2001, «Ritorno della guerra giusta?»), 94–106.
17 Qui però entra in gioco il secondo elemento dell’intensità della violenza. Se usata senza “proporzioni” la forza per difendersi fa riemergere in tutta la sua drammaticità la prospettiva della realtà della violenza.
18 M. Walzer, Guerre, 407. Un’idea simile a questa era, nella tradizione, quella della guerra giusta come forza coattiva sulla base di un ordine giuridico dato ed evidente, in particolare la legge naturale. Il fine della violenza permessa era in legame ad ordine teleologico ovvero il fine della violenza per ristabilire un ordine giuridico dato ed evidente, in difesa di un bonum in commune. Un uso lecito della violenza, nella misura della proporzione, riguardava - nella forma della legittima difesa individuale, - collettiva (ius ad bellum), - del tutore (educativa se genitoriale, punitiva se dello Stato): H. Oberhem, «Violenza», B. Stoeckle (ed.), Dizionario di Etica Cristiana, Cittadella, Assisi 1978, 453.
19 M. Walzer, Guerre, 26. Anche il nazismo ha avuto bisogno di giustificare, come bene per l’umanità, l’attuazione dell’Olocausto. Naturalmente in realtà per la guerra ingiusta non siamo di fronte a dei valori umani, ma a delle ideologie.
20 Ivi, 287. L’autore prevede uno stato di eccezionalità, una sorta di principio di totalità, che può mettere in discussione questa assolutezza del non esercizio di una violenza totale. Ne discute ampiamente in Guerre giuste ed in ingiuste, 313-335, ammettendo come leciti, in parte, i bombardamenti sulle città tedesche, e la violenza sui civili, per lo stato di eccezionalità del male assoluto del nazismo che andava fermato e rifiutando sostanzialmente la violenza della bomba atomica su Hiroshima per la mancanza di questa eccezionalità.
21 C. Chiurco, «Violenza», in Enciclopedia filosofica, vol.XII, Bompiani, Milano 2006, 12148.
22 Ivi, 12150.
23 P. Giustiniani, «Violenza», in P. Benanti et al. (edd.), Teologia morale, Dizionari S. Paolo, 2019, 1160. Anche in H. Arendt, Sulla violenza, 38.
24 P. Giustiniani, «Violenza», in P. Benanti et al. (edd.), Teologia morale, Dizionari S. Paolo, 2019, 1160. Anche in H. Arendt, Sulla violenza, 38.
25 H. Arendt, Sulla violenza, 44.
26 Della minoranza “impazzita” e violenta contro qualcuno, la “maggioranza silenziosa” si fa complice: nessuno si oppone alla manifestazione della violenza.
27 C. Chiurco, «Violenza», 12152.
28 Segnaliamo tuttavia come Heidegger veda nella violenza non un positivo, ma un qualcosa da cui umanità deve affrancarsi e mettere da parte: Ivi, 12153.
29 Sono profonde le pagine che Henaff ricava dagli studi di G. Dumézil sui bambini guerrieri, segno del contrasto tra la vita e la violenza: Ivi, 20-22.
30 Sono profonde le pagine che Henaff ricava dagli studi di G. Dumézil sui bambini guerrieri, segno del contrasto tra la vita e la violenza: Ivi, 20-22.
31 Anche secondo H. Arendt l’ira, la rabbia, è generatrice di violenza. Mentre il materialismo dialettico vede la fonte di quest’ira nello sfruttamento del sistema economico capitalistico e nella violenza lo strumento per rispondervi, altri pensatori, come Sorel, Pareto e Fanon - teorici di una giustificazione della violenza come intrinseca e feconda all’interno del dinamismo sociale - vedono questa rabbia scaturire dall’ipocrisia del sistema sociale: H.Arendt, Sulla violenza, 68.
32 M.Hénaff, Figure, 27.
33 Ivi 29. Cfr. Ivi, 43-44. Viene segnalato un passaggio da una giustizia vendicatoria ad una consegna al terzo – autorità – di questo esercizio della “vendetta”. La violenza viene in parte eliminata da questo passaggio.
34 La seconda parte di Figure della violenza discute il caso del terrorismo islamico quale luogo simbolico in cui offesa, vendetta e riconoscimento sono meccanismi che scattano a sproposito e sfociano nella violenza omicida.
35 Secondo il modello “ratio practica fide illuminata” di ispirazione tommasiana.
36 Commissione Teologica Internazionale (CTI), Dio Trinità, unità degli uomini, 2014, n. 45.
37 Ivi, 48.
38 Ivi, 50.
39 Ricordiamo come storicamente questa affermazione sia spesso dimenticata in un’accettazione della violenza anche in relazione con fede stessa: cfr., ad esempio, G. Gutièrrez, Alla ricerca dei poveri di Gesù Cristo, Queriniana 1995, 134 ss.
40 Uno sviluppo di questo tema in C.M Martini, Terrorismo, ritorsione, legittima difesa, guerra e pace, Discorso per la vigilia di Sant'Ambrogio 2001, Centro editoriale Ambrosiano, Milano 2001.
41 Abbiamo sostenuto che una violenza anche coercitiva può essere compatibile con il bene ed in questo caso diventa qualcosa di diverso dalla violenza ingiusta.
42 W. Huber H. Reuter, Etica della pace, Queriniana, Brescia 1993, 322-323. Tuttavia sia M. Walzer che H. Arendt si chiedono, a questo proposito, che ne sarebbe stato della protesta non violenta di Gandhi se avesse dovuto affrontare il tiranno assoluto. Cfr. H. Arendt, Sulla violenza 58; M. Walzer, Guerre, 410. Una contestazione di queste affermazioni deriva dal paradosso di non riuscire a pensare ad una situazione alternativa alla sola violenza perché impedita dal paradigma culturale dominante, pensare la sola via violenta conduce di per sé all’affermazione della violenza: cfr S. Hauerwas, The Peaceble Kingdom: A Primer in Christian Ethics, Hymns Ancient & Modern Limited, 2003, 123-125.
43 G. Piana, In novità di vita, vol.IV, Cittadella, Assisi 2013, 583.
 IT
IT  EN
EN 
















