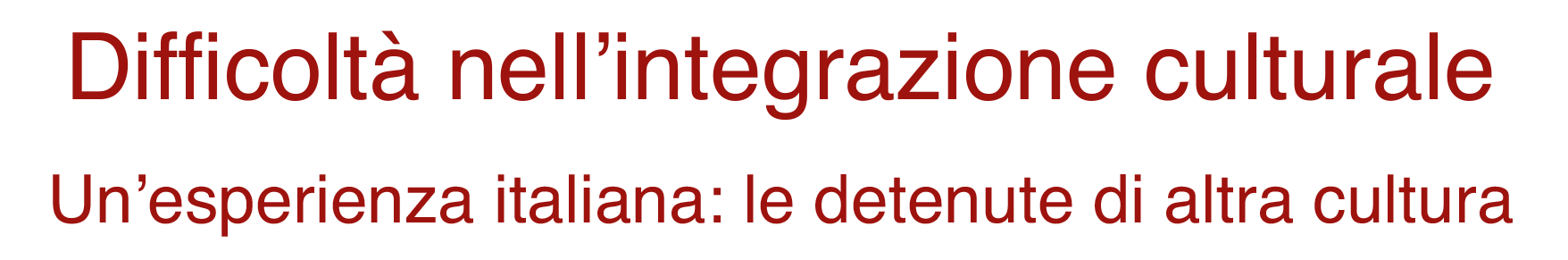

ANNA CARELLI
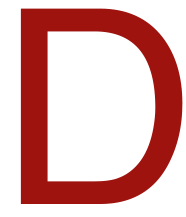
 a circa 18 anni faccio parte dell’associazione VIC Caritas (Volontari In Carcere) ed entro nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia (Roma), dove incontro e parlo con le detenute che desiderano fare colloqui. La maggior parte di queste donne sono straniere, molte vengono dall’Africa. Sono stata insegnante di inglese, sfrutto la conoscenza di questa lingua e di un po’ di francese.
a circa 18 anni faccio parte dell’associazione VIC Caritas (Volontari In Carcere) ed entro nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia (Roma), dove incontro e parlo con le detenute che desiderano fare colloqui. La maggior parte di queste donne sono straniere, molte vengono dall’Africa. Sono stata insegnante di inglese, sfrutto la conoscenza di questa lingua e di un po’ di francese.
I racconti che, a volte a fatica, a volte come un fiume in piena, vengono fatti dalle donne con cui parlo, mi fanno intravedere esperienze totalmente diverse dalla mia, situazioni difficili, spesso drammatiche che hanno determinato o comunque condizionato fortemente le vicende della loro vita. Prima di tutto l’essere nate in paesi economicamente e/o politicamente disastrati (spesso le due cose si combinano), dove i diritti sono negati totalmente, la corruzione prevale, le risorse sono depredate, le guerre continue fanno vittime (spesso ignorate dai paesi “ricchi” perché non fanno notizia sui nostri giornali). Oppure far parte di etnie (penso a quella Rom per esempio) o di gruppi (camorra, mafia) le cui “regole” condizionano profondamente e tremendamente i comportamenti, da cui è difficile prendere le distanze.
Oggi il fenomeno delle migrazioni è oggetto di dibattito continuo e ineludibile, cresce la paura di tanti di essere “invasi”, mentre molte persone di buona volontà discutono di “integrazione” e di come renderla possibile o facilitarla per chi viene da altri paesi e da altre culture. Ho cercato di approfondire il significato di questa parola, la definizione potrebbe essere: “inserirsi in un determinato contesto sociale, politico, culturale, accettandone in pieno i sistemi, i costumi, la mentalità”. È un fenomeno importante, molto complesso, difficile, che richiede tempi lunghi; che dovrebbe spingere noi “paese accogliente” a metterci in discussione, a chiederci se il sistema che vorremmo imporre ad altri sia poi così valido e “perfetto” in tutte le sue parti, tale da poter essere accettato in pieno.
Quello che mi appare chiaro è che conciliare la necessità di integrazione con il desiderio o comunque il bisogno (e il diritto!) di non tradire le proprie origini, di non rinunciare al proprio vissuto richiede tempo e fatica, specie perché la scelta è troppe volte una “non scelta”. Fuggire da un paese in guerra o dove non si riesce a sopravvivere perché la miseria è una condizione da cui non si esce, non è una decisione libera e tranquilla. Mi sono resa conto che chi viene da altri paesi a volte rimane ai margini della nostra società anche a lungo per mille motivi: la lingua, la povertà, la mancanza di relazioni e di informazioni, la nostra indifferenza.
Ho in mente molte storie dal carcere.
Quella drammatica di G., che ha perso il marito ed un figlio in un incendio provocato dai soldati di Boko Haram, è rimasta lei stessa ferita tanto gravemente da dover trascorrere molti mesi in ospedale. Ha scoperto solo alla fine della degenza che due dei suoi figli si erano salvati e vivevano in un orfanatrofio.
Quella tragica di L., che, venduta dalla famiglia troppo povera per mantenerla, è stata stuprata in Libia e ha scoperto di essere incinta solo quando è arrivata in carcere, sconvolta, incapace di parlare.
Quella di D., abbandonata dalla madre e cresciuta per strada, analfabeta, mai stata a scuola, arrivata in Italia su un barcone e finita a “lavorare” per strada.
Quella di B., che, incinta, ha attraversato il mare rimanendo per giorni su un barcone con la paura di perdere il suo bambino.
Quella di N., rimasta semi paralizzata durante una guerra in cui fuggendo non ha più trovato il marito, che si dimostra madre tenerissima di un bambino, per ora affidato ad una famiglia italiana, sempre al centro dei suoi pensieri, ed al quale manda continuamente regali.
Quella di P., che mostra la cicatrice che le attraversa la pancia, ricordo dell’operazione subita per salvarla dalla morte causata dalla rottura di un ovulo pieno di droga ingerito.
Quella di A., che in Ruanda ha assistito alla morte di tante persone care, è arrivata in carcere confusa, spaventata, non capiva dove si trovava, non sapeva se la madre fosse ancora viva, era incinta ma pensava continuamente al suo primo bambino rimasto nel suo paese e chiedeva di uscire per andare a cercarlo. Lei, con l’aiuto di tante persone, con grande fatica è riuscita a rasserenarsi, ha ricevuto notizie del figlio, è stata accolta in una casa famiglia, ha avuto il suo bambino, ed ora sta bene.
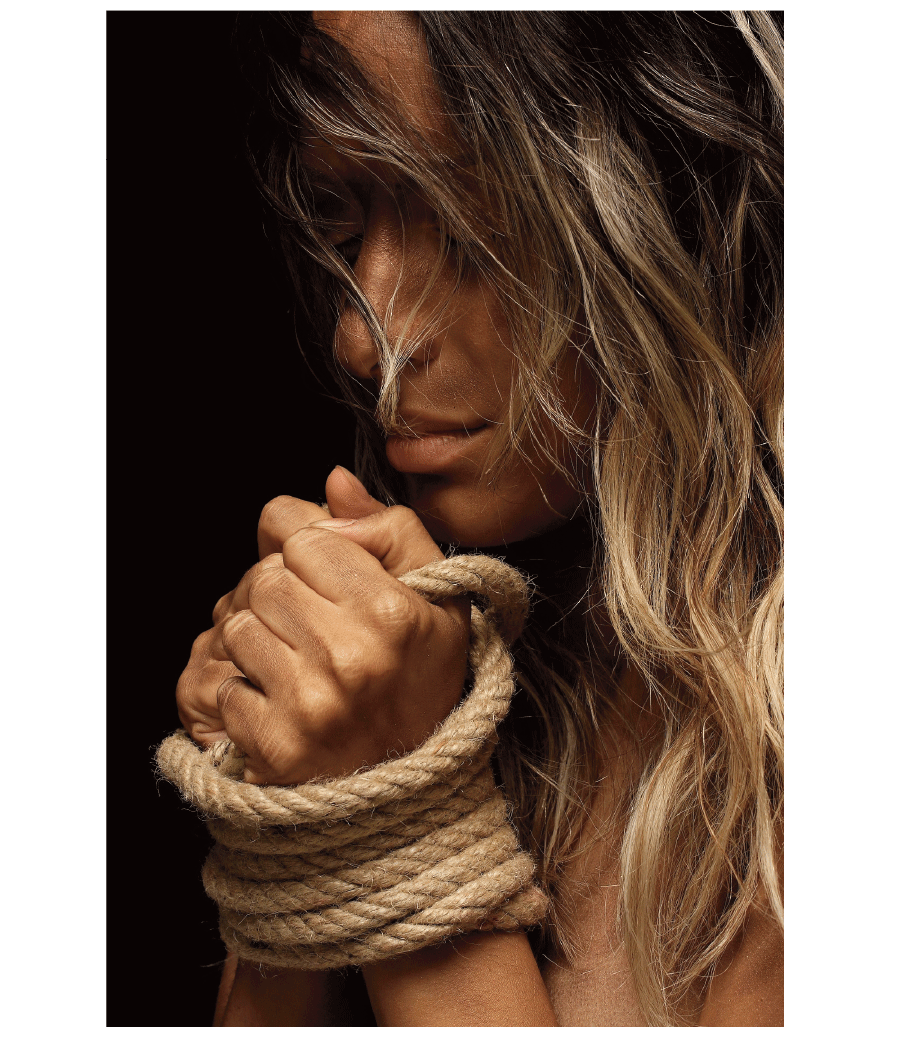 Quella di J., fuggita via mare dopo la morte del padre e del fratello in guerra, arrivata a Lampedusa, arrestata per aver manifestato contro la polizia per ottenere asilo politico (dopo veri mesi trascorsi in un centro migranti dove non succedeva niente!), terrorizzata dall’idea di essere rimandata a casa. Anche la sua è una storia a lieto fine, ha trovato lavoro come badante in una famiglia che l’ha accolta affettuosamente.
Quella di J., fuggita via mare dopo la morte del padre e del fratello in guerra, arrivata a Lampedusa, arrestata per aver manifestato contro la polizia per ottenere asilo politico (dopo veri mesi trascorsi in un centro migranti dove non succedeva niente!), terrorizzata dall’idea di essere rimandata a casa. Anche la sua è una storia a lieto fine, ha trovato lavoro come badante in una famiglia che l’ha accolta affettuosamente.
La storia di F., che, venuta con la speranza di completare i suoi studi e sfuggire alla miseria, si è trovata coinvolta in una brutta storia di prostituzione, ha pagato duramente per il suo reato (dal quale ha preso le distanze) con lunghi anni di carcere in cui anche il suo bambino innocente ha trascorso i suoi primi 3 anni. Anche lei ha trovato aiuto, una coppia generosa ha preso in adozione il suo bambino e un po’ anche lei, e con loro si è creato un rapporto di grande affetto. Adesso lavora fuori dal carcere durante il giorno, tra poco finirà di scontare la sua pena e potrà tornare alla vita libera, anche se forse continuerà ad indossare sempre pantaloni che nascondono le tante ferite che ha sulle gambe!
Voglio anche accennare alla storia di Z., rom di origine croata, abituata a scappare da scuola e rubare fin da bambina e che per questo, come tante altre, sta pagando in carcere, ma che qui ha scoperto con soddisfazione di avere delle capacità. Ha imparato cosa significa la dignità del lavoro, sente l’orgoglio di avere figli che vanno a scuola e che forse potranno integrarsi più facilmente nel nostro paese, avere una vita più tranquilla.
Tante storie di donne che hanno tentato e tentano di vivere nel nostro paese, di integrarsi nel nostro mondo facendo qualche piccolo lavoro: la parrucchiera, l’ambulante, la donna delle pulizie, la badante, il commercio di prodotti da e per l’Africa. Poi basta un contrattempo, un incontro sbagliato, la necessità di far curare un figlio o la propria madre, e i soldi, prima sufficienti per sopravvivere, diventano troppo pochi, si rimane indietro con l’affitto, si cade vittime di persone senza scrupoli che propongono un modo “facile” per superare il problema e si finisce in carcere.
Dopo anni trascorsi in detenzione è ancora più faticoso ricominciare, trovare un lavoro, superare i pregiudizi, riallacciare i rapporti con famiglie disastrate e smembrate, recuperare gli affetti che comunque rimangono forti, soprattutto nei confronti dei figli.
Il mio particolare punto di osservazione mi costringe ad interrogarmi sulla reale possibilità di “integrazione” per loro che, oltre ad avere la difficoltà di vivere in un paese diverso dal proprio, hanno commesso errori, li hanno duramente pagati e vivono situazioni di disagio. Alcune ci riescono, forse quelle più determinate, più disponibili ad accettare aiuto o semplicemente più fortunate. 
Sono convinta che ogni singolo caso che si risolve positivamente sia un arricchimento per la nostra società, spero che ci sia più spazio e comprensione nel nostro paese per queste donne o almeno per i loro bambini, e che una qualche “integrazione” diventi possibile.
 IT
IT  EN
EN 



















