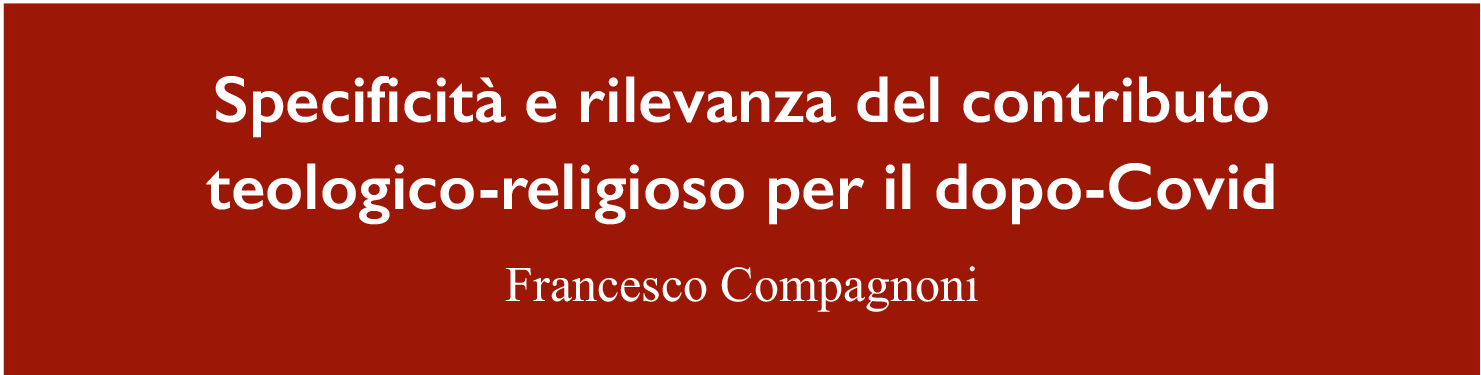
![]() Il cristianesimo ha qualche cosa (di originale) da dire in questa circostanza storica? Può dare motivazioni agli operatori e indicazioni operative di massima per le istituzioni? In base a quali premesse, teoretiche e/o storiche, il cristianesimo può essere incisivo in questa situazione?
Il cristianesimo ha qualche cosa (di originale) da dire in questa circostanza storica? Può dare motivazioni agli operatori e indicazioni operative di massima per le istituzioni? In base a quali premesse, teoretiche e/o storiche, il cristianesimo può essere incisivo in questa situazione?
Il contributo storico del cristianesimo nel superare crisi storiche paragonabili al Covid (terremoti, carestie, pesti e colera, guerre...) era solo consolatorio, quindi circoscritto al momento dato, oppure ...?
Lo stesso, con poche varianti, si potrebbe chiedere anche alle altre due Religioni del Libro, Islam ed Ebraismo.
Nella mia esperienza personale diretta una catastrofe storica paragonabile a questa Pandemia potrebbe essere l’ultima guerra mondiale. Allora l’Italia ebbe 350.000 morti ed ora dall’inizio del Covid siamo a ca. 130.000. E anche gli sconvolgimenti sociali conseguenti e collaterali si possono tranquillamente mettere a confronto.
Tra queste due catastrofi diverse generazioni hanno sperimentato cambiamenti sociali rilevanti. Dopo la fine della guerra l’Italia è diventata Repubblica e soprattutto ci siamo data una Costituzione che imposta un altro modo di fare politica rispetto a prima. In economia ci sono stati gli “Anni Gloriosi” iniziando dal 1945: dal 1950-1970 il tasso di crescita del PIL fu di 6% annuo. L’Italia ha conosciuto non solo una crescita generica del benessere economico, ma anche del benessere sociale che ci portò nel 1978 al Servizio Sanitario Nazionale (basato su universalità, uguaglianza, equità) e dal 1970 (e specialmente dal 1990) alla Cassa Integrazione Guadagni, strumenti di grande perequazione sociale.
Durante questo periodo del secondo dopoguerra i seminari cattolici erano pieni, e le associazioni laicali cattoliche contavano su masse ingenti di associati. Si pensi all’Azione Cattolica che ne contava milioni.
Poi venne il ‘68, il Vaticano II, la caduta delle ideologie per arrivare alla quarta rivoluzione industriale, quella dell’internet delle cose.
E poi, boom!, è arrivato il Covid.
Ma per fare un discorso teologico coerente, non possiamo dimenticare che dopo la Seconda Guerra Mondiale l’Italia era diventata progressivamente molto meno cattolica e cristiana che nella prima metà del secolo XX, e forse anche meno religiosa in genere. Nel nostro Paese sono passati il divorzio, “il diritto all’aborto”, il «rifiuto militante dell’omofobia», la spinta verso l’eutanasia e l’accettazione sociale delle droghe. E la riduzione epocale della natalità: dal milione di nascite nel 1960 alle 400.000 attuali. Tutti comportamenti contrari a quelli che prima erano tipici del cattolicesimo. Ricordo che in un (allora) famoso romanzo americano dell’immediato dopoguerra (“Il Cardinale” di H. M. Robinson, 1950), qualcuno affermava che i cattolici sono quelli che non abortiscono, non divorziano e non mangiano carne il venerdì.
Quello che è certo è che la presenza sociale e culturale (si pensi ai media) del cristianesimo è enormemente calata negli ultimi decenni. Come, in parallelo, sono scomparse le chiese piene della prima grande ripresa post-bellica che io ho vissuto per decenni.
Le ragioni di questa svolta, ed anche la definizione di questa fenomenale secolarizzazione, possono essere molteplici e non è qui il luogo per discuterne. Ma il fatto, pur nella mia grossolana descrizione, è innegabile1.
Dato il nuovo posizionamento sociale della chiesa nella società post-cristiana, tra i teologi morali, alla cui confraternita io appartengo, si discute molto oggi se la chiesa stessa debba proporre norme morali e oppure solo valori. Le prime sono regole etiche che vengono proposte in base all’applicazione di un valore morale a situazioni umane ricorrenti. «È moralmente proibito assumere droghe», è la «norma» che deriva dai «valori» sia del mantenimento della propria buona salute come anche del principio che è un male per la persona perdere il controllo delle proprie azioni.
La maggior parte dei colleghi è favorevole alla sola proposizione di valori morale da parte della chiesa come istituzione. Sia in nome della libertà di coscienza, che dell’impossibilità di prevedere norme sensate per le tante situazioni che si presentano nelle nostre società complesse. Non solo questo. Anche la gerarchia dei valori tra di loro, e la loro preminenza reciproca, è messa in discussione anche da pensatori cristiani, ad esempio quelli legati tradizionalmente alla sessualità o anche alla proprietà.
Noi teologi, che in definitiva proponiamo l’esperienza continua dei cristiani, ammettiamo che non deteniamo, come di fatto ritenevamo nel passato, una sorta di monopolio morale. Oggi le situazioni, i beni umani disponibili, le riflessioni comunitarie e individuali, sono talmente tante e diversificate che un “modello etico” non basta più. Si discute addirittura se sia giustificabile “UN SOLO modello etico”.
Gli altri autori di questa ricerca, specialmente gli economisti, hanno messo molto giustamente in rilevo il fatto che le nostre società sviluppate hanno come fine il progresso, l’accumulo, lo sviluppo. Per riassumere, l’aumento costante del PIL (Prodotto Interno Lordo). Di fatto tutto mira all’incremento costante del benessere legato a beni e servizi che siano monetizzabili. Trascurano al contempo – senza negarli ma riducendoli al rango di filantropia – il benessere umano integrale, cioè quei beni umani (e valori) non calcolabili col PIL2.
Per non divagare lontano del nostro tema, a me sembra che dal punto di vista dei valori cristiani - cioè dalle finalità operative che si legano in qualche modo alle credenze della nostra fede - si possa dire che attualmente è quanto mai necessaria la solidarietà. Ma perché questo non significhi semplicemente un po’ più di filantropia, direi che la solidarietà necessaria debba partire dai più poveri e demuniti sia in riferimento ai singoli, alle piccole comunità, agli Stati, alla Comunità Globale. Tenere contro sempre degli ultimi è la chiave per superare in pratica il liberismo economico e l’elitarismo sociale. Per fare questo però è necessaria una motivazione forte anche solo per cercare di mezzi per realizzarla. Infatti dal punto di vista etico classico non basta sapere cosa sarebbe teoreticamente bene fare, ma è il farlo la cosa più difficile e che esige impegno esistenziale.
Ora questa relativizzazione del nostro legame con beni/servizi materiali può nascere solo se abbiamo davanti agli occhi e al cuore un bene più grande, quello dell’incontro con il Signore alla fine della nostra vita. Potremmo chiamarla “la riserva escatologica” in quanto relativizza i beni di questa vita; non è che li annienti, ma li mette in relazione con un Bene più alto. «Relativizzazione» significa “mettere in relazione con”. Nel nostro caso significa che i miei/nostri beni materiali e servizi debbono avere la giusta relazione con quelli degli altri. Non si nega che l’energia necessaria al mio/nostro condizionatore sia un bene umano, ma si chiede che questo uso di energia sia messo in relazione con l’etica dell’ambiente, con la fame nel mondo, con la violenza internazionale necessaria per il controllo liberista delle risorse energetiche.
Ne segue però immediatamente e concretamente che la nostra vita privata e quella sociale deve essere strutturata diversamente. “Il come” in definitiva ce lo diranno gli esperti (anche quelli coinvolti in questa ricerca) ma resta che ogni soluzione porterà con sé un minor attaccamento ai beni, da parte di quelli che li possiedono, ed anche – molto probabilmente – una riduzione dei beni globali a disposizione delle comunità. Almeno all’inizio del processo di solidarietà. Non è implicita la decrescita ma certo una richiesta di sobrietà, almeno in linea di principio.
Ci tengo molto a sottolineare, come etico cristiano, al di là di quanto fin qui detto, che è strettamente necessaria una visione interdisciplinare del problema, perché come si costruisce una società più solidale e con quali mezzi, non è competenza dell’etica, bensì degli esperti e di politici eticamente motivati. Motivati soprattutto per “tener duro” perché il percorso si prevede lungo e combattuto. E sempre da rilanciare, da completare, da reinventare.
Ma anche sarà necessario, proprio per la “riserva escatologica”, non sviluppare progetti utopistici e rivoluzionari, tendenti a risolvere una volta per tutte il problema della giustizia sociale. Noi cristiani sappiamo che la perfezione dell’uomo non è di questo mondo e che la nostra vita è solo la strada per giungere alla meta che è l’incontro con il Signore alla fine.
Questo incontro però non relativizza il percorso terreno, perché esso è la via dell’uomo per diventare sé stesso, sia individualmente che socialmente. E il percorso su queste strade non può essere quello del Ricco Epulone (Luca 16, 19-31), ma deve ispirarsi strutturalmente (non solo individualmente) al modello del Buon Samaritano (Luca 10, 25-37). Non per nulla Papa Francesco ha messo questo racconto evangelico al centro dell’enciclica “Fratelli Tutti”. Noi cristiani sappiamo che l’uomo è stato creato in libertà affinché viva in comunità e raggiunga, con la pienezza del proprio essere, l’incontro con Dio. Quello che preghiamo nella “Salve o Regina”, “dopo questo esilio” è una forma – poetica – per dire che non tutto finisce qui, e che crediamo che il ricongiungimento con il nostro Padre Celeste non sia l’unico scopo della nostra vita indipendentemente da come l’abbiamo vissuta.
Per mediare, in qualche modo, tra queste considerazioni altamente astratte, e l’impegno degli esperti e dei politici, possiamo tener presente pochi riferimenti essenziali. Prima di tutto aver presente l’orientamento generale ai “Diritti Umani”, e subito dopo, più concretamente, all’Agenda 2030 dell’ONU, con i suoi 17 goals. E non dimentichiamo, a livello di indicazioni valoriali, quanto Papa Francesco ha avanzato sia nella Laudato si’ (2015) che nella Fratelli Tutti (2020).
Ci si potrebbe chiedere alla fine: ma dov’è lo specifico cristiano in tutto questo?
Per capirci dobbiamo tener presente che per i cristiani il comportamento etico proposto è stato considerato nella storia non come specifico del nostro gruppo religioso, ma strutturalmente adeguato a tutti gli esseri umani. È la celebre teoria della “legge naturale”, che può oggi essere accettata o respinta, ma che vuole sostanzialmente sottolineare che l’umanità di ogni persona è sempre la stessa, nel suo profondo. E che caso mai ai cristiani è richiesto di “andare oltre” a quello che la società nella quale vivono ritiene buono, ma sulla stessa linea di avanzamento possibile e adeguata ad ogni persona umana.
In definitiva i cristiani credono che il Signore ci assiste nelle scelte morali singole e generali - la Grazia - ma essendo cittadini di questo mondo sanno che la stessa nostra natura umana ci fa intuire che è bene essere solidali e inclusivi. E non solo per utilità a medio e lungo termine, ma per l’amicizia sociale, la concordia, la pace, che tutte le culture ritengono scopi ultimi della vita associata.
I cristiani, più degli altri (anche nell’opinione popolare), devono essere portatori di valori e soluzioni etiche elevate, ma che siano accettabili anche dagli altri. L’accettazione sociale di valori/norme è indispensabile per la vita sociale mediamente pacifica. Questa si può ottenere tramite leggi appropriate, ma soprattutto con la testimonianza attiva di minoranze qualificate, come i gruppi sociali motivati dal punto di vista religioso.
Sullo sfondo di queste semplici riflessioni c’è evidentemente una visione positiva delle possibilità umane a medio e lungo termine, pur associata a quella della realtà del peccato/errore morale sia individuale che sociale. In questo senso si intravede sempre la possibilità di ripartire, di tornare a vedere e far il bene, di sviluppare gli aspetti migliori della nostra umanità.
Questo ottimismo è generato dalla fiducia in un Dio buono e misericordioso, ma anche basato sull’esperienza storica che rileva negli ultimi due secoli un percorso di maggior responsabilità e libertà degli uomini e delle donne di oggi, rispetto ad epoche e culture passate.
Ne segue che non possiamo permetterci di pensare che in fondo, poi, tutto va o torna a posto. E questo perché ogni persona, ogni generazione, ha un proprio percorso ed una propria missione: non può semplicemente attendere, o sperare, che tutto sarà in ordine per i propri nipotini. La possibilità che questo avvenga è legata strettamente all’impegno, grande o piccolo, delle generazioni che precedono le altre. Nelle vicende umane, l’oggi prepara il domani, e il domani orienta l’oggi. Senza trascurare il peso dello ieri.
Resta infine da considerare che per ognuno di noi quello che facciamo o tralasciamo nella nostra vita è definitivo ed unico, sia in relazione a noi stessi che agli altri. È per realizzare questa presenza nella storia degli uomini che siamo nati: realizzare il bene umano nostro e degli altri. Lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato è la nostra impronta positiva sul nostro tempo, ed è il motivo per i quale siamo stati posto nel mondo e nella storia dal Signore.
Francesco Compagnoni
NOTE:
1 Corsera 19.02.21- Intervista di Aldo Cazzullo al Card. Ruini: La Chiesa italiana oggi è in declino? La sua autorevolezza, la sua influenza sulla società sono in declino?
«Purtroppo un certo declino è innegabile. Le cause sono molte. La principale è la forza della secolarizzazione, anzi della scristianizzazione che attraversa le società occidentali e si allarga anche oltre; ad esempio in America Latina. Non dobbiamo però rassegnarci, tanto meno disperare. Occorre insistere nell’evangelizzazione e prendere posizioni chiare, coraggiose e realistiche sui problemi che interessano alla gente. Soprattutto, dobbiamo aver fiducia nel Signore che non abbandona il suo popolo».
Cf per il riscontro sociologico:
R. Cipriani, L'incerta fede. Un’indagine quanti-qualitativa in Italia, Franco Angeli, Milano 2021.
F. Garelli, Gente di poca fede: Il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio, Il Mulino, Bologna 2020.
2 Cf. https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità/la-misurazione-del-benessere-(bes)/gli-indicatori-del-bes
 IT
IT  EN
EN 











