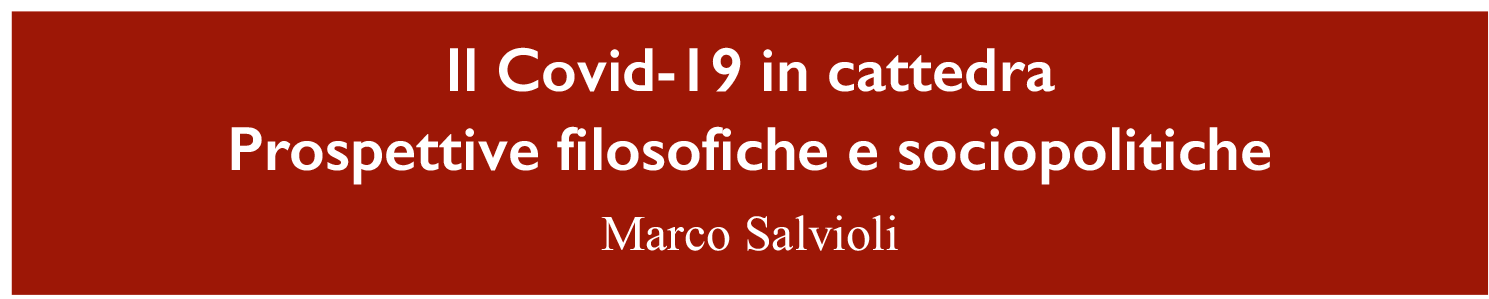
![]() Lo scatenarsi del Covid-19 su scala globale ha fatto impietosamente riemergere la vulnerabilità dell’essere umano, proprio nei confronti di quella realtà naturale che si riteneva per tanti versi domata dalla tecnica. Il coronavirus SARS-CoV-2 non ha infatti scatenato una semplice pandemia, ma – come ha puntualizzato Richard C. Horton, editor-in-chief del Lancet – una vera e propria sindemia, ossia un intreccio di patologie con gravi conseguenze economiche e sociali1. È questo tratto sistemico che suscita l’interrogazione filosofica e sociopolitica, così come lascia intendere che occorra far tesoro – per utilizzare una metafora valorizzata da Edgar Morin – della spietata lezione impartita dalla cattedra globale su cui è salito questo virus particolarmente aggressivo2.
Lo scatenarsi del Covid-19 su scala globale ha fatto impietosamente riemergere la vulnerabilità dell’essere umano, proprio nei confronti di quella realtà naturale che si riteneva per tanti versi domata dalla tecnica. Il coronavirus SARS-CoV-2 non ha infatti scatenato una semplice pandemia, ma – come ha puntualizzato Richard C. Horton, editor-in-chief del Lancet – una vera e propria sindemia, ossia un intreccio di patologie con gravi conseguenze economiche e sociali1. È questo tratto sistemico che suscita l’interrogazione filosofica e sociopolitica, così come lascia intendere che occorra far tesoro – per utilizzare una metafora valorizzata da Edgar Morin – della spietata lezione impartita dalla cattedra globale su cui è salito questo virus particolarmente aggressivo2.
1. Chomsky: il Covid-19 e la crisi del neoliberalismo
Noam Chomsky riconosce negli effetti provocati dall’emergenza virologica un sintomo della più ampia crisi di civiltà, relativa all’assetto politico-sociale neoliberale attestatosi in Occidente da almeno quarant’anni. Questa crisi si palesa innanzitutto nell’incapacità mostrata dal “capitalismo incontrollato” di rispondere alle esigenze della popolazione e reclama tanto la fine di un processo quanto il darsi di un nuovo inizio sociopolitico. In forza dell’ideologia neoliberale, la sfera pubblica è stata infatti quasi ridotta all’irrilevanza, mentre l’azione dello Stato – come ha mostrato l’altra crisi di sistema, ossia la Grande recessione del 2007-2008 – viene invocata solo per emettere moneta a vantaggio delle grandi banche, per tutelare gli interessi dei grandi gruppi petroliferi o farmaceutici e per finanziare l’industria bellica. Per il noto linguista americano, fin dalla prima minaccia epidemiologica globale del XXI secolo (SARS 2003), puntualmente denunciata dall’OMS, il governo USA e le multinazionali farmaceutiche erano avvertite dell’alta probabilità di un imminente evento pandemico. I profitti previsti e le convenienze politiche non erano, tuttavia, tali da giustificare un impegno significativo nella prevenzione. Il conflitto che si è così verificato tra l’esigenza della prevenzione e l’obiettivo della massimizzazione del profitto, con la vittoria di quest’ultimo criterio, mostra almeno due elementi patogeni d’ascendenza neoliberale di cui soffre l’attuale ordinamento sociopolitico ed economico. Mi riferisco, in particolare, alla condivisione generalizzata della tesi di Milton Friedman per cui l’unica responsabilità sociale dell’impresa sarebbe quella di aumentare i profitti dei propri azionisti3 e delle dottrine aziendalistiche orientate all’ottimizzazione dell’efficienza, che hanno diffuso pratiche come quelle del “servizio just-in-time” volte a ridurre al minimo l’accumulo di scorte. Per il linguista statunitense, in definitiva, l’errore fondamentale è consistito nell’aver accettato – almeno dai tempi di Regan – il trasferimento del processo decisionale «al mondo degli affari dedito al profitto privato e svincolato dell’influenza di coloro che potrebbero essere interessati al bene comune»4. Se il Covid-19 ha tolto legittimità all’incantesimo neoliberale, il nuovo inizio che Chomsky auspica chiede che s’immagini un’alternativa percorribile. Questa dovrà comportare il ridimensionamento dell’influenza sui governi delle grandi corporations a favore del benessere effettivo della popolazione e il passaggio dalla competizione hobbesiana tra gli stati ad un’autentica cooperazione. Pienamente condivisibile, questa visione dovrebbe essere a mio avviso integrata dall’umanesimo rigenerato proposto da Morin in opposizione alla deriva neoliberale, che procede dalla «coscienza della comunità di destino degli umani»5, capace di concretizzare l’universalismo astratto e formale del capitalismo globale.
2. Agamben: un laboratorio per nuove forme dispotiche?
Applicando alla crisi virologica alcuni concetti elaborati nel corso della propria ricerca filosofica, Giorgio Agamben avanza una tesi tanto radicale, quanto controversa: indipendentemente dalla realtà della pandemia, coloro che governano il mondo la stanno usando come pretesto per allestire un «laboratorio in cui si preparano i nuovi assetti politici e sociali che attendono l’umanità»6. Richiamandosi alla definizione del sovrano elaborata dal giurista Carl Schmitt ed implicitamente all’ordine politico insediatosi in Germania nel 1933, Agamben sostiene l’attuale sperimentazione miri ad abbandonare l’assetto delle democrazie borghesi, attraverso la normalizzazione dello «stato di eccezione, cioè la pura e semplice sospensione delle garanzie costituzionali». Questa strategia consiste nell’aggirare il potere legislativo a forza di decreti governativi, con l’obiettivo di far implodere surrettiziamente la divisione dei poteri a favore del dispositivo governativo della biosicurezza che Agamben ritiene di riconoscere – quantomeno ad uno stadio sperimentale – proprio nell’Italia colpita dal Covid-19. Sfruttando lo stato di paura diffusa, quello che ad esempio era il più che giusto «diritto del cittadino alla salute» viene trasformato in una sorta di «obbligazione giuridico-religiosa che deve essere adempiuta a qualsiasi prezzo»7, in primis quello della limitazione delle libertà fondamentali. Una società che vive costantemente in stato d’eccezione non può letteralmente essere una società libera, come si può intuire anche dall’osservazione della radicale mutazione dei rapporti sociali che si sta realizzando. Quando il prossimo è percepito come un untore in potentia, i rapporti interpersonali tendono a degenerare, mentre le connessioni virtuali sostituiscono progressivamente i contatti interpersonali e le occasioni di aggregazione, al punto da far pensare che chi non sarà reperibile in rete verrà di fatto escluso dalla vita sociale. Non si tratterebbe qui di dissolvere il tessuto sociale reale per consolidare l’attuale iperindividualismo, ma – sulla scorta di Massa e potere di Elias Canetti – Agamben ritiene che si voglia piuttosto ottenere «una massa rarefatta e fondata su un divieto, ma proprio per questo, particolarmente compatta e passiva»8. Se si considera poi che l’autentico sfondo dell’ondata di panico suscitata dalla diffusione del Covid-19 è costituito dalla miseria valoriale, per cui «la nostra società non crede più in nulla se non nella nuda vita» alla cui conservazione si possono sacrificare «le condizioni normali di vita, i rapporti sociali, il lavoro, perfino le amicizie, gli affetti e le convinzioni religiose e politiche»9, si delinea sempre più chiaramente un quadro hobbesiano in cui la tirannia del Leviatano s’attesta al prezzo della conservazione della sola esistenza biologica. Una trasformazione sociale non si può tuttavia attuare senza l’apporto della religione. Nel contesto contemporaneo, secondo il filosofo, la Chiesa non è più in grado di soddisfare il persistente bisogno di religione, il quale viene intercettato dalla scienza e, in particolare, dalla medicina. La «religione medica», che si afferma nel silenzio delle «due religioni che sembravano reggere l’Occidente, il cristianesimo e il capitalismo, la religione di Cristo e la religione del denaro»10, presenta almeno cinque caratteristiche che la rendono particolarmente funzionale all’avvento di un nuovo dispotismo. Questa religione (a) non ha innanzitutto bisogno di una dogmatica speciale, in quanto i suoi “teologi” – ossia i “virologi” – operano prendendo a prestito i concetti fondamentali dalla biologia, sullo sfondo di un impianto gnostico-manicheo: un dio/principio maligno (malattia) e un dio/principio buono (guarigione). Essa poi (b) si avvale dell’insieme delle pratiche adottate per il contenimento del contagio per un’ininterrotta celebrazione cultuale, volta ad abbracciare la vita intera. Questa pratica cultuale (c) dev’essere normativamente obbligatoria e il potere profano è pertanto chiamato a vigilare affinché la liturgia della religione medica venga puntualmente osservata. Esprimendo a suo modo la semantica della “fine” e l’atmosfera “apocalittica”, tale religione (d) riprende l’istanza escatologica lasciata cadere dal cristianesimo, alludendo ad «un eschaton in cui la decisione estrema è sempre in corso e la fine viene insieme precipitata e dilazionata»11. Ciononostante, (e) la religione medica – a differenza del cristianesimo e in parte del capitalismo – non offre prospettive di salvezza e di redenzione definitiva, in quanto il virus non può essere eliminato e muta assumendo sempre nuove forme. Per Agamben è quantomeno doveroso resistere infine al pervasivo «dispotismo tecnologico-sanitario»12, che si sta instaurando – esauritasi la forza trainante del terrorismo – attraverso l’«invenzione di un’epidemia»13.
3. Žižek: nella catastrofe… verso una nuova solidarietà
La prospettiva elaborata da Slavoj Žižek si dipana com’è noto tra filosofia, psicanalisi d’orientamento lacaniano e critica politica di ascendenza marxista; nell’affrontarne le osservazioni sociopolitiche sulla sindemia occorre pertanto tener presente questa complessa strategia analitica. Secondo il pensatore sloveno «le epidemie virali ci rammentano la contingenza ultima e l’insensatezza della vita»14, in quanto gli effetti devastanti provocati da un parassita apparentemente irrilevante fanno emergere quanto poco conti l’uomo nell’ordine reale delle cose. Questa consapevolezza produce un vero e proprio trauma al quale Žižek ritiene di poter applicare le cinque fasi – negazione, rabbia, negoziazione, depressione e accettazione – impiegate per descrivere il decorso psicologico dei malati terminali da Elisabeth Kübler-Ross15. La pandemia comporta poi alcuni paradossi che mettono in luce i punti deboli dell’attuale tecnocrazia globalizzata: da un lato, infatti, «più il nostro mondo è connesso, più un disastro locale può scatenare una catastrofe globale» e, dall’altro, «siamo più indipendenti dalla natura e al tempo stesso più vulnerabili di fronte ai suoi capricci»16. Per rispondere agli effetti spaesanti e spesso letali del Covid-19, occorre una radicale svolta sociopolitica. In polemica col neoliberalismo ancora egemone, Žižek ritiene che «in un’epoca di pandemia è necessario uno Stato forte»17, tale da poter ottenere la fiducia dei cittadini, nel momento in cui i meccanismi del mercato si mostrano ampiamente insufficienti per frenare il caos e la fame. Quanto ai populismi, risulta ovvio che non vi dovrebbe essere più posto per la strategia dell’America first nel contrastare un virus che contagia l’intera umanità. Rispetto poi alla “postura” da tenere nell’applicazione delle misure di contenimento del contagio, Žižek invita a riscoprire l’humanum al di là della mascherina («guardare profondamente l’altro negli occhi può rivelare più di un contatto intimo»18) proprio nel rispetto del distanziamento sociale («rispettare una certa distanza fisica potrà persino rafforzare l’intensità del legame con gli altri»19). Le misure governative non vengono qui interpretate come una mera limitazione della libertà individuale, ma come un deciso invito a prendersi responsabilmente cura dell’altro, proteggendolo dal contagio di cui si potrebbe essere un tramite inconsapevole, perché asintomatico. Il primato così attribuito alla custodia della salute altrui fa tutt’uno con una puntuale risposta alla critica dell’ideologia sviluppata da Agamben, proprio a partire dal riconoscimento della realtà del virus. Un’«interpretazione sociale del genere», commenta Žižek con una certa ironia, «non fa certo sparire la realtà della minaccia»20. Più in generale, per il pensatore sloveno è ormai chiaro che «sia la destra alternativa (alt-right) sia la sinistra fasulla rifiutano di accettare appieno la realtà dell’epidemia, ed entrambe la mitigano in un esercizio di riduzione socio-costruttivista, ovvero denunciandola in nome del suo significato reale»21.
L’analisi qui condotta manifesta la consapevolezza che la pandemia sia un sintomo, assolutamente non sottovalutabile, della necessità di un radicale cambiamento di sistema rispetto al modo con cui si è pensata la globalizzazione. È pertanto altamente auspicabile, secondo Žižek, che a fronte dell’egemonia neoliberale si diffonda piuttosto «un virus che ci faccia immaginare una società alternativa, una società che vada oltre lo Stato-nazione e si realizzi nella forma della solidarietà globale e della cooperazione»22.
4. Parsi: E dopo? Conservazione, involuzione, rinascita
Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), interviene nel dibattito tratteggiando tre scenari che si potrebbero aprire alla risoluzione dell’emergenza Covid-19, a partire dalla ritrovata consapevolezza della vulnerabilità umana. Se la rivoluzione informatica aveva eclissato tale consapevolezza, la pandemia ci sfida ad elaborare un’alternativa sociopolitica ed economica che proceda sulla base di una solidarietà, intesa come impegno di proteggere i più deboli, la cui vulnerabilità dovrebbe diventare l’«elemento intorno a cui ripensare e ricostruire l’interdipendenza»23. Anche Parsi, sebbene molto più diplomaticamente, ritiene quindi che la pandemia abbia mostrato come la via neoliberale non sia più percorribile: «sia pure confusamente e talvolta contraddittoriamente, abbiamo riscoperto che le autorità politiche possono imporre la salvaguardia del bene comune sulla protezione dell’utile individuale»24. Benché timidamente, si torna a pensare che l’economia possa essere collocata all’interno di finalità che la politica dovrebbe essere in grado di riconoscere e proporre. (1) Lo scenario della Restaurazione è il primo ad essere descritto: per quanto sia facilmente ipotizzabile un lungo periodo di tempo per uscire dalla recessione economico-sociale globale, le dinamiche internazionali non verrebbero qui sconvolte dall’impatto del Covid-19. Si cercherà semplicemente di trovare soluzioni sul piano sanitario e rilanciare la crescita. Preoccupazioni legittime che aggraverebbero, tuttavia, l’enorme conflitto che la pandemia ha finito per evidenziare, ossia «la questione della produzione e della sua remunerazione tra capitale e lavoro». La Restaurazione non giungerebbe tuttavia a risolvere tale conflitto, in quanto essa comporterebbe «un ulteriore slittamento verso un’interdipendenza in cui il mercato si dilata sempre più a scapito della democrazia»25, nella forma di una deriva tecnocratica che verrà imposta dai governi. Una possibile ricaduta dei provvedimenti adottati per contenere il contagio consisterà infatti nella facilità con cui l’esecutivo potrà legittimare determinate scelte, compiute aggirando il controllo democratico, sulla sola base di motivazioni tecniche attinte alle valutazioni degli esperti. (2) Per definire il secondo scenario Parsi s’ispira alla Fine dell’Impero romano d’Occidente. La divisione globale del lavoro, realizzata finora attraverso una consistente delocalizzazione, verrebbe sostituita da una diffusa regionalizzazione in cui le nazioni uscite dalla pandemia più o meno simultaneamente verranno a coalizzarsi a livello economico. Questa contrazione, unita al dilagare della paura, comporterebbe poi il pericolo concreto di una crescita surrettizia della diffidenza reciproca a scapito dell’auspicata solidarietà e, dal punto di vista politico, la possibilità di una concomitante involuzione autoritaria dei regimi democratici che sarebbero guidati da leader “forti” alla testa di movimenti populisti (sul modello di Viktor Orbán). Una popolazione sfinita dal corpo a corpo col Covid-19 e dalla conseguente crisi economica potrebbe essere facilmente preda dell’illusione hobbesiana, soprattutto se manipolata mediaticamente, per cui apparirebbe conveniente cedere quote di libertà individuale in cambio di maggior sicurezza. (3) Lo scenario ampiamente più auspicabile è infine quello del Rinascimento, che prevede «una ricostruzione che parta dalla presa d’atto della vulnerabilità umana, dal riconoscimento della sua centralità e ineluttabilità, e inizi a sostituire l’interdipendenza delle cose con l’interdipendenza degli umani»26. Si tratterebbe di una trasformazione complessiva di sistema a partire dalla ritrovata centralità del fattore umano, che comporterebbe l’abbandono del modello neoliberale angloamericano per rilanciare un modello ispirato ad un New Deal aggiornato: dare abbastanza a chi ha troppo poco, invece di incrementare la ricchezza di chi ha molto (F. D. Roosevelt). In definitiva, la più grande lezione che dovremmo apprendere dalla crisi provocata dal Covid-19 consisterebbe così nell’operare convintamente – esprimendomi con le parole di Parsi che possono riassumere, per certi versi, anche i desiderata di autori molto più radicali come Chomsky e Žižek – «un riequilibrio del rapporto tra politica ed economia, tra democrazia e mercato, tra libertà e solidarietà»27. Realizzare questo cambiamento di rotta significherebbe anche, almeno in modo implicito, rispondere a livello sociopolitico alla domanda cruciale risollevata nel pieno dell’emergenza sanitaria e che corrisponde, in realtà, al non-detto che costituisce il basso continuo dell’attuale assetto capitalistico neoliberale: «fino a quando potremmo permetterci di dire che una vita umana non ha prezzo»28? La lezione che dovremmo apprendere dalla sindemia scatenata dal SARS-CoV-2 consiste almeno nell’essere consapevoli che non si può rispondere adeguatamente a questo drammatico interrogativo prima di aver ricollocato, a differenza di quanto è accaduto negli ultimi quarant’anni, il plesso economico-finanziario a servizio dell’uomo.
Marco Salvioli
NOTE:
1 Cfr. R. Horton, Offlin: COVID-19 is not a pandemic, in The Lancet 396, 26 (2020) 874.
2 Cfr. E. Morin, Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus, con la collaborazione di S. Abouessalam, Raffaello Cortina Editore, Milano 2020.
3 Cfr. M. Friedman, Capitalismo e libertà, IBL Libri, Torino 2010, 205-206 (ed. or. 1962) e Id., The Social Responsibility fo Businness is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, 13 September 1970.
4 N. Chomsky, Crisi di civiltà. Pandemia e capitalismo, Interviste di C. J. Polychroniou, Ed. it. a cura di V. Nicolì, Ponte alle Grazie, Milano 2020, 14.
5 E. Morin, Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus, 37. Per la critica al neoliberismo, cfr. ivi, 40-41.
6 G. Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Quodlibet, Macerata 2020, 23.
7 Ivi, 7.
8 Ivi, 24.
9 Ivi, 14.
10 Ivi, 22.
11 Ivi, 38.
12 Ivi, 9. Per una critica a quest’interpretazione eccessivamente monolitica dell’odierno potere sovrano, si veda il contributo – per altro ampiamente ispirato dalla riflessione di Agamben – offerto da D. Di Cesare, Virus sovrano? L’asfissia capitalistica, Bollati Boringhieri, Torino 2020, in part., 26-29.
13 Ivi, 10.
14 S. Žižek, Virus. Catastrofe e solidarietà, Ponte alle Grazie, Milano 2020, Kindle edition, pos. 100.
15 Cfr. E. Kübler-Ross, La morte e il morire, Cittadella, Assisi 1976.
16 S. Žižek, Virus. Catastrofe e solidarietà, pos. 195.
17 Ivi, pos. 127.
18 Ivi, pos. 38.
19 Ivi, pos. 47.
20 Ivi, pos. 386.
21 Ivi, pos. 403.
22 Ivi, pos. 283. Per un ulteriore sviluppo del combinato disposto di solidarietà e responsabilità, cfr. E. Morin, Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus, 63.
23 V. E. Parsi, Vulnerabili: come la pandemia cambierà il mondo. Tre scenari per la politica internazionale, Piemme, Milano 2020, 4.
24 Ivi, 11.
25 Ivi, 33.
26 Ivi, 49.
27 Ivi, 60. Cfr. anche S. Maffettone, Il quarto shock. Come un virus ha cambiato il mondo, Pref. di G. Lo Storto, Luiss University Press, Roma 2020.
28 Cfr. The Economist (April 4th-10th 2020), che titolava A grim calculus. The stark choices between life, death and the economy.
 IT
IT  EN
EN 











