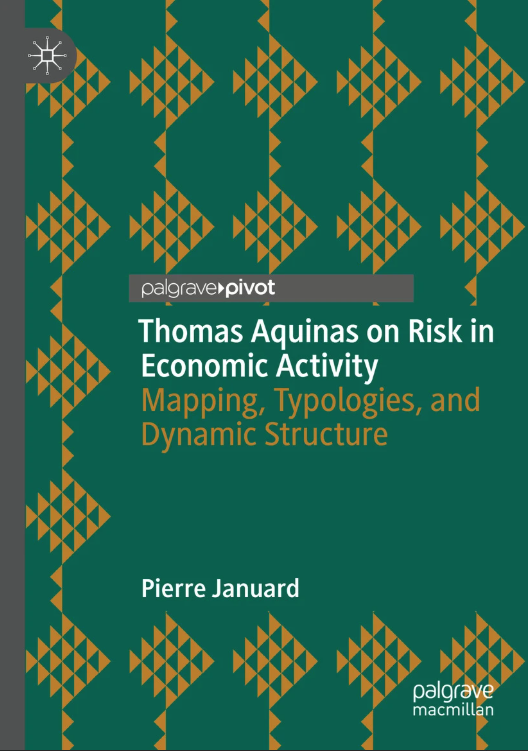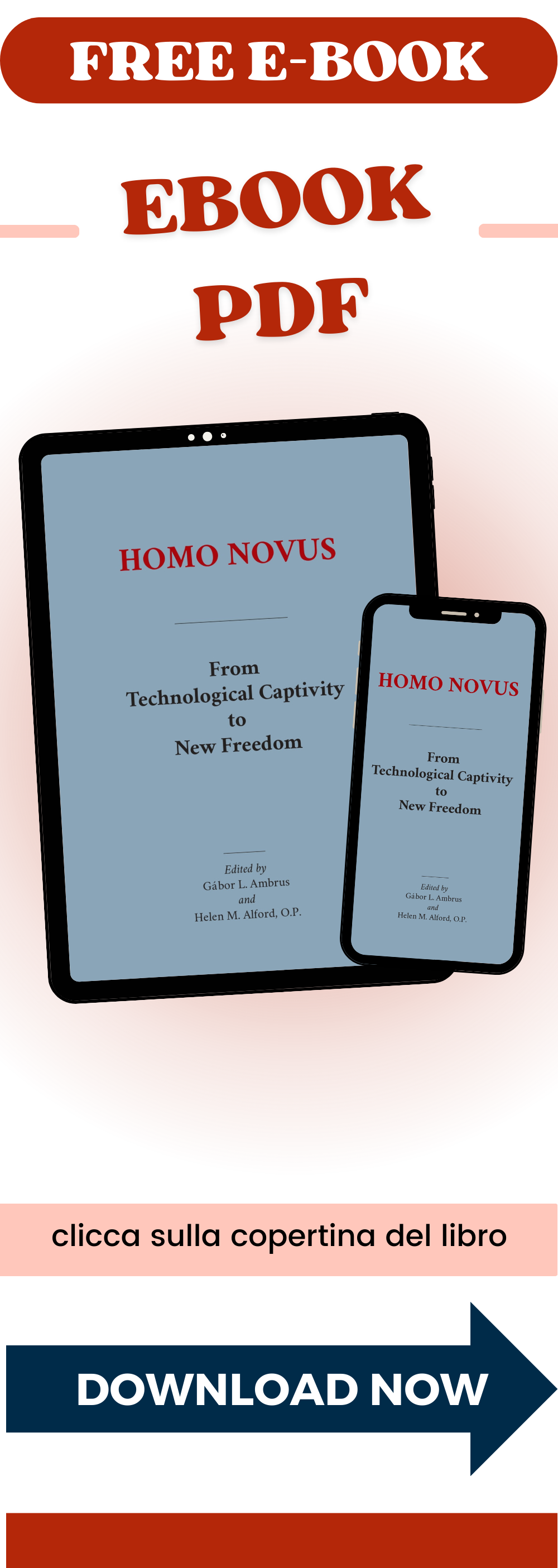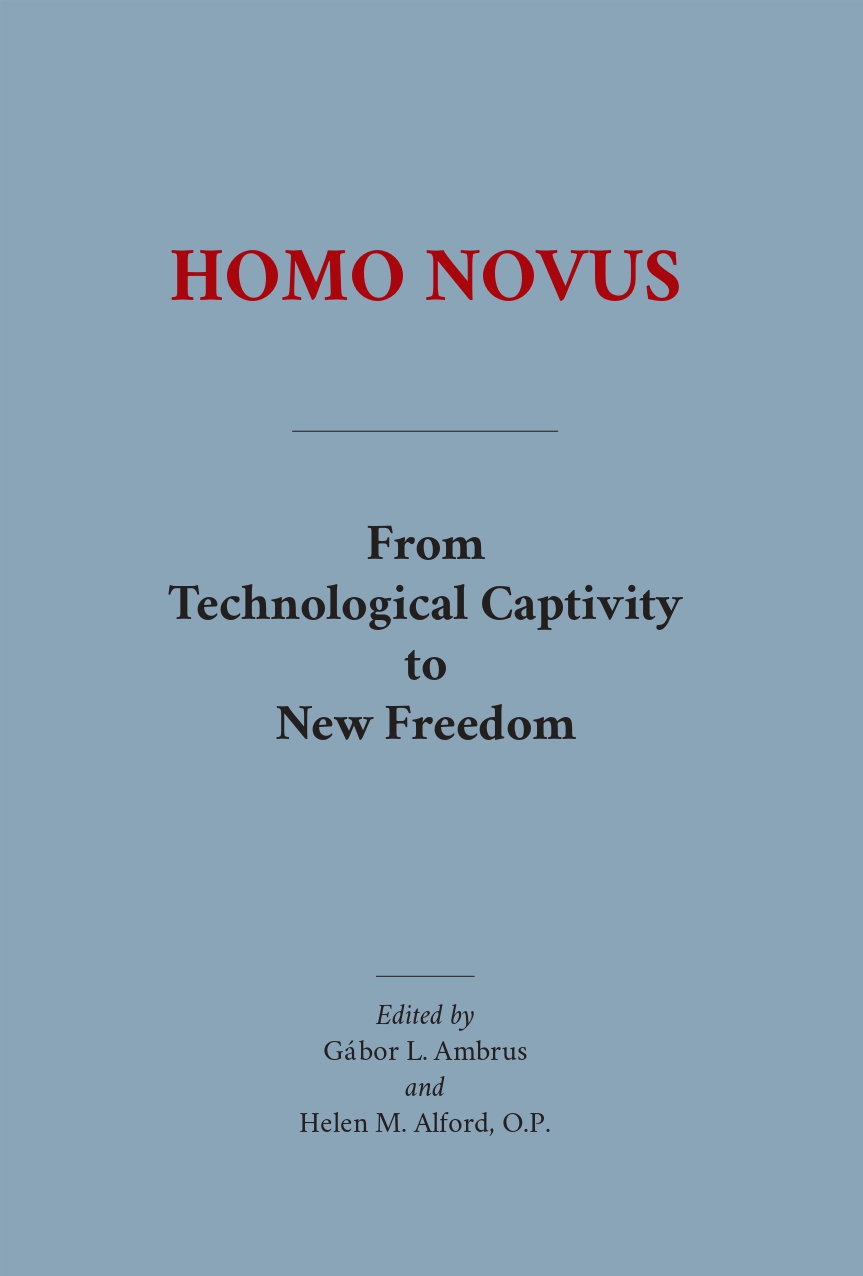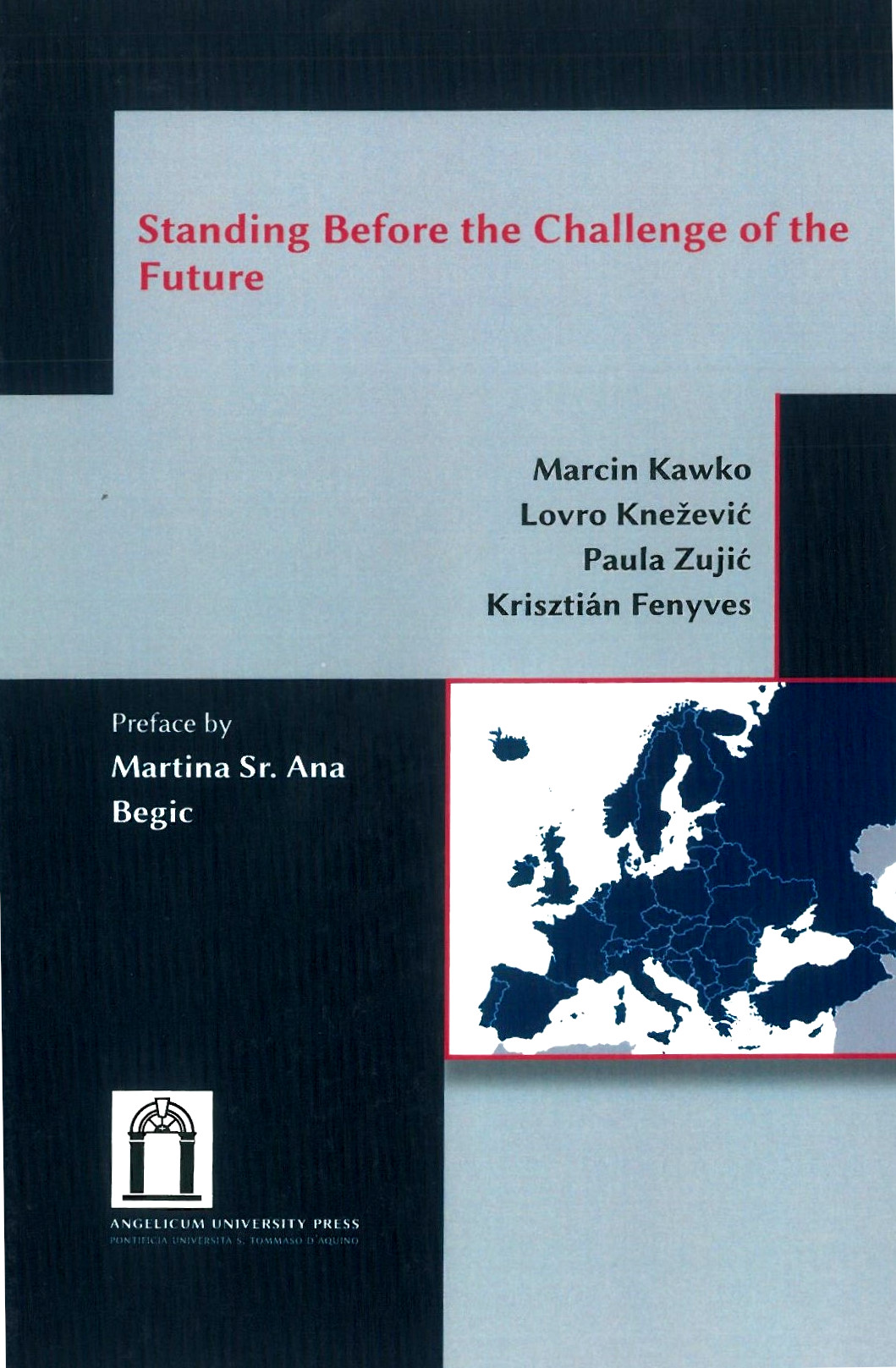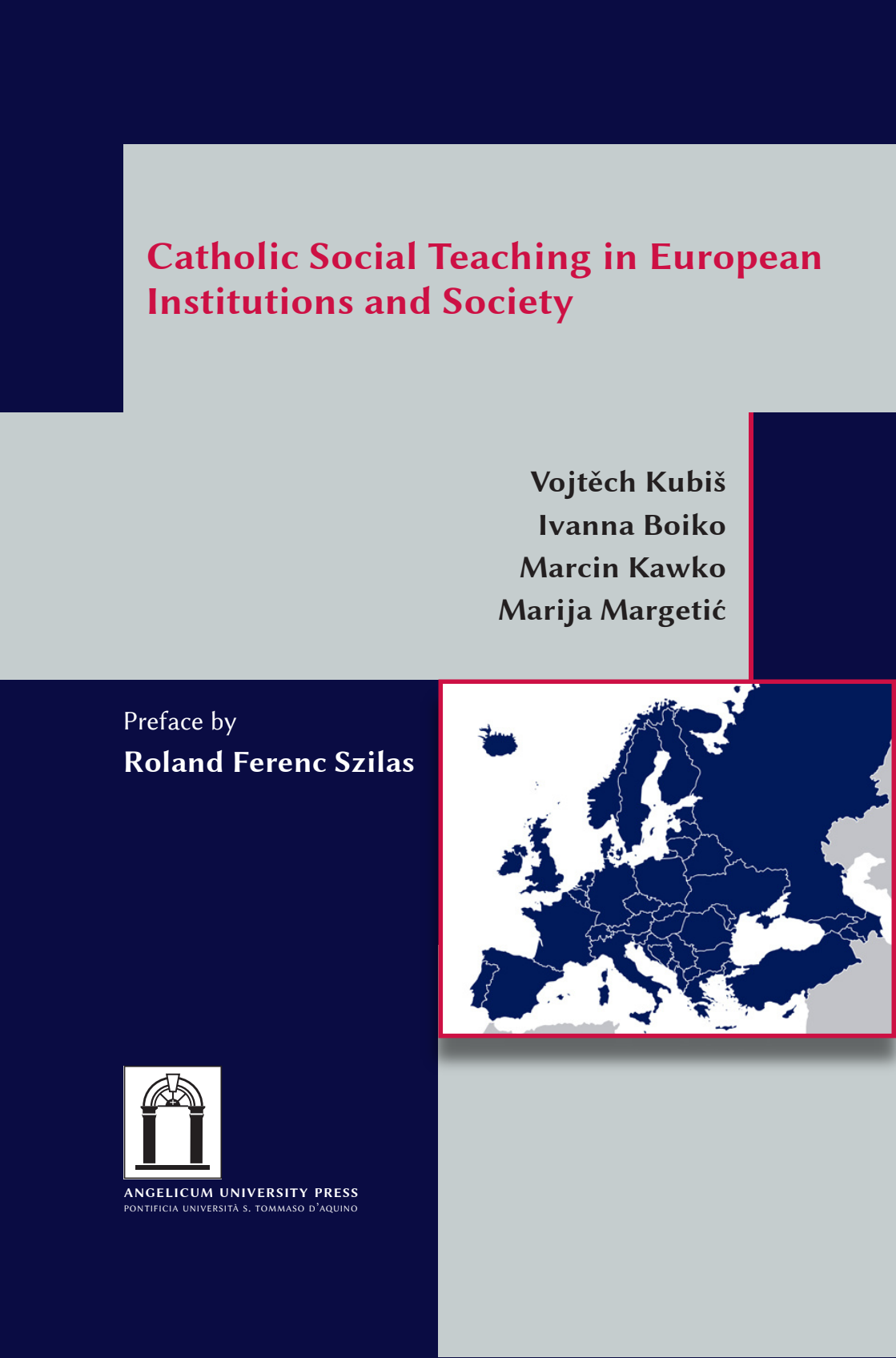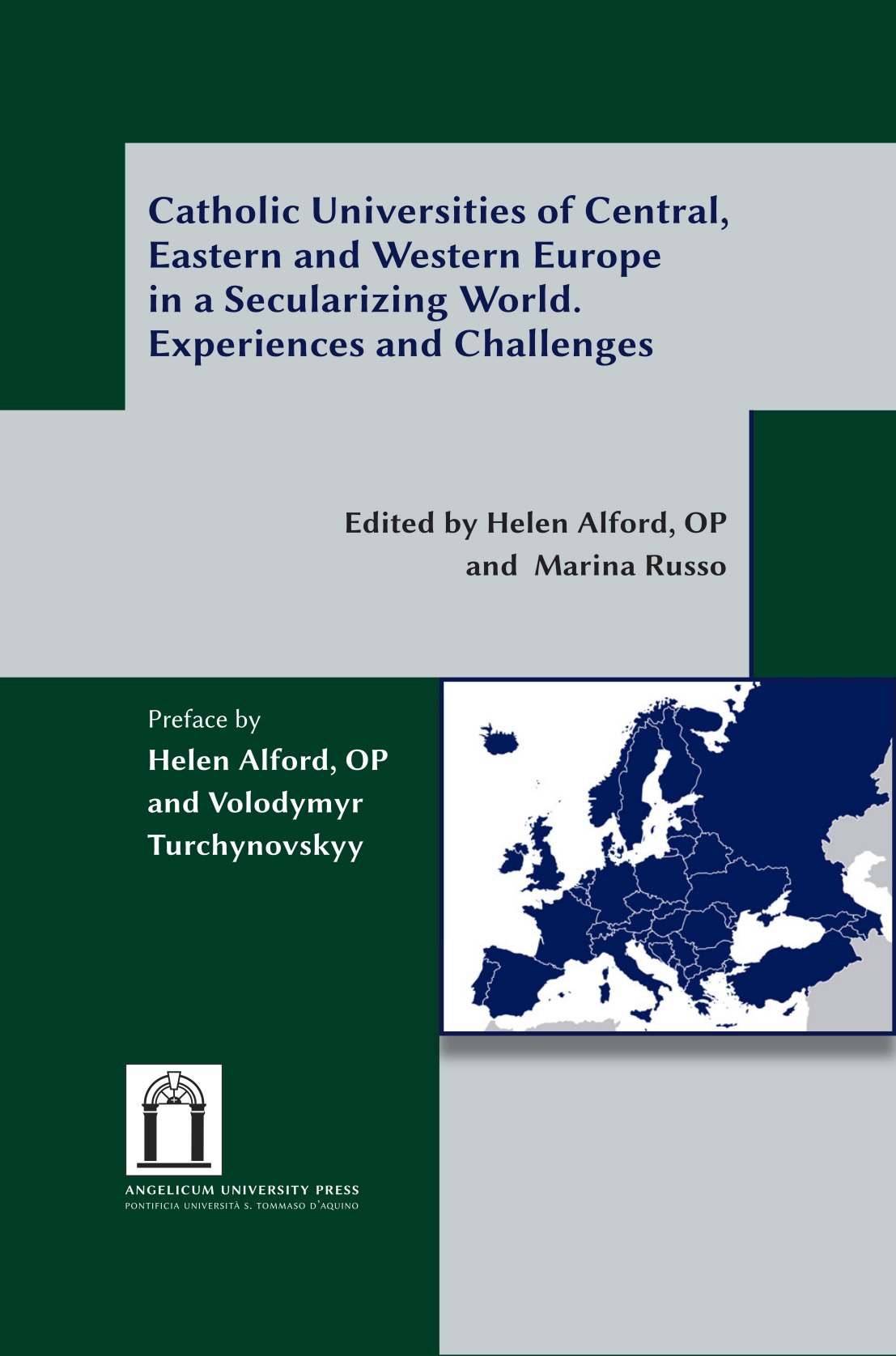Lezione inaugurale del III Master “Management e Responsabilità Sociale d’Impresa”
Roma, 18 novembre 2005
L’espressione Responsabilità Sociale dell’Impresa traduce dall’inglese Corporate Social Responsibility, dove è l’aggettivo “corporate” a non corrispondere con precisione all’italiano. Infatti “impresa” è un sostantivo che si applica a qualsiasi forma di attività economica condotta da un agente (imprenditore) che rischia in proprio, mentre l’ag-gettivo “corporate” si applica a quella particolare forma d’impresa che è la “corporation”, ossia in italiano la grande impresa capitalistica. In realtà, il problema che la RSI vuole affrontare riguarda proprio la corporation che fin da subito è stata estranea a quella “naturale” responsabilità sociale che le varie altre forme d’impresa (artigianali, civili, cooperative) hanno sempre dimostrato di avere, per il radicamento sul territorio che le caratterizza e anche per la loro limitata dimensione, che non consente alcun “potere di mercato”.
“corporate” a non corrispondere con precisione all’italiano. Infatti “impresa” è un sostantivo che si applica a qualsiasi forma di attività economica condotta da un agente (imprenditore) che rischia in proprio, mentre l’ag-gettivo “corporate” si applica a quella particolare forma d’impresa che è la “corporation”, ossia in italiano la grande impresa capitalistica. In realtà, il problema che la RSI vuole affrontare riguarda proprio la corporation che fin da subito è stata estranea a quella “naturale” responsabilità sociale che le varie altre forme d’impresa (artigianali, civili, cooperative) hanno sempre dimostrato di avere, per il radicamento sul territorio che le caratterizza e anche per la loro limitata dimensione, che non consente alcun “potere di mercato”.
E’, invece, la grande dimensione della corporation, insieme con la cosiddetta “organizzazione scientifica del lavoro”, ossia la catena di montaggio, e con la sua presenza pluri-nazionale, che hanno contribuito a rendere la gerarchia di comando che governa la corporation sempre più estranea non solo ai lavoratori che eseguono, ma anche al contesto territoriale che ospita la grande impresa, mentre il suo elevato grado di potere di mercato l’ha spinta a vessare fornitori e amministrazioni pubbliche, piuttosto che a collaborare con essi. Quanto ai consumatori, questi vengono “indotti” al consumo da pubblicità sempre più invadenti e subliminari, piuttosto che persuasi della bontà del prodotto stesso da un’informazione trasparente.
In questo paper affronterò dapprima gli sviluppi che hanno generato la corporation e le modalità operative che questa ha assunto. Vedremo poi quali “barriere” sono state poste dalla legislazione per evitare comportamenti irresponsabili, quando non del tutto fraudolenti, da parte delle grandi imprese. Da ultimo, analizzeremo che cosa può fare la RSI e infine trarremo qualche conclusione.
1. Come si sviluppa la moderna società di capitali.
Risale all’XI secolo l’introduzione in Occidente (Venezia e Genova in primis)1 della “commenda”, ossia di quella forma d’impresa che poi diventerà generalizzata che permetteva l’investimento di capitale da parte di soggetti che non erano direttamente interessati all’impresa, utilizzando la formula della responsabilità limitata2. A beneficiarne furono in primo luogo le imprese marittime, poi con l’appellativo di accomandita il contratto a responsabilità limitata venne esteso anche ad altre attività commerciali ed industriali3. Nel corso del XVI secolo nacquero in Olanda le borse4 e nel XVII secolo tra Olanda, Gran Bretagna e Francia le società per azioni; è in questo contesto che si verificarono i primi importanti episodi speculativi, che necessitarono dei primi interventi pubblici volti a controllare la speculazione finanziaria. Forse il più curioso è quello della “mania dei tulipani” che scoppiò nella borsa di Amsterdam tra 1636 e 1637. I bulbi, importati dall’Oriente, erano stati perfezionati dagli agronomi olandesi e venivano molto apprezzati e venduti a caro prezzo. Sorsero società di produzione e commercio dei bulbi di tulipano, le cui azioni venivano scambiate in borsa a prezzi sempre più elevati, cosicchè chi voleva comperarle ipotecò case e terreni. Quando nel febbraio 1637 si verificò il crollo del corso delle azioni, le autorità dovettero intervenire a bloccare il panico, proclamando la moratoria dei pagamenti e l’annullamento dei contratti più evidentemente esagerati5.
Ma sicuramente l’episodio speculativo più noto per i suoi estesi effetti macroeconomici e per la legislazione che provocò fu quello legato a John Law (1716-1720), emerso nello snodo tra il finanziamento delle grandi Compagnie per il commercio con l’America, l’Asia e l’Africa, l’immissione di circolazione cartacea e il collocamento di debito pubblico. L’originale nesso che John Law costruì fra i diversi flussi finanziari sopra citati finì in un colossale crollo che si propagò dalla piazza originaria (Parigi) attraverso tutti gli altri centri finanziari europei, un po’ per l’impianto troppo avveniristico del sistema di Law, un po’ per la mancanza di controlli sulla costituzione di nuove società per azioni e sulla loro quotazione in borsa6. Fu soprattutto in Gran Bretagna che con il Bubble Act del 1720 tali controlli iniziarono ad essere resi stringenti, pur senza poter sconfiggere definitivamente né la speculazione né le crisi finanziarie7.
Nella seconda metà dell’Ottocento assistiamo ad un altro anello significativo dell’evoluzione della società per azioni, che ha luogo negli Stati Uniti, un paese che raccoglie e rilancia in un modo tutto particolare l’eredità europea. Muovendosi in un’area geografica immensa, ma sottopopolata e priva di strutture di mercato, i soggetti imprenditoriali americani tesero fin da subito a creare grossi complessi produttivi che mettevano la dimensione al primo posto, rivelando forti tendenze monopolistiche che dovettero essere contrastate attraverso provvedimenti legislativi. Fu così che già dal 1890 con il primo Sherman Act la Corporation americana si trovò di fronte ad un legislatore deciso a non permettere un esito letale per la concorrenza – ossia la nascita di monopoli – anche se non incline a contrastare radicalmente l’ascesa dimensionale delle imprese produttive, come aveva fatto invece con le banche attraverso il Banking Act del 1864. In quest’ultimo caso, infatti, la legge americana si era spinta ad imporre la piccola dimensione, impedendo la proliferazione di sportelli da parte della stessa banca e mantenendo quindi un sistema bancario fortemente frammentato8. Non potendo dunque esaurire in un singolo settore la sua ansia di crescita dimensionale, la corporation iniziò a integrarsi verticalmente, poi a crescere per linee laterali più o meno complementari diventando un congelomerata, quindi ad espandersi all’estero multinazinalizzandosi. Questo modello di impresa si affermò con difficoltà in Europa e Giappone, dove più a lungo resistettero le piccole imprese familiari e i sistemi di impresa organizzati in cluster locali o in gruppi più o meno coesi (famosi sono gli zaibatsu, poi keiretsu giapponesi). Il suo controllo divenne sempre più problematico e dunque si sviluppò un sistema stratificato di managers che formano una gerarchia ben strutturata e funzionale, la quale ha comunque fatto sorgere una serie di problematiche di controllo non indifferenti9.
L’ultimo anello della catena che ha portato la società di capitali alla loro configurazione attuale è costituito nella seconda metà del Novecento dalla globalizzazione e finanziarizzazione del mercato internazionale. Con la globalizzazione, le grandi imprese diventano da multinazionali a transnazionali: se la multinazionale replicava il proprio impianto produttivo all’interno di ciascun paese in cui era presente, minimizzando gli scambi internazionali e obbedendo alle legislazioni nazionali, con la transnazionale il processo produttivo viene articolato su livello mondiale, con l’obiettivo di porre le legislazioni nazionali al servizio dell’impresa, la quale colloca i processi a più alta intensità di lavoro nei paesi dove il lavoro costa meno, i processi a più alta intensità di capitale nei paesi dove il capitale è più a buon mercato ed è meno tassato e così via, perseguendo la propria logica di massimizzazione del profitto attraverso un intenso commercio internazionale di prodotti intermedi trasferiti spesso a prezzi di comodo10 fino ad arrivare sui mercati di consumo con prezzi altamente concorrenziali. Il governo di simili transnazionali è diventato ancora più complesso, nella misura in cui l’intero processo produttivo è scomposto in passaggi realizzati in più nazioni con legislazioni differenti, mentalità, usi e costumi differenti.
Quanto alla finanziarizzazione, l’abbandono del sistema di Bretton Woods nei primi anni 1970 e l’adozione di tassi di cambio flessibili hanno fatto piombare il mondo in un vortice speculativo che non poteva verificarsi con il gold standard, sia pur in presenza di controlli assai più sofisticati che non in passato e di una collaborazione tra banche centrali mai sperimentata prima, che hanno finora evitato crisi mondiali. Questo nuovo assetto dei pagamenti internazionali, in passato esistito solo in periodi di guerra (in cui gli stati attivavano altri controlli amministrativi) ha determinato il duplicarsi dei mercati finanziari fra transazioni a pronti e transazioni a termine (spot and future markets), con la nascita di servizi finanziari di copertura dei rischi (hedging). Su questa base si sono innestate le “innovazioni finanziarie”, sostanzialmente basate sulla cartolarizzazione (securitization) dei debiti11, sui derivati (derivatives) e sulle operazioni over the counter (oppure anche dette off balance-sheet, che sono plafond di impegni di pagamento non registrati in bilancio da utilizzare in caso di bisogno). Sono così di molto aumentate le occasioni per far soldi a mezzo di soldi con la mobilitazione di capitali a breve termine (hot money) in operazioni di arbitraggio, accompagnata dall’uso delle cosiddette innovazioni finanziarie e delle transazioni off-shore nei “paradisi fiscali”, dove i movimenti di capitale hanno una tassazione nulla o vicina allo zero e non sono richiesti di trasparenza informativa, potendo quindi facilmente occultare un riciclaggio di capitali guadagnati illecitamente o degli artifici contabili truffaldini. La finanza, che è storicamente nata per aiutare i poveri ad uscire dalla loro indigenza (si pensi ai Monti di Pietà, alle Casse di Risparmio, alle banche popolari e alle cooperative di credito) e per convogliare i risparmi a scopi produttivi a beneficio dell’intera società, è diventata largamente autoreferenziale.
La finanza ha assunto aspetti di vero e proprio gioco d’azzardo (gambling) con l’utilizzo, iniziato da Michael Milken negli anni 1980, dei cosiddetti junk bonds (titoli spazzatura), obbligazioni di società con merito di credito basso, ma rendimenti elevati per compensare l’elevato rischio di default. Si è dimostrato che su una media pluriennale, pur scontando i tassi di default, i rendimenti medi di fondi basati sui junk bonds sono stati superiori a quelli di fondi composti da obbligazioni “normali”. Si è dunque venuto a creare a livello mondiale un “castello” finanziario sempre più imponente e sempre più distante dalla base reale dell’economia. Anche le società produttive sono state costrette ad esercitarsi sui mercati finanziari, per allargare la platea dei loro finanziatori, per impiegare il cash flow, per sostenere la redditività dell’azienda, finendo talora stritolate dagli eccessi speculativi degli uffici finanziari loro o altrui.
Si può ricordare in questo contesto il famoso caso capitato all’ENI nel luglio 1985. Era nell’aria una svalutazione della lira, ma l’ENI non sapeva che Bankitalia l’aveva programmata per il lunedì 22 luglio. Il venerdì mattina precedente, 19 luglio, il direttore finanziario dell’ENI Mario Gabbrielli ordinò di acquistare al fixing 125 milioni di $ per il rimborso di un prestito attraverso la Banca San Paolo. Bankitalia insistette con il funzionario (senza che Gabrielli potesse essere avvertito perché in viaggio senza telefono) affinchè l’operazione fosse rinviata al lunedì successivo, ma la Banca San Paolo procedette, acquistando dollari a 2200 lire per $ invece che a 1900 (il lunedì successivo, la lira fu svalutata a 1950 lire per $). L’ENI sborsò 35 mld lire in più12, ma intentò causa al San Paolo, vincendola in Cassazione nel 1998 ed ottenendo il risarcimento. Gabbrielli dovette però lasciare la direzione finanziaria dell’ENI, sull’onda delle accuse a lui rivolte. In una recente intervista13, Gabbrielli non solo chiarisce la sua innocenza rispetto al caso in questione, ma rivela che nei dodici mesi precedenti con opportune operazioni sui cambi aveva fatto risparmiare all’ENI ben 250 mld lire, il che, nel contesto della presente argomentazione, serve a chiarire quanto una società produttiva può guadagnare o perdere per motivi meramente legati alla fluttuazione dei cambi.
Ma persino fondi amministrati con criteri “scientifici” da illustri e specchiate personalità possono rivelare rischi paurosi. E’ il caso del fondo LTCM (Long Term Capital Management), creato nel 1994 con 1,3 mld $ da soci di elevata professionalità fra cui due premi Nobel, che avevano pensato di applicare modelli matematici di previsione dell’andamento del mercato basati sull’assunto di riduzione progressiva dei divari fra i prezzi sui vari mercati. Attraverso il leverage (ossia la leva finanziaria, anche detta indebitamento) e le operazioni over the counter, il fondo aumentò a dismisura il suo giro d’affari. In alcuni momenti l’indebitamento fu pari a 40-50 volte il capitale, ma gli affari sembravano fiorire, persuadendo anche molte istituzioni ad investire nel fondo. Nel 1995 si ottenne un tasso di rendimento del 43%, nel 1996 del 41% e nel 1997 del 17%. La crisi asiatica e quella russa del 1998 diedero però un colpo fatale al fondo, che cercò di liquidare le proprie posizioni maggiormente speculative, facendo ulteriormente diminuire il prezzo dei titoli, di cui deteneva una larga fetta. Per evitare un crack di proporzioni incalcolabili, la Federal Reserve americana riunì nel settembre del 1998 i principali creditori, che ricapitalizzarono l’LTCM, esautorando i precedenti proprietari del fondo, i quali persero tutti i loro capitali14.
2. Il controllo della corporation.
Nella corporation in linea di principio i managers hanno il potere di controllare l’amministrazione dell’azienda e la proprietà nomina i managers. Ora, questa separazione fra proprietà e controllo, tanto discussa dalla letteratura e per lungo tempo giudicata positivamente15, ha presentato col tempo seri problemi, in gran parte connessi con il predominio dei managers, che hanno oscurato le capacità di supervisione dei managers da parte della proprietà16. I managers, infatti, hanno cercato di influire sempre più pesantemente nella nomina dei consiglieri di amministrazione, per avere dei rappresentanti della proprietà a loro favorevoli, vanificando dunque il potere di controllo sui managers da parte dei consigli di amministrazione17. Inoltre, vantando una asset specificity sempre maggiore, hanno dato la stura ad una escalation dei loro compensi, che si è portata dietro una escalation dell’intero sistema di incentivi monetari su cui la gerarchia manageriale è basata18. Fra questi incentivi, da notare particolarmente sono le stock options, che fanno diventare i managers stessi proprietari delle imprese e dunque singolarmente interessati alla valorizzazione delle loro azioni.
Quando poi fra i proprietari si sono fatti largo i fondi pensione e una quantità di altri soggetti non imprenditoriali, interessati ai flussi di rendimento monetario annui più che alla salute a lungo termine delle imprese, i managers hanno incominciato a sposare il cosiddetto “cortotermismo”, ossia una filosofia di alti rendimenti sul breve termine, raggiunti con tutti gli strumenti disponibili: rinviare costi e ammortamenti al futuro, tagliare drasticamente i rami d’azienda (al momento poco fiorenti, acquisire o vendere scatole più o meno vuote allo scopo di ottenere guadagni di arbitraggio, tagliare selvaggiamente il personale (downsizing), finendo col governare l’impresa non più interessandosi a sviluppare i suoi prodotti salvaguardando la dignità di chi vi lavora, ma badando esclusivamente a raggiungere rendimenti finanziari interessanti (attraverso i capital gains) per gli azionisti (rule by numbers oppure by ratios). Se la tendenza è questa, si può comprendere come sia spianata ai managers la strada che li spinge verso il baratro dei comportamenti illeciti, senza che dall’interno dell’azienda vi siano sufficienti “anticorpi” per fermarli. Se gli azionisti, dunque, vengono tenuti all’oscuro o vengono solo parzialmente informati o sono conniventi, e così anche i sindaci delle imprese, quali sono oggi le barriere esistenti per bloccare la strada dei comportamenti nelle società di capitali?
Una prima barriera può essere fornita dalle società di revisione/certificazione, quando vengono opportunamente utilizzate. Porterò un esempio assai interessante, emerso nel corso del mio lavoro di ricerca per ricostruire la storia dell’Italcementi19. Nel mese di febbraio 1992, Giampiero Pesenti, che era da tempo alla ricerca di internazionalizzare la sua florida azienda cementiera nazionale, venne a sapere che Paribas, la quale deteneva la maggioranza delle azioni dell’azienda francese Ciments Français, seconda azienda cementiera francese, ampiamente multinazionalizzata, era disponibile alla vendita. Iniziarono le trattative, nel corso delle quali si venne ad evidenziare l’elevato indebitamento dell’azienda francese, che forniva il motivo ufficiale per cui Paribas ne favoriva l’alienazione. Dopo vari ripensamenti, il 26 aprile 1992 l’Italcementi ne decise l’acquisizione, pattuendone il prezzo, con la clausola di poter far verificare tutti i conti dell’azienda nel corso dell’anno successivo all’accordo.
Nell’estate del 1992 l’Italcementi inviò la società di revisione Kpmg Peat Marwick per fare un’audit sui conti del 1991. Questi scoprirono varie operazioni irregolari, che coprivano altro indebitamento. Paribas e l’intero Consiglio di amministrazione di Ciments Français proclamarono di non saperne nulla e la responsabilità ricadde sul presidente-direttore generale Pierre Conso, che si dovette dimettere e in seguito subire procedimenti ammnistrativi. Paribas dovette riconoscere ad Italcementi un consistente indennizzo, successivamente (1994) quasi raddoppiato in sede di accordo definitivo. Quello che vi è da notare in questa vicenda è che la società di revisione che lavorò per conto di Italcementi era particolarmente motivata ad approfondire i conti di Ciments Français; non altrettanto si può dire quando le società di revisione eseguono il controllo sui conti della stessa azienda che paga la loro parcella. Possono semplicemente essere superficiali, perchè considerano l’azienda per cui lavorano al di sopra di ogni sospetto; oppure possono anch’esse venire “addomesticate”, come i recenti scandali finanziari americani ed europei dimostrano.
Una seconda barriera che potrebbe fare argine alla corruzione delle società di capitali può essere costituita dalle banche finanziatrici, che dovrebbero disporre di informazioni di prima mano sullo stato delle imprese e dovrebbero chiudere i rubinetti del credito quando il “merito di credito” raggiunge parametri inaccettabili, segnalando all’impresa stessa e ai mercati che l’azienda ha bisogno di un ridirezionamento, prima che sia troppo tardi e i danni si siano moltiplicati. Ora, in questo campo il comportamento delle banche ha seguito nella storia due grandi filoni20, legati a due sistemi bancari diversi: il sistema orientato al mercato (USA), dove le banche giocano un ruolo marginale, e il sistema orientato alla banca (Germania, Giappone), dove invece la banca svolge un ruolo importante fino ad essere, in certi casi, il centro del sistema delle imprese. In un sistema orientato alla banca le banche sono in genere “universali” (o miste), pronte ad offrire alle imprese ogni sorta di servizio “dalla culla alla bara”, ossia dal collocamento delle azioni all’inizio delle attività all’eventuale liquidazione o salvataggio in situazione di difficoltà. Per meglio conoscere dall’interno lo stato delle imprese, le banche universali erano use piazzare qualche loro rappresentante nei consigli di amministrazione delle imprese, dando luogo a partecipazioni incrociate che sono un tratto distintivo dei sistemi orientati alla banca. In generale, il sistema di banca universale attiva una forte responsabilizzazione delle banche nei confronti non solo del finanziamento, ma della perforance delle imprese.
Come è noto21, l’Italia ha sempre avuto un sistema orientato alla banca, ma non sempre un sistema di banche universali. In particolare, con la legge bancaria del 1936 che decretava la fine dell’adesione italiana alla banca universale si è messo in esistenza un peculiare sistema bancario in cui la banca era specializzata nel credito a breve termine (banche commerciali) o nel credito a lungo termine (istituti di credito speciale, di proprietà pubblica, di cui i più importanti furono IMI e Mediobanca22). Questo sistema finì con l’attivare una prassi contraria all’assunzione di responsabilità da parte delle banche italiane nei confronti delle imprese, che si manifestò con tre fenomeni inquietanti. Il primo è noto come pluriaffidamento, emerso negli anni 1950 come effetto sia della legislazione del 1936 sia del “miracolo economico” che sosteneva le fortune delle imprese industriali, letteralmente “rincorse” dalle banche che offrivano credito. La prassi di avvalersi di più di una banca per le richieste di finanziamento, fornendo il minimo di informazioni, si generalizzò al punto da provocare una vera e propria estraneità delle banche rispetto ai progetti industriali delle imprese, cui veniva richiesto un collaterale immobiliare, spesso di dubbia liquidabilità23.
Il secondo fenomeno è quello della cosiddetta doppia intermediazione, che si manifestò negli anni 1970, quando con l’inflazione il pubblico non si rivelò più desideroso di acquistare le obbligazioni a tasso fisso degli ICS, per finanziare i quali la Banca d’Italia impose alle banche commerciali di assorbire le obbligazioni degli ICS. Come scrive Piluso: “il doppio passaggio dei fondi intermediati non si associava, nei due momenti in cui ciò sarebbe potuto avvenire, con alcun vaglio del merito di credito dei destinatari reali dei finanziamenti”24. Infine, il terzo fenomeno è quello del credito agevolato e della programmazione, che si fecero largo in Italia tra fine anni 1950 e anni 1960, inizialmente per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno, ma poi proliferati fino a coprire svariati ambiti. Era lo stato che assumeva su di sé le decisioni di sostenere certi investimenti e forniva a varie imprese (per lo più pubbliche, ma non solo) la legittimazione a ricorrere al credito bancario, soprattutto presso gli ICS, vanificando qualsiasi “pretesa” di questi ultimi di giudicare sul merito di credito.
La privatizzazione delle banche (con la loro crescita dimensionale) ed il ritorno alla banca universale iniziate dalla riforma bancaria Amato del 1993, in un contesto di innovazioni tecnologiche e finanziarie (si pensi alle cartolarizzazioni e all’estensione dei servizi bancari) non hanno riportato in auge quelle forme di relationship banking connesse con la banca universale. Con Basilea 1 e Basilea 2 si è provveduto ad un abbattimento dei rischi, ma soprattutto attraverso la loro ripartizione, favorendo lo spostamento dell’attenzione dei banchieri “dalla valutazione delle imprese alla gestione del rischio, rinunciando a selezionare direttamente le imprese e i progetti di investimento innovativi”25. La “centrale dei rischi”, inoltre, ossia il database dei bilanci delle imprese italiane attivato nel corso degli anni 1980, non include le posizioni debitorie con intermediari non italiani.
E’ così che si è arrivati a casi limite ben noti. La ristrutturazione della Ferruzzi - Montedison iniziata nel 199326 accertò nel 1992 un indebitamento di oltre 32.000 mld lire (quasi 17 mld Euro), suddiviso in ben 311 banche. Ancora più paradigmatico è il caso Parmalat. Le oltre 250 società del gruppo, molte delle quali estere, erano affidate da 120 banche, fra cui tutte le maggiori italiane e molte primarie banche estere (Bank of America, Citigroup, Santander, Abn Amro, Barclays, Deutsche Bank), con un indebitamento che dopo il crack superò i 14 mld Euro. L’occultamento dei dati nascondeva anche artifici contabili truffaldini, che però non potevano sfuggire alle banche se queste avessero veramente esercitato il controllo, tanto è vero che il commissario della Parmalat Bondi ha citato, oltre alle società di certificazione, anche alcune banche per correità.
Se gli azionisti non controllano, le società di certificazione non fanno il proprio mestiere e le banche si chiamano fuori, come si collocano rispetto alle barriere poste ai comportamenti irresponsabili delle imprese le autorità indipendenti? Secondo quanto è stato anche recentemente ribadito27, il disegno istituzionale delle autorità esistenti in Italia non è unitario, essendo queste state promosse alla spicciolata dal 197428 in poi sull’onda di bisogni diversi e dunque la risposta non può essere univoca. Quello che si può in generale affermare è che il loro obbiettivo è nella grande maggioranza dei casi diverso rispetto a quello di contrastare la corruzione finanziaria. Soltanto la vigilanza della Banca d’Italia sulle banche e quella analoga dell’ISVAP sulle assicurazioni esercitano in linea di principio un controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, mentre tutte le altre agenzie si concentrano su particolari aspetti dell’attività economica delle aziende sottoposte al loro controllo: pubblicità ingannevole, fusioni ed incorporazioni, correttezza nell’applicazione delle leggi regolative del mercato. Anche la Consob, che è preposta al controllo delle aziende quotate, lo esercita in relazione alla trasparenza del mercato borsistico (obblighi informativi, opa, ordinato svolgimento delle negoziazioni, insider trading, aggiotaggio) più che con obiettivi di monitoraggio dell’andamento delle aziende stesse. In più va ricordato che, in ogni caso, le aziende quotate sottoposte alla Consob sono un’esigua minoranza delle aziende italiane.
Un crack come quello di Parmalat si è dunque potuto verificare anche perché la Consob si accontenta di una correttezza “formale” dei bilanci, mentre la Banca d’Italia dichiarò che non le spettava il controllo delle aziende affidate dalle banche. Ricapitolando quanto fin qui detto con applicazione alla Parmalat, si è registrata la seguente sequenza di falliti controlli:
a) gli azionisti di controllo della Parmalat (ossia la famiglia Tanzi) furono essi stessi ad ordinare ai managers di truccare i bilanci per coprire i buchi soprattutto di un’espansione internazionale e di gruppo disordinata, già fin dai primi anni 1990, forse sperando in qualche inversione di tendenza della spirale dell’indebitamento, che puntualmente non si verificò;
b) le società di certificazione furono accomodanti;
c) le banche, molte delle quali non potevano non sapere e alcune delle quali erano state “ammorbidite” da Tanzi, si trinceravano dietro il rischio sopportabile a causa del pluriaffidamento, con l’avallo di Bankitalia, che non vedeva motivi di instabilità nel sistema;
d) la Consob non aveva identificato motivi formali di sanzione;
e) nessuno aveva sotto controllo la parte internazionale dell’indebitamento di Parmalat, dove si verificarono le falsificazioni più clamorose29.
In realtà, furono gli analisti di R&S di Mediobanca nel luglio del 2003 ad esprimere le prime valutazioni pubbliche allarmate sul futuro del gruppo Tanzi, a cui Mediobanca aveva già rifiutato credito in precedenza, a causa dell’opacità dei bilanci. Questo conferma quanto da molti studiosi ritenuto, ossia che Mediobanca sia stata l’unica vera banca d’affari italiana. La sequenza sopra riportata chiarisce, dunque, che non esistono oggi barriere insuperabili per fermare la corruzione finanziaria delle società di capitali, quando proviene dal suo stesso interno. Le imprese che imboccano la strada della corruzione possono continuare per molti anni a fronteggiare le barriere frapposte dalla legislazione e dalla corretta prassi aziendale, facendo uso di qualche misura volta ad ottenere comportamenti collusivi da parte di vari “controllori”, ma soprattutto avvalendosi dei “buchi” informativi permessi dalla prassi del pluriaffidamento e dalla mancanza di un sistema di controlli su scala mondiale.
3. La Responsabilità Sociale dell’Impresa
Visto che le barriere legislative esterne ai comportamenti illeciti ed irresponsabili delle imprese non stanno dando risultati sufficienti, e che oltre ai problemi sopra elencati di illeciti sanzionabili dal potere giudiziario, molti altri ancora sono i comportamenti censurabili da parte delle imprese, si sta oggi provando a fare leva su quella che, se applicata, è la barriera “naturale”, ossia il comportamento socialmente responsabile. Oggi si parla dunque tanto di Responsabilità Sociale dell’Impresa (RSI o CSR, corporate social responsibility)30 proprio perché tale comportamento socialmente responsabile trova maggiore difficoltà che nel passato ad essere la norma, particolarmente nelle grandi imprese, ma un po’ dovunque. Ciò è avvenuto essenzialmente per quattro motivi: a) l’individualismo esasperato che spinge i detentori di profitti a tenerli per sé, invece di metterli a servizio del “bene comune” (in passato erano più diffusi gli imprenditori “sociali”; b) il prevalere della cosiddetta “teoria dei due tempi”: la produzione massimizza i profitti con qualsiasi mezzo, senza riguardo a considerazioni etiche, e successivamente la distribuzione dei profitti può incorporare considerazioni etiche; c) lo sradicarsi dell’impresa da un ambiente sociale a cui doveva rendere conto a causa dei fenomeni di delocalizzazione e multinazionalizzazione; d) lo scollegarsi della finanza dall’aspetto reale dell’economia.
Tuttavia, il richiamo alla RSI si verifica molto spesso sull’onda di una rivolta di consumatori e dipendenti nei confronti di comportamenti amorali, quando non immorali, in relazione a: a) trattamento della forza lavoro, soprattutto nei paesi in via di sviluppo; b) pubblicità ingannevole; c) territori di insediamento maltrattati (inquinati, resi insicuri, abbandonati); d) contraffazione dei prodotti e prezzi artificialmente alti. Si tratta, dunque, di un richiamo “imposto” dall’esterno, che induce da parte dell’impresa reazioni del tutto strumentali, aggiungendo qualche vincolo in più (oltre alla legislazione vigente) all’obiettivo di massimizzazione dei profitti, ma che non cambia in profondità le prassi aziendali. Così strumentale è a volte l’uso della RSI che il bilancio sociale, deputato a dar conto dei livelli di RSI raggiunti da un’impresa, viene stilato ex-post da un consulente esterno, senza alcun coinvolgimento né dei processi decisionali, né dei managers dell’impresa31. Comportamenti socialmente responsabili, anche se “imposti” dall’esterno e adottati strumentalmente, sono sempre preferibili a comportamenti irresponsabili, ma il loro carattere “estrinseco” non ne garantisce la continuità nel tempo. La sostenibilità non è garantita, perché in tutte le situazioni di conflitto fra i legittimi interessi dei molteplici agenti coinvolti in un processo di produzione la soluzione “giusta” può andare in rotta di collisione con la massimizzazione del profitto da distribuire agli azionisti e dunque non sarà adottata se non ricorrendo ad una fermezza di convinzioni capace di far superare le ragioni della convenienza immediata.
Anche l’ancoraggio all’etica della responsabilità, che sta alla base della teoria dell’impresa come multi-stakeholder, è insufficiente. Infatti, su tale etica della responsabilità si può stilare un “contratto sociale” condiviso fra tutti gli stakeholders dell’impresa, contratto che fissa i canoni di comportamento collettivamente condivisi e li formalizza in un “codice etico”. Ma chi garantisce che questi canoni vengano poi effettivamente praticati? In parte può essere utilizzato a questo scopo il meccanismo della “reputazione”, ma anche questa può essere una carta limitata dalla grave incapacità di molti stakeholders di conoscere adeguatamente ciò che l’impresa effettivamente fa o potrebbe fare.
Se dunque tutti i sistemi di enforcement esogeno (inclusa l’etica della responsabiltà) si rivelano inadeguati, solo una motivazione intrinseca ad adottare il codice di comportamento concordato può assicurare il risultato; occorre cioè un ancoraggio della RSI all’etica delle virtù. La soluzione al problema del comportamento socialmente responsabile delle imprese non è quella di costringerle a guadagnare di meno attraverso la fissazione di un vincolo in più (la RSI, oltre ai vincoli già legalmente vigenti), ma quella di offrire all’impresa una più completa visione del suo bene, attraverso la dimostrazione teorico-pratica che un’impresa socialmente responsabile è un’impresa civile e civilizzante, ossia un’impresa che aumenta il grado di civiltà di una società e contribuisce a renderla sostenibile nel tempo, perché più integralmente “umana”.
A questo scopo, occorre che le istituzioni intervengano sull’assetto istituzionale della società in modo che questo incoraggi la diffusione delle virtù civiche attraverso l’educazione e il sostegno alle iniziative che danno vita ad imprese socialmente responsabili. Occorre sviluppare standard condivisi per la redazione dei bilanci sociali e allargare l’utilizzo delle società di certificazione di buone pratiche aziendali (che sono società diverse da quelle di certificazione dei bilanci tradizionali, come ad esempio quelle per la certificazione ambientale). Ma, soprattutto, occorre che le persone non abbiano paura di sostenere le imprese “civili”, impegnandovisi direttamente e studiando le modalità per meglio farle funzionare, perché solo dall’esempio molti potranno imparare.
responsabili. Occorre sviluppare standard condivisi per la redazione dei bilanci sociali e allargare l’utilizzo delle società di certificazione di buone pratiche aziendali (che sono società diverse da quelle di certificazione dei bilanci tradizionali, come ad esempio quelle per la certificazione ambientale). Ma, soprattutto, occorre che le persone non abbiano paura di sostenere le imprese “civili”, impegnandovisi direttamente e studiando le modalità per meglio farle funzionare, perché solo dall’esempio molti potranno imparare.
Un master come quello dell’Angelicum su “Management e responsabilità sociale dell’impresa” può essere una punta di diamante nella direzione di diffondere le conoscenze necessarie e nel formare lo spirito giusto, capace di mantenere (o restituire) al mercato e all’impresa la loro dimensione autenticamente umana.
NOTE:
1 È probabile che tale contratto venisse già usato in precedenza nei commerci arabi e bizantini.
2 G. Felloni, Profilo di storia economica dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea, Torino, 1997.
3 Si veda P.Malanima, Economia preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo, Milano, 1995, pp. 451 e ss.
4 G. Borelli, Temi e problemi di storia economica europea, Verona, 1993. La prima borsa fu quella di Anversa del 1531.
5 C.P. Kindleberger, Storia della finanza nell’Europa occidentale, Cariplo-Laterza, 1981.
6 A.E. Murphy, John Law. Economic theorist and policy maker, Oxford, OUP, 1997.
7 Sulla ricorrenza quasi decennale delle crisi finanziarie negli anni 1551-1866, si veda C.P. Kindleberger, Euforia e panico. Storia delle crisi finanziarie, Bari, Laterza, 1981. In seguito, le crisi si diradarono, ma la loro virulenza non diminuì, fino alla grande crisi internazionale del 1929-33, che portò ad interventi legislativi ancora più drastici.
8 V. Zamagni, Dalla rivoluzione industriale all’integrazione europea, Bologna, Il Mulino, 1999, cap. 5.
9 Ibidem, cap. 6.
10 Cosa possibile, perché si tratta di trasferimenti all’interno della medesima impresa, anche se registrati dalle statistiche import-export perché attraversano confini nazionali.
11 Che permette lo smobilizzo di capitali reimpiegabili. Se il tasso di rendimento atteso dai nuovi impieghi supera lo sconto effettuato con la cartolarizzazione, l’operazione è attiva.
12 Si veda F. Briatico, Ascesa e declino del capitale pubblico in Italia. Vicende e protagonisti, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 508-510.
13 A. Bernacchi, “Così la lira naufragò”, in Il Sole-24 Ore, 5 agosto 2005.
14 L. Bini Smaghi, Chi ci salva dalla prossima crisi finanziaria. I vantaggi, le incognite, i rischi della globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2000.
15 Si veda per tutti A. D. Chandler, Strategia e struttura, Milano, Angeli, 1976.
16 Si veda a questo proposito l’interessante lavoro di M.J.Roe, Strong managers weak owners. The political root of American corporate finance, Princeton, PUP, 1994 (trad. it. Manager forti azionisti deboli. Economia, finanza e scelte politiche alla radice della corporate governance, Milano, 1997).
17 Nelle società italiane a controllo familiare è piuttosto vero il viceversa (è la proprietà ad annullare l’autonomia sia degli altri consiglieri di amministrazione, sia dei managers).
18 Al contempo approfondendo il gap tra stipendi dei managers e salari dei lavoratori, salito negli USA a livelli davvero preoccupanti.
19 V. Zamagni, Italcementi. Dalla leadership nazionale all’internazionalizzazione, Bergamo, 2005.
20 V. Zamagni (a cura di), Finance and the enterprise, Londra, Academic Press, 1992.
21 V. Zamagni, Dalla periferia al centro, Bologna, Il Mulino, 2005.
22 Si veda S. La Francesca, Storia del sistema bancario italiano, Bologna, Il Mulino, 2004.
23 M. De Cecco e G. Ferri, Le banche d’affari in Italia, Bologna, Il Mulino, 1996.
24 G. Piluso, Il banchiere dimezzato. Finanza e impresa in Italia, Venezia, Marsilio, 2004, p. 102.
25 Piluso, cit., p. 129.
26 E terminata con la dissoluzione e la vendita a pezzi di Montedison.
27 M. Clarich, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, Bologna, Il Mulino, 2005. Si veda anche F. Merusi e M. Passaro, Le autorità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2003.
28 Anno di introduzione della Consob. In precedenza, era stata attivata solo la vigilanza sulle banche, affidata, dopo alcune tergiversazioni iniziali, alla Banca d’Italia.
29 V. Malagutti, Buconero spa. Dentro il crack Parmalat, Roma-Bari, Laterza , 2004.
30 Il più recente lavoro che in 50 contributi per un totale di oltre 800 pagine offre uno sguardo complessivo sull’elaborazione in tema di RSI è quello di L. Sacconi (a cura di), Responsabilità sociale dell’impresa, ABI, Roma, 2005.
31 Si pensi che la Parmalat redigeva un bilancio sociale! Si può dire che il modo di affrontare la RSI sia la questione che oggi discrimina fra le imprese veramente “etiche” e quelle che fanno dell’etica un uso solo strumentale. Come ebbe a dire il presidente di Granarolo Luciano Sita in una recente intervista: “Un buon codice etico dev’essere applicato, controllato e vissuto in prima persona dal management. Perché non sia una foglia di fico va elaborato e condiviso insieme agli stakeholder e non può essere affidato a società di consulenza”. F. Tamburini, “L’etica rafforza le leggi”, in Il Sole-24 Ore, 7 maggio 2005.
 IT
IT  EN
EN