Negli ultimi due decenni l’economia mondiale ha vissuto cambiamenti tanto profondi da rivoluzionare gli equilibri geopolitici che avevano dominato la scena dal secondo dopoguerra. Queste tendenze si sono rese ancora più evidenti con la crisi finanziaria ed economica che ha investito prima gli USA e poi l’Europa, sebbene fossero in atto già da tempo. I cambiamenti epocali che si sono verificati sembrano confermare le previsioni dei fautori della cosiddetta globalizzazione, ma in realtà hanno fatto emergere elementi nuovi, spesso trascurati dagli economisti. In questo nuovo contesto le categorie di Paesi in Via di Sviluppo e Paesi Emergenti sembrano superate e occorre ripensare quali possano essere il luogo e gli obiettivi del loro Buon Governo.
gli equilibri geopolitici che avevano dominato la scena dal secondo dopoguerra. Queste tendenze si sono rese ancora più evidenti con la crisi finanziaria ed economica che ha investito prima gli USA e poi l’Europa, sebbene fossero in atto già da tempo. I cambiamenti epocali che si sono verificati sembrano confermare le previsioni dei fautori della cosiddetta globalizzazione, ma in realtà hanno fatto emergere elementi nuovi, spesso trascurati dagli economisti. In questo nuovo contesto le categorie di Paesi in Via di Sviluppo e Paesi Emergenti sembrano superate e occorre ripensare quali possano essere il luogo e gli obiettivi del loro Buon Governo.
Il Sud del mondo tra sviluppo e crisi globali
Secondo i dati della Banca Mondiale, la Cina è di gran lunga il leader dei cosiddetti paesi emergenti: nel 2001 aveva un PIL annuale corrente pari al 13,7% di quello degli USA, appena dieci anni dopo era giunto al 48,8%. Nello stesso periodo il PIL dell’India rispetto a quello degli USA è passato dal 4,6% al 12,3%. Lo stesso indice per il Brasile è salito dal 5,2% al 16,5% e per la Russia dal 2,9% al 12,4%. Questi quattro paesi, che in un fortunato rapporto della Goldman Sachs (Wilson D. e R. Purushothaman, 2003) vennero indicati con l’acronimo BRICs, equivalevano complessivamente al 26,4% del reddito annuale USA nel 2001, mentre dieci anni dopo al 90%!
Ma il processo di convergenza dei redditi mondiali sembra riguardare anche le economie di altri paesi, ed in particolare dei PVS. Se si confrontano i dati assoluti del PIL corrente negli ultimi 60 anni, l’ultima decade risulta l’unica in cui si sia effettivamente realizzato un riavvicinamento tra paesi ricchi e poveri. Naturalmente si tratta di grandi aggregati, che non tengono conto delle situazioni di singoli stati. Tuttavia il dato segnala un’inversione di tendenza. Nella tabella 1 sono riportati i rapporti percentuali tra il PIL aggregato dei paesi rispettivamente a medio e basso reddito in confronto a quello dei paesi ad alto reddito.
Tabella 1 – Percentuale del PIL dei Paesi ad Alto Reddito (a valori correnti)
| 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
| Paesi a Medio Reddito | 27,01% | 25,08% | 29,05% | 18,68% | 22,03% | 49,36% |
| Paesi a Basso Reddito | 2,17% | 1,75% | 1,28% | 0,76% | 0,64% | 1,01% |
Nostre elaborazioni su dati della Banca Mondiale, World Development Indicators, accesso online Gennaio 2013.
Per quanto riguarda il primo gruppo di paesi, si può notare che tra il 1961 ed il 2001 il valore è oscillato tra un massimo di 29,05% nel 1981 ed un minimo di 22,03% nel 2001 con una riduzione di oltre un terzo durante la decade degli anni ’80 (caratterizzata dall’esplosione della crisi dei debiti esteri). Nello stesso periodo il reddito dei paesi più poveri si è ridotto, sempre relativamente a quello dei paesi più ricchi, in modo continuo passando dal 2,17% allo 0,64%, una riduzione di oltre due terzi. Tra il 2001 ed il 2011, invece, si osserva una netta inversione di tendenza per entrambi i gruppi di paesi. Chiaramente l’avvicinamento dei paesi a medio reddito nei confronti dei paesi ricchi è più evidente: sono passati da rappresentare circa un quinto del reddito prodotto dalle economie più ricche a circa la metà, con un incremento del 124%. Ma anche il recupero dei paesi poveri è notevole se si pensa che è stato del 58% rispetto al valore del 2001.
Questi semplici dati rilevano un fatto stilizzato che riguarda il cambiamento nelle relazioni economiche mondiali: se nel periodo 1961-2001 è innegabile il progressivo allargamento del differenze tra paesi ricchi e paesi poveri, nell’ultima decade la tendenza sembra capovolgersi, con una intensità tale da lasciar pensare a dei cambiamenti durevoli. La convergenza, come detto, coinvolge anche il gruppo dei paesi a basso reddito, ma indubbiamente avviene più lentamente. Ciò mette in luce il rischio di un’ulteriore polarizzazione tra chi beneficia della globalizzazione e chi no: i grandi fornitori di fattori produttivi a livello mondiale possono godere di un crescente potere di mercato e di una maggiore incidenza politica, mentre chi non riesce a raggiungere questo rango, in particolare i piccoli paesi, rischiano di restare fuori dai vantaggi del nuovo equilibrio mondiale.
E’ interessante notare che la convergenza sembra confermare le previsioni ottimistiche dei fautori della globalizzazione e dei teorici del neoliberismo, ma paradossalmente poggia su cause molto diverse: non è infatti la diffusione delle tecnologie e l’aumento della produttività a causare processi di crescita economica, ma l’effetto congiunto di un massiccio allargamento del mercato e del sempre maggiore peso strategico dei fattori land-based.
Tra le molte ragioni di queste nuove tendenze economiche, una delle più significative è l’aumento dei prezzi delle cosiddette commodities ovvero delle materie prime energetiche, agricole e minerali, come mostrato nella tabella 2 (che si riferisce ad un indice di prezzo reale, fatti pari a 100 i prezzi del 2005). Si tratta del risultato di due dinamiche economiche che hanno riguardato questi beni. Da un lato infatti le materie prime energetiche hanno seguito dapprima un apprezzamento in occasione delle crisi degli anni ’70, poi una forte diminuzione per tutti gli anni ’80 e ’90 per poi impennarsi negli ultimi dieci anni. Le materie prime agricole hanno invece avuto un continuo deprezzamento tra gli anni ’60 e gli anni ’90 (con un breve picco durante la prima crisi petrolifera del 1973), che è coinciso con l’allargamento delle disparità di reddito tra paesi ricchi e paesi poveri, per poi apprezzarsi negli ultimi dieci anni fino a superare il valore in termini reali che avevano mezzo secolo fa. Infine, le materie prime minerarie hanno seguito un andamento tendenzialmente decrescente, per poi aumentare decisamente nell’ultima decade. L’incremento recente di tutti i gruppi è stato notevolissimo: il prezzo delle materie prime energetiche e dei minerali è triplicato, quello delle materie prime agricole è quasi raddoppiato.
Tabella 2 – Indice dei prezzi delle materie prime (2005 = 100)
| 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
| Materie prime energetiche | 12,50 | 13,62 | 86,51 | 39,29 | 56,10 | 152,99 |
| Materie prime minerarie | 85,90 | 94,99 | 72,35 | 65,54 | 63,07 | 167,04 |
| Materie prime agricole | 164,02 | 146,56 | 139,22 | 92,07 | 88,83 | 169,89 |
Nostre elaborazioni su dati della Banca Mondiale, World Development Indicators, accesso online Gennaio 2013.
L’aumento dei prezzi delle materie prime ha avuto come ulteriore conseguenza il miglioramento delle ragioni di scambio dei PVS e dei paesi emergenti. Se consideriamo infatti che i prezzi dei beni finiti ad elevata tecnologia prodotti dai Paesi Industrializzati sono generalmente diminuiti a causa della loro massificazione, ne deriva che l’apprezzamento delle commodities ha causato una redistribuzione del valore aggiunto a livello globale. Ci limitiamo a citare alcuni casi più rappresentativi, rimandando per ulteriori approfondimenti alla lettura delle tavole della Banca Mondiale sull’andamento delle ragioni di scambio per paese. Con riferimento al valore delle ragioni di scambio nel 2000, è interessante notare che undici anni dopo l’indice per la Russia è aumentato del 134,2%, per l’India del 35,9% e per il Brasile del 35,8%. Il legame tra tali andamenti e l’aumento dei prezzi delle materie prime è confermato anche dai risultati conseguiti da grandi esportatori di beni alimentari come l’Argentina (+35,2%), di minerali come il Cile (+113,3%), la Bolivia (+75,4%), il Perù (+59%), il Sud Africa (+54,1%) 1. L’unica eccezione è costituita dalla Cina, la cui ragione di scambio si è mantenuta sostanzialmente costante, ma occorre considerare che rappresenta attualmente il principale acquirente di materie prime a livello mondiale per finanziare il proprio vorticoso sviluppo.
Elementi nuovi ed equilibri geopolitici
Il “successo” economico di tanti outsider è dovuto a cause in gran parte non previste dall’economia tradizionale, sia di tipo neoclassico che keynesiano. Bisogna forse risalire alle teorie classiche per rintracciare fattori di sviluppo che emergono di nuovo oggi nel nuovo scenario mondiale.
Tra questi, uno accomuna i BRICs e contribuisce a spiegarne gran parte della loro ascesa, ovvero il fatto che le dimensioni contano (Salvatore D., 2010): Cina ed India in primo luogo, ma anche Russia e Brasile. I vantaggi che derivano da questo fattore di sviluppo sono diversi. Dal punto di vista della domanda, i quattro paesi presentano ciascuno un grande mercato interno dovuto alla popolazione economicamente attiva, ma anche a quella che potenzialmente può essere ancora inclusa nel mercato. I casi di Cina e India sono eclatanti, dal momento che la parte più ricca della popolazione rappresenta una piccola percentuale di quella totale ma è assai rilevante come valore assoluto: si tratta di centinaia di milioni di persone che possono permettersi ormai uno standard di vita di livello europeo. Ma anche Brasile e Russia sono casi rilevanti, in cui la popolazione si avvicina rispettivamente ai 200/150 milioni di abitanti. Basti pensare che nel loro insieme i BRICs rappresentano quasi tre miliardi di persone.
Dal punto di vista dell’offerta conta anche l’estensione territoriale: i quattro BRICs sono tutti tra i sette paesi più grandi del mondo e coprono insieme circa il 30% delle terre emerse. Una conseguenza immediata è la presenza di materie prime, incluse quelle che negli ultimi anni hanno acquisito un valore strategico 2. Si tratta di fattori di sviluppo di lungo periodo che in un mondo globalizzato sono destinati a contare sempre di più.
Un secondo elemento nuovo è la crescente dipendenza del Nord del Mondo dai fattori primari della produzione (lavoro, materie prime e terra) presenti nei paesi del Sud del Mondo, paradossalmente proprio a causa delle più recenti innovazioni tecnologiche, dei cambiamenti nell’organizzazione internazionale della produzione industriale e anche dello sviluppo dei mercati finanziari. Riassumiamo gli elementi più importanti con riferimento a ciascun fattore produttivo:
- Lavoro: il fenomeno della delocalizzazione nella produzione dei beni industriali si è spinta a livelli impensabili appena 20 anni fa, determinando una situazione in cui alcuni paesi o aree geografiche (Cina, Sud-est Asiatico, Est Europa, Centro America) sono gli unici fornitori della manodopera che produce i beni globali. Il suo effetto sulla crescita del reddito è stato indagato in una vasta letteratura tra cui Sridharan, Vijayakumar e Rao (2009).
- Materie prime: l’aumento della domanda di specifiche materie prime, non richieste in passato, che assumono un ruolo strategico perché essenziali nella produzione di beni ad alta tecnologia. In questo campo sembra paradossale notare che una delle principali cause della globalizzazione, la rivoluzione informatica, da un lato rappresenta una grande innovazione tecnologica nata nel Nord del Mondo che influisce sulla dematerializzazione dell’economia, ma dall’altro ha “inventato” nuove materie prime strategiche, sempre più richieste, che ancor più che in passato sono concentrate nei BRICs e nei paesi del Sud (Dierckxsens, 2012).
- Terra: si è assistito ad un aumento generalizzato del prezzo della terra e dei beni agricoli primari, per effetto di molteplici fattori, tra cui l’evoluzione dei mercati finanziari che ha favorito la formazione di bolle speculative anche in questo settore. Ma hanno agito anche fattori fondamentali, come la crescente domanda di terra per la produzione di biotecnologie e biocarburanti. La conseguenza più grave dell’apprezzamento della terra è stato l’impoverimento della popolazione, ma anche, al contrario, l’arricchimento delle elite degli esportatori di prodotti nazionali ed il miglioramento della bilancia commerciale. E’ aumentata così la disuguaglianza interna, ma in un mondo in cui le dimensioni assolute contano più di quelle relative, i “pochi” nuovi ricchi sono comunque un numero sufficiente per far sentire il loro peso sul mercato mondiale.
Pur con riferimento al solo caso della Cina, si potrebbe aggiungere anche il fattore capitale, sia reale che monetario, dal momento che negli ultimi decenni, con la crisi finanziaria europea, il capitale cinese ha progressivamente sostituito quello del vecchio continente nel finanziamento del debito strutturale degli Stati Uniti. In ogni caso, molti paesi esportatori del Sud del Mondo hanno accumulato ingenti riserve valutarie negli ultimi anni.
Il terzo elemento nasce dalla combinazione dei precedenti e determina cambiamenti geopolitici. In una situazione in cui i fattori della produzione necessari allo sviluppo e alla modernizzazione del Nord del Mondo sono detenuti da paesi le cui dimensioni fisiche ed economiche sono rilevanti, il potere economico mondiale subisce una inevitabile redistribuzione. Gli elementi nuovi sono la presa di coscienza da parte dei paesi emergenti di poter assumere questo ruolo nello scacchiere globale e la tendenza a costituire un blocco di interessi da contrapporre ad Europa e Stati Uniti. Non tutti i paesi possono vantare gli elementi di novità richiamati in precedenza, ma la loro convergenza consente di accrescerne il potere negoziale. In questa direzione si colloca la contrapposizione all’interno dei negoziati WTO, l’esperienza del G20, ma anche accelerazioni nei processi di integrazione economica regionale come nel caso dell’America del Sud con UNASUR.
Da questi movimenti sembra esclusa l’Africa, ma ciò non è del tutto vero. Il ruolo dei paesi africani è spesso passivo o ancora ridotto a terra di conquista di vecchi e nuovi colonizzatori, ma l’aumento della domanda di materie prime ha consentito ad alcuni paesi di sperimentare una crescita economica (anche se non apprezzabile dal punto di vista sociale). Inoltre il Sud Africa occupa una posizione forte dal punto di vista della presenza di materie prime strategiche, la Cina ha crescenti rapporti commerciali con il continente ed il Brasile sta giocando un ruolo di traino dei paesi “lusitofoni”. Naturalmente non mancano le voci critiche: la principale tesi contro il prolungarsi del boom dei paesi emergenti si basa principalmente sulla scarsità di risorse, sui limiti fisici dei fattori produttivi di cui sono dotati tali paesi e sull’effetto negativo che la crisi di USA e Europa può ancora esercitare su di essi (Holly Bell, 2011). Tuttavia, il limite fisico di alcuni fattori è ancora lontano: ad esclusione del petrolio e dell’uranio, le riserve di alcune materie strategiche non sono vicine all’esaurimento. Il problema è che sono concentrate in poche regioni del mondo. Se consideriamo poi la disponibilità di manodopera, è improbabile che Cina e India siano prossime ad una situazione di piena occupazione. In secondo luogo, è vero che una volta giunti all’esaurimento dei fattori primari i paesi che ne erano dotati subiranno una crisi, ma fintantoché tale eventualità non si presenti essi beneficeranno di un continuo apprezzamento di tali risorse, e quando essa si compirà rappresenterà un problema globale che richiederà un ripensamento radicale del modello economico in primo luogo nei paesi industrializzati, che se ne sono avvantaggiati per decenni.
Potere globale versus sviluppo locale 3
I fenomeni descritti sembrano accreditare l’ipotesi di una redistribuzione del potere economico a livello globale (Armijo, 2007), grazie ad una sempre maggiore dipendenza dei paesi del Nord dalle risorse del Sud del mondo. Da questo punto di vista, acquisisce importanza la complementarietà tra le economie dei due grandi gruppi di paesi, l’interdipendenza invece della competizione, che restituisce potere negoziale a chi aveva vissuto finora un situazione di subalternità. Questa tesi è molto simile a quella che Nicholas Kaldor aveva espresso nel maggio 1984 nella terza lezione di un ciclo di conferenze tenute in memoria del banchiere Raffaele Mattioli presso l’Università Bocconi di Milano. Nelle prime due giornate seminariali, i temi affrontati avevano riguardato il dibattito sulla crescita economica ed il confronto critico tra le posizioni legate alla teoria neoclassica dell’equilibrio e le posizioni di ispirazione keynesiana. Kaldor aveva sottolineato come, in economia chiusa, nei modelli ad un solo bene la crescita della capacità produttiva è giustificata dalla crescita della domanda di consumi, che a sua volta è indotta dai nuovi investimenti. Se ci si pone nell’ottica dei settori, come nella terza lezione milanese, accanto a questo processo emerge il problema delle interdipendenze tra le diverse parti dell’economia, che perciò possono essere considerate complementari, dal momento che lo sviluppo di ciascun settore dipende in modo cruciale dalle relazioni che esso intrattiene con gli altri.
Nell’esposizione del suo schema teorico, Kaldor (1984 [1996]) si riferisce alla tradizionale ripartizione tra attività land-based ed attività manifatturiere, mentre i servizi sono considerati come attività in parte rese alle imprese di produzione ed in parte alla collettività in generale e rimangono al di fuori dell’analisi. Il legame tra i due settori produttivi è definito in questo modo: ogni settore rappresenta il mercato per i beni prodotti dall’altro e ne è allo stesso tempo – direttamente, come nel caso dell’industria, o indirettamente, come in quello dell’agricoltura – il fornitore dei mezzi di produzione necessari. All’estensione del mercato corrisponde l’espansione dell’attività manifatturiera. In questo processo la crescente divisione del lavoro, e quindi l’incremento di produttività del lavoro, rende i prodotti più a buon mercato. Di conseguenza si innesca un processo di crescita auto-sostenuta.
Trascurando per semplicità gli aspetti tecnici del modello, possiamo coglierne il significato di fondo considerando i rapporti di domanda reciproca tra i due settori. Nel settore land-based il surplus agricolo (ovvero la parte di prodotto che non viene consumata all’interno dell’agricoltura) può essere ceduto all’industria in cambio di beni capitali. Di conseguenza il tasso di accumulazione in agricoltura dipende negativamente dalla ragione di scambio definita come rapporto tra il prezzo dei beni industriali e il prezzo dei beni agricoli: se i primi diventano relativamente meno costosi il settore può aumentare i suoi investimenti e quindi svilupparsi ad un tasso più elevato. Nel settore manifatturiero, invece, la relazione è opposta: maggiore è la ragione di scambio intersettoriale, maggiore sarà la capacità dell’industria di investire, dal momento che il “grano” costerà meno in termini di “ferro”. Di conseguenza il tasso di accumulazione dell’industria dipende positivamente dalla ragione di scambio.
Questi rapporti di domanda reciproca determinano un “vincolo di complementarietà” tra i due settori, che può essere illustrato graficamente (Thirlwall, 1986) nella fig. 1, dove con la linea ga si indica la relazione inversa tra crescita del reddito in agricoltura e ragione di scambio (p), mentre con la linea gm si indica la relazione diretta tra crescita del reddito nell’industria e ragione di scambio. Le domande reciproche di beni raggiungono l’equilibrio per quel valore della ragione di scambio (p*) che rende uguali i due tassi di crescita (ga = gm = g*). Lo sviluppo di ciascun settore è vincolato all’altro.
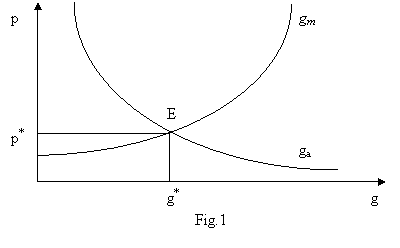
Si può dimostrare che il progresso tecnico e la concorrenza rendono stabile l’equilibrio. In realtà lo schema di Kaldor rappresenta una forte semplificazione della realtà, innanzitutto perché assume che le strutture delle domande rimangano sostanzialmente stabili. In realtà ciascun settore può domandare percentuali crescenti o decrescenti dell’altro bene rispetto al proprio reddito, ad esempio per fenomeni di meccanizzazione agricola. Se la domanda dell’altro bene cresce allo stesso ritmo del reddito, allora siamo nel caso di Kaldor e l’equilibrio è dato dal pareggio dei tassi di crescita dei due settori. Se invece la domanda dell’altro bene può crescere in modo più o meno proporzionale rispetto al reddito, allora la relazione di equilibrio è del tipo:
ma ga = mm gm
dove ma e mm rappresentano le elasticità della domanda di acquisti dell’altro bene rispetto al reddito di ciascun settore, cioè indicano se la percentuale di acquisti dell’altro bene aumenta (in questo caso m > 1) o diminuisce (e allora m < 1) rispetto al proprio reddito. Questo nuovo vincolo è noto in letteratura come legge di Thirlwall 4 (1979). In questo caso più generale vi saranno dunque tassi di crescita diversi tra i due settori, a favore di quello che riuscirà ad “allentare” il vincolo di complementarietà. La nuova rappresentazione grafica dipende dai valori delle elasticità. Nel caso classico dei rapporti tra Paesi Industrializzati e Paesi in Via di Sviluppo si può considerare il noto argomento di Prebisch, secondo cui il possesso delle tecnologie industriali a vantaggio del primo gruppo condannava il secondo ad una domanda crescente di beni industriali, dunque al peggioramento progressivo della ragione di scambio ed all’aggravarsi delle disuguaglianze mondiali, come del resto i dati delle tabelle 1 e 2 sembrano confermare fino alla fine del XX secolo. In questo caso ma > 1 e mm < 1 e la rappresentazione grafica è quella della fig. 2:

Fig. 2
Come si può vedere, il punto di equilibrio è quello in cui si incontrano le due linee di domanda reciproca ma ga emm gm. In questo punto si determina la ragione di scambio, cui corrispondono tassi di crescita compatibili con il vincolo di complementarietà diversi per i due settori, in questo caso: ga* < gm*.
Tuttavia, è possibile immaginare un caso diverso in cui – ferma restando la tendenza del settore land-based a consumare proporzioni sempre maggiori di beni tecnologici provenienti dal settore avanzato (ma > 1) – anche quest’ultimo si trovi costretto ad acquistare proporzioni maggiori di beni tradizionali e materie prime (mm > 1). Se il cambiamento in atto nei Paesi Industrializzati è più forte di quello che interessa i PVS, allora si può avere una riduzione della ragione di scambio ed un processo di convergenza economica a livello mondiale, ga* > gm*, come illustrato nella fig. 3:
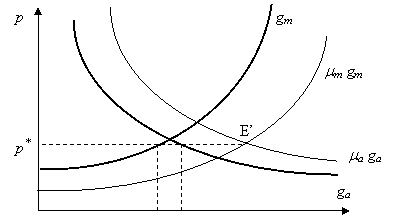
Fig. 3
In definitiva, modifiche delle complementarietà tra settori – dovute a cambiamenti tecnologici o a variazioni nella struttura delle preferenze – conducono a tassi di crescita generalmente differenti tra loro. Si verificano in tal modo cambiamenti profondi nei rapporti economici a livello mondiale.
Lo schema proposto può essere molto utile per interpretare i mutamenti che si sono realizzati negli ultimi anni. In primo luogo abbandoniamo la classificazione settoriale seguita finora e consideriamo invece una divisione geografica del tipo Nord-Sud del mondo. In secondo luogo consideriamo i fatti stilizzati messi in evidenza in precedenza all’interno dello schema concettuale proposto. Le dimensioni dei paesi emergenti, la concentrazione delle nuove tecnologie nel Nord e dei fattori tradizionali dello sviluppo nel Sud ed il ruolo strategico delle nuove materie prime possono giustificare una situazione del tipo rappresentato in fig. 3: nonostante la dipendenza tecnologica dal Nord, l’importanza delle risorse land-based concentrate nel Sud del mondo è tale da rovesciare la ragione di scambio internazionale ed aprire una nuova stagione di convergenza dei redditi mondiali.
Nell’economia globalizzata il rapporto con i mercati internazionali è un indiscutibile fattore di successo o di fallimento delle economie nazionali e la loro diversa capacità di competere comporta profondi mutamenti nella tradizionale divisione tra Paesi Industrializzati e Paesi in Via di Sviluppo. Tuttavia l’effetto complessivo di tali trasformazioni all’interno dei singoli paesi è oggetto di interpretazioni controverse e spesso contrastanti. Per considerare anche questo aspetto, è interessante allora classificare le attività economiche interne definendo due nuovi gruppi di attività produttive:
- un settore, che possiamo chiamare globale, che comprenda tutte le attività che si proiettano direttamente verso i mercati internazionali, come: investimenti diretti esteri, coltivazioni estensive e industrie nazionali d’esportazione, o che sono ad essi fortemente legati, come nel caso di attività estrattive, infrastrutture per la grande impresa, servizi commerciali e finanziari avanzati;
- un settore, che definiamo locale, il quale, invece, includa le attività rivolte principalmente al territorio di appartenenza e al mercato interno, come: imprese locali, cooperative, servizi personali, costruzioni, commercio al dettaglio, trasporti interni, ecc.
In effetti, in entrambi i casi, l’effettiva qualificazione di ciascuna attività economica come locale o globale non dovrebbe essere decisa a priori, ma valutata alla luce dei comportamenti economici rilevanti. Mentre il settore globale tende ad assumere la stessa fisionomia in tutti i paesi, il settore locale è fortemente condizionato dalle caratteristiche del territorio e in generale da tutti i fattori socio-economici specifici. Perciò, nel caso dei PVS, è rappresentato prevalentemente da attività di sussistenza delle fasce povere della popolazione e da tutte le iniziative di piccole dimensioni che, in condizioni favorevoli, potrebbero costituire la base economica di una classe media nascente. Tali attività, spesso comprese nel settore informale, ma non solo, sono cresciute nell’ombra e, in alcuni casi, costituiscono anche esperienze di successo, come ad esempio le pratiche nate dal basso come il microcredito o le reti di cooperative artigiane o contadine, che però non hanno ancora raggiunto una scala rilevante. Questo settore locale attualmente deve essere preso in considerazione per due ordini di motivi: perché conta molto in termini di popolazione (anche se non in termini di reddito monetario) e perché può essere strumento di politiche per lo sviluppo locale.
I due gruppi di attività così formati si differenziano tra loro per il contesto in cui operano ed a cui di conseguenza sono orientati. Il criterio di appartenenza ai due sotto-settori deve tenere conto di indicatori che si riferiscono ad aspetti diversi: l’origine delle risorse utilizzate, le destinazioni dei prodotti, la presenza nel territorio, la distribuzione del valore aggiunto, ecc. I due sotto-gruppi rappresentano, in un certo senso, due anime dello sviluppo: quella che tende al mercato estero e ad un sistema centralizzato; quella più legata allo sviluppo del mercato interno attraverso attività decentrate. Si possono così individuare costellazioni alternative di attività globali e locali in base ai legami che stabiliscono con i mercati internazionali e tra di esse. In uno schema Nord-Sud, allora, ci si aspetta che i settori globali (sia nel Nord che nel Sud) presentino valori bassi delle elasticità degli acquisti o delle importazioni, al contrario dei settori locali del Sud che rimangono generalmente dipendenti dalle tecnologie e dai prodotti più avanzati. Le attività locali del Nord, invece, hanno raggiunto nel tempo un livello di integrazione più elevato con l’economia globale, riuscendo a conquistare nicchie di mercato o affermando prodotti specializzati, come nel caso di piccole e medie imprese di esportazione in settori ‘di punta’, produzioni tipiche, ecc.
Un elemento importante è l’intensità dei legami tra settori all’interno di ciascun paese. Secondo un’analisi che è ormai classica dell’economia dello sviluppo che segue l’approccio Input-Output, vanno in particolare studiati i cosiddetti legami a monte o backward linkages e legami a valle o forward linkages. I primi riguardano gli acquisti da parte di un settore di input provenienti dagli altri: un indice sintetico di tali legami può esprimere dunque la capacità del settore di esercitare una domanda interna nei confronti degli altri, di essere un cliente. I secondi, invece, riguardano gli acquisti da parte degli altri settori del prodotto considerato: un indice sintetico può esprimere, in questo caso, la possibilità del settore di rivolgersi al mercato interno, di essere quindi un fornitore. Diversi metodi, inoltre, propongono di considerare un indicatore sintetico di entrambe le tipologie di legami, che esprimerebbe il grado di complementarietà tra il settore ed il resto dell’economia del paese. Se poi confrontiamo questo aspetto con i legami produttivi e commerciali con l’estero, possiamo ricavare una visione più completa dei flussi produttivi e commerciali che riguardano i settori e dunque del loro ruolo funzionale all’interno del sistema economico di appartenenza. Si possono ottenere molti casi possibili: tra quello virtuoso di settore integrato esportatore e quello vizioso di settore non integrato importatore vi sono molte situazioni intermedie. Si possono anche costruire delle vere e proprie mappe dei legami tra settori e con l’estero, per poter apprezzare come si strutturi l’economia del paese e nel complesso quali siano i punti di forza locali e globali. Un’analisi di questo tipo consentirebbe di individuare le traiettorie seguite dai vantaggi o svantaggi economici ottenuti nel rapporto con l’economia globale, le vie di diffusione al resto dell’economia e definire nuove politiche di intervento per incentivarne gli aspetti positivi e scoraggiarne quelli negativi.
La configurazione della struttura economica tra gruppi di attività locali e globali ha infatti un’incidenza sul benessere e sulla crescita economica del paese.Infatti, dal momento che i settori locali possono essere considerati dei “diffusori”, mentre quelli globali dei “concentratori” di benefici economici, i loro effetti nel processo di sviluppo sono molto rilevanti. Si possono figurare diversi scenari: da quello di sviluppo integrato di lungo periodo, che vede l’espansione dei settori locali in grado di esportare parte della loro produzione e moltiplicare nel sistema interno i benefici acquisiti, a quello di sviluppo duale, con i settori globali unici esportatori e i locali limitati ad attività di sussistenza. Tra questi, è ipotizzabile anche uno scenario di complementarietà locale-globale, in cui gli attori globali si specializzano nelle attività più competitive ma mantengono rapporti stretti con i settori locali, con effetti positivi sui fattori di sviluppo di lungo periodo.
Il luogo del Buon Governo e della convivenza
Di fronte al nuovo scenario dei rapporti internazionali, prima di considerare quali possono essere le scelte politiche ed i contenuti del Buon Governo, occorre capire qual è il suo “luogo”, ovvero quale collocazione può avere una politica economica che agisca per conseguire il bene comune, per rafforzare i diritti, ripartire equamente il potere, promuovere lo sviluppo umano in armonia con l’ambiente naturale.
In questo quadro globale rischia di essere messo in secondo piano il ruolo delle politiche nazionali e quindi la stessa possibilità di intervenire a vantaggio della prosperità, della pace e della giustizia per i propri cittadini. Il luogo del Buon Governo è allora nei rapporti tra settori locali e settori globali della società, nella consapevolezza che la qualità di vita delle persone si determina sul territorio coltivando rapporti di complementarietà e reciprocità. In questo campo si possono sviluppare azioni che favoriscano la diffusione degli effetti positivi dei settori globali al resto del sistema, oppure che difendano i settori locali dalle crisi o dagli shock esterni; ma anche politiche per la promozione della coesione sociale e territoriale, per il decentramento amministrativo, la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, la protezione del patrimonio culturale e naturale. Inoltre, in un sistema di interdipendenze mutue sempre più forti, i rapporti tra settore locale e settore globale all’interno di ciascun paese influenzano anche la qualità dei rapporti globali tra questo paese e gli altri. Basti pensare all’effetto sull’estensione del mercato che possono avere politiche redistributive in grandi paesi come i BRICs. E’ pur vero che il numero assoluto dei “pochi” ricchi può essere già sufficiente per avere un certo potere di mercato, tuttavia la concreta capacità di incrementarlo, quindi di migliorare anche la dimensione relativa del fenomeno, può portare a vantaggi dirompenti nei rapporti globali, persino sulla crescita economica mondiale. Si tratta poi di un miglior benessere sociale o, come proposto in alcuni paesi dell’America del Sud, “buon vivere”. Da questo punto di vista investire nel miglioramento delle relazioni tra persone può favorire la crescita del capitale sociale, la prevenzione dei conflitti ed una maggiore sicurezza. La promozione del tessuto di piccole e medie imprese, ma anche lo sviluppo del Terzo Settore e quindi della società civile organizzata nel Sud del Mondo possono essere considerate politiche che concorrono al Buon Governo. Sullo stesso piano possono essere considerate politiche di protezione e uso sostenibile delle risorse naturali, dal momento che il loro valore dipende solo dal loro concreto sfruttamento economico ma anche dalla loro conservazione 5.
Altro elemento cruciale che può guidare le scelte di Buon Governo nei PVS e nei BRICs è la progressiva democratizzazione dell’economia. Infatti i grandi benefici accumulati in questi anni sono il riflesso di processi di delocalizzazione, investimenti globali, tendenze speculative che seguono le convenienze di grandi gruppi di interessi privati il cui campo di intervento è il mondo e che non possono più essere identificati con il blocco Stati Uniti – Europa. Si tratta piuttosto di una elite globale che muove enormi risorse a livello planetario (Krugman, 2009) 6. I loro vantaggi sono per lo più invisibili perché domiciliati presso paradisi fiscali o perché rappresentati dai nuovi strumenti finanziari che sfuggono ai controlli delle autorità economiche. Dal momento che le risorse strategiche dei PVS e dei BRICs sono fortemente land-based, la loro crescita economica può rappresentare una valida opposizione a tali tendenze monopolistiche, favorendo una maggiore distribuzione del benessere economico e notevoli miglioramenti nella qualità di vita delle loro popolazioni.
Dal momento che le risorse strategiche dei PVS e dei BRICs sono fortemente land-based, la loro crescita economica può rappresentare una valida opposizione a tali tendenze monopolistiche, favorendo una maggiore distribuzione del benessere economico e notevoli miglioramenti nella qualità di vita delle loro popolazioni.
Bibliografia
Armijo, L. E. (2007), “The BRICs countries (Brazil, Russia, India, and China) as analytical category: mirage or insight?”, Asian Perspective, Vol. 31, n. 4.
Colombi C. (2007), Un modello neokaldoriano di sviluppo economico. Complementarietà tra settori produttivi, cambiamento strutturale ed economia aperta, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Roma “Sapienza”.
Dierckxsens V. (2012), “Potere sociale del Sud per un cambiamento di razionalità economica”, Agenda Latinoamericana Mondiale 2013, edizione italiana.
European Commission (DG Enterprise and Industry) (2010), Critical raw materials for the EU Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials, http://ec.europa.eu/
European Parliament (STOA: Science and Technology Options Assessment) (2011), Future Metal Demand from Photovoltaic Cells and Wind Turbines. Investigating the Potential Risk of Disabling a Shift to Renewable Energy Systems, http://www.europarl.europa.eu/
Holly Bell, A. (2011), “Status of the ‘BRICs’: an analysis of growth factors”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 69.
Kaldor N. (1984 [1996]), Causes of Growth and Stagnation in the World Economy, Cambridge University Press.
Krugman, P. (2009), Il ritorno dell’economia della depressione e la crisi del 2008, Garzanti.
Salvatore D. (2010), “Globalisation, international competitiveness and growth: advanced and emerging markets, large and small countries”, Journal of International Commerce, Economics and Policy, Vol. 1, n. 1.
Sridharan P., N. Vijayakumar e K. Chandra Sekhara Rao (2009), “Causal relationship between Foreign Direct Investment and growth: evidence from BRICS Countries”, International Business Research, Vol. 2, n. 4, Ottobre.
Thirlwall A. P. (1979), “The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences”, Quarterly Review Banca Nazionale del Lavoro, Marzo.
Thirlwall A. P. (1986), “A General Model of Growth and Development on Kaldorian Lines”, Oxford Economic Papers, 38.
Wilson D. e R. Purushothaman (2003), “Dreaming with BRICs: The Path to 2050”, Global Economics Paper,Goldman Sachs, n. 99, Ottobre.
NOTE:
1 La ragione di scambio è aumentata anche per i paesi produttori di petrolio (Venezuela +158,7%, Angola +144,7%, Arabia Saudita +115,8%, Nigeria +111,4%, ecc.) sul quale però si concentra la quasi totalità delle loro esportazioni.
2 A titolo di esempio indichiamo: il Gallio per la produzione di celle fotovoltaiche, il Neodimio per la tecnologia laser, l’Indio per i display, il Cobalto e il Litio per le batterie di nuova generazione, ecc. Per una trattazione più completa è possibile consultare alcuni rapporti dell’Unione Europea indicati in bibliografia.
3 L’analisi teorica riportata in questo paragrafo segue e sviluppa l’argomento principale della mia tesi di dottorato (Colombi C., 2007).
4 La “legge di Thirlwall” è una relazione di lungo periodo, che vale al tasso di cambio di ‘equilibrio’ (cioè che garantisce il pareggio della bilancia commerciale).
5 Un esempio pionieristico di questa strada alternativa è quella sperimentata dall’Ecuador con l’iniziativa Yasuní-ITT che prevede l’impegno indefinito da parte del governo a non estrarre il petrolio esistente nel sottosuolo del parco naturalistico omonimo, ed equivalente a ben il 20% delle riserve di greggio del paese, in cambio della raccolta di risorse finanziarie dalla comunità internazionale pari al 50% del mancato ricavo che costituiscono un fondo di investimento per lo sviluppo umano amministrato dal PNUD (http://yasuni-itt.gob.ec).
6 Edizione riveduta ed ampliata de “Il ritorno dell’economia della depressione” del 1999, che commentava le crisi finanziarie degli anni ’90 prevedendo nuove crisi negli anni successivi. Nel 2008, anno dell’inaspettata crisi negli USA, Paul Krugman è stato insignito del Premio Nobel per l’economia.
 IT
IT  EN
EN 
















