
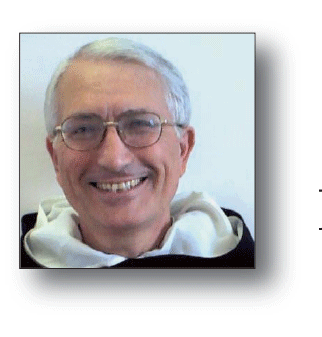
FRANCESCO COMPAGNONI
![]() l tema del presente fascicolo di OIKONOMIA è “ Migrazioni e diversità culturali”. Nella Pagina Classica riportiamo il testo originale della definizione - nota a studiosi e studenti - di “cultura” scritto 150 anni fa dal ‘primo’ antropologo culturale, E. B. Tylor . Impostazione fondamentalmente rimasta valida, almeno come punto di partenza, per la riflessione contemporanea.
l tema del presente fascicolo di OIKONOMIA è “ Migrazioni e diversità culturali”. Nella Pagina Classica riportiamo il testo originale della definizione - nota a studiosi e studenti - di “cultura” scritto 150 anni fa dal ‘primo’ antropologo culturale, E. B. Tylor . Impostazione fondamentalmente rimasta valida, almeno come punto di partenza, per la riflessione contemporanea.
Anche per il termine ‘migrazioni” possiamo rifarci a qualche cosa di ‘non nuovo’, di tipicamente umano. E questo in due sensi. Nel primo, ricordandoci che gli uomini si sono quasi sempre spostati in gruppo, quindi portandosi dietro non solo le proprie categorie mentali, ma anche quelle sociali che permettevano loro di ritrovare un ambiente nel quale vivere decorosamente. Nel secondo senso, in quanto gli Organismi Onu ci indicano che attualmente i migranti sono 200 milioni in tutto il mondo, il che significa che oggi nel mondo più di una persona su 30 è un migrante. Parliamo pertanto di un fenomeno umano da sempre rilevante.
Quando si migra ci si porta appresso dunque tutto il nostro Io, individuale e sociale, non meno importante che il nostro corpo o i beni materiali. La lingua innanzi tutto, con tutte le implicazioni che essa coinvolge. Senza la nostra cultura noi siamo sradicati, ma non nel senso che ci mancano in qualche modo il nostro passato, bensì nel senso stretto che senza radici culturali l’uomo non può proprio sopravvivere, come per i vegetali.
Normalmente migrando abbandoniamo una parte delle vecchie convinzioni per adottarne una parte di nuove, ma il processo non è assolutamente indolore. Anzi è complesso e genera spesso distorsioni individuali e sociali di vario genere.
Fino a non molto tempo fa il modello ritenuto di successo era il melting pot statunitense, che però ora non funziona più. Forse perché si sono ‘mischiate’ materialmente troppe componenti diverse, ed una società statuale con troppo differenze al suo interno - per esempio gli ispanici in USA che non padroneggiano l’inglese – non può essere efficientemente ‘madre di tutti’.
Si ricorre allora a modelli/slogans come: imparino la nostra lingua, accettino la nostra costituzione, accettino i diritti umani. Ma si potrebbe anche chiedere, ad esempio: accettino la nostra religione? Oppure la nostra società laicizzata?
L’integrazione potrebbe partire da quest’ultima base concettuale (i migranti devono assimilare i fondamenti sociali della nuova patria), ma è necessario che questo metodo non resti senza influenza anche sulla cultura che integra i migranti/immigrati. I milioni di turchi in Germania hanno cambiato qualche cosa della cultura tedesca? Di fatto ciò è già avvenuto. Facilitato dal fatto che dopo la Germania ipernazionalista di Hitler quella attuale non potrebbe permettersi nessuna forma di sciovinismo di fronte ai propri partners dell’Unione Europea.
Anche chi accoglie, dunque deve cambiare, e deve anche soffrire, probabilmente. Ma la situazione cambia se il migrante verso l’Europa ha una qualche comunanza storica, o la stessa religione, come quelli dal Vicino Oriente, oppure se è un cinese? Tali cinesi vengono, dice il presidente Romano Prodi, dalla stessa provincia, per questo ci sembrano un blocco inscalfibile di commercianti; comunque sappiamo che la millenaria migrazione cinese non si è lasciata facilmente colonizzare: si pensi alle comunità cinesi di tutto l’Estremo Oriente che sono ancora tali dopo secoli.
Il futuro sviluppo, vicino e lontano, di questo nostro problema non è prevedibile, data la quantità e velocità che ha assunto. Come non lo era l’assalto degli ultimi anni all’Europa dall’Africa e dal vicino Oriente.
Meglio, quindi, non pensare a soluzioni apodittiche, rigide. Perché il fenomeno si evolve e in fondo non sappiamo quanto un gruppo consistente può abbandonare la propria cultura di origine senza danni per sé e per il paese ricevente. Si pensi alla tragica situazione della migrazione africana negli USA e alle periferie (banlieue) nordafricane in Francia.
Il pericolo, come possiamo vederlo oggi, è che non si arrivi a formare nessuna nuova cultura condivisa. E che quindi lo Stato – per salvaguardare le sue funzioni basilari - diventi sempre più repressivo nei confronti dei non conformismi. Oppure che gran parte delle nuove società siano oppresse da élites capaci. Oppure che il tutto si riduca a cercare il minimo comune tra tutti. Quest’ultima possibilità significherebbe solo materialismo, perché è solo sui beni materiali che si trova presto un accordo.
L’obiettivo, molto idealista, è che le culture si influenzino reciprocamente, ma tendano in questo ad un maggior grado di umanizzazione universale. Tenendo presente in questo come stella guida i diritti umani. Ed anche tenendo conto del fatto che si parte dai valori basici - nel senso dell’etica globale di H. Küng - che le grandi religioni universali hanno sempre professato e proposto (anche se raramente realizzato…).
Le scienze sociali non possono non interessarsi di migrazioni e identità culturali dal loro punto di vista scientifico, e quindi anche abbastanza astratto. La prassi storica sarà diversa da quella auspicata o prevista, ma solo riflettendo sistematicamente sui dati attuali possiamo prepararci ad un futuro meno catastrofico e meno doloroso. Meno doloroso per ‘loro’ ma anche per ‘noi’.
I testi che proponiamo alla lettura sono alquanto diversificati, ma raggruppabili in due insiemi.
G. Barzaghi, filosofo classico e cristiano, riflette sull’identità e l’alterità, ed il suo pensiero ci mostra quali radici dell’essere tocchi il problema di scontri/incontri di identità umane diverse.
D. Fedeli, pedagogista, ci espone la problematica del firmarsi della personalità nel periodo evolutivo del bambino, sottoposto ugualmente a influssi neurobiologici ed ambientali.Antonino Urso e Teresa De Bonito, psicologi e psicanalisti, presentano la problematica partendo dal di dentro della persona. E di qualsiasi persona, di qualsiasi cultura.
Questi tre, sono testi che si riferiscono al perennemente Humanum.
Anche il testo sull’identità sessuale di S. Cipressa è vicino alla problematica strutturale della propria identità/accettazione sociale. Con l’aggravante nel nostro contesto di studio, che il ‘diverso’ ha spesso maggior difficoltà all’adeguamento indolore nella nuova cultura.
Il testo di Leonardo Quarenta è invece un testo esperienziale e vissuto: dice molto su di questo giovane angolano che è uno studente (del mondo) ed un musicista.
Anche la testimonianza di Anna Carelli è di questo genere. Ma dal punto di vista europeo. Un figlio di A. Carelli ha sposato una ragazza congolese, e quindi le nipotine di A. Carelli sono in qualche modo italiane di seconda generazione.
Infine il testo di G. Piazza ci presenta un’esperienza comunitaria di accoglienza fondata decenni fa ed in continua evoluzione
Nella rubrica Spazio Aperto ospitiamo un contributo di Giuseppe Casale sull’autonomia della politica ed uno di Giuseppe Trentin sull’argomentazione morale. Entrambi gli studi sono di carattere metodologico, ma nella scienza ‘metodologia’ significa ‘logica’, quindi correttezza dei processi di conoscenza. Di qui la loro rilevanza.
Vi si aggiunge di M.A. Ciclista la lucida relazione del seminario “La Città e l’urbanizzazione di oggi” che si è svolto, da ottobre 2016 a giugno 2017, presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’Angelicum. Tema per nulla lontano da quello generale delle migrazioni.
 IT
IT  EN
EN 



















