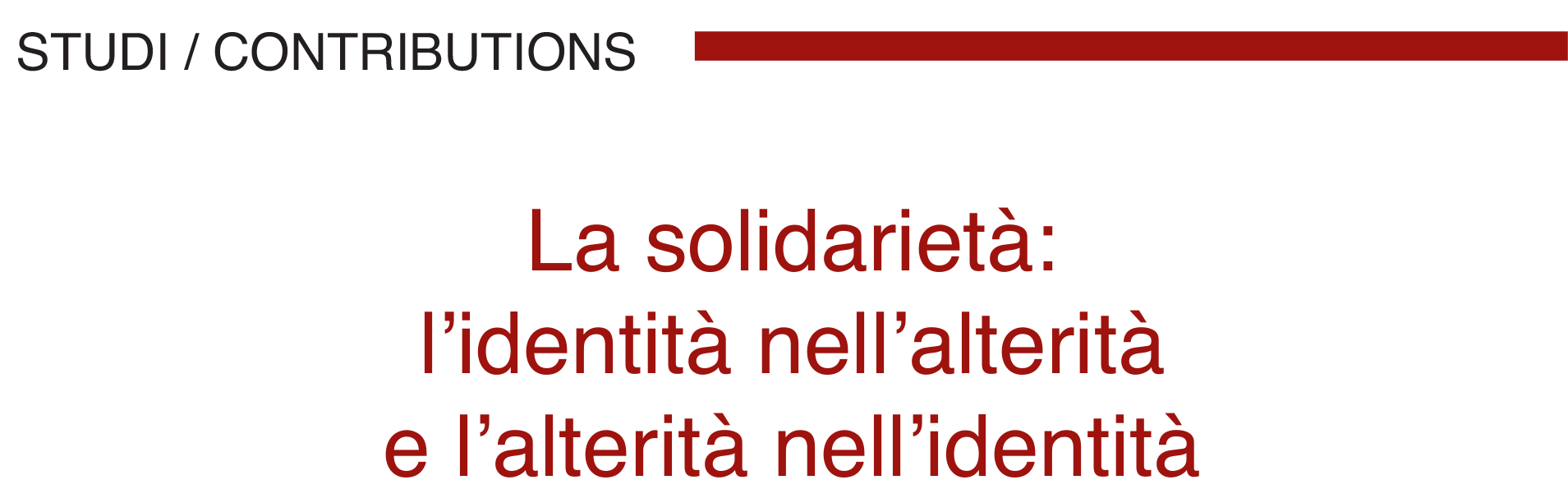
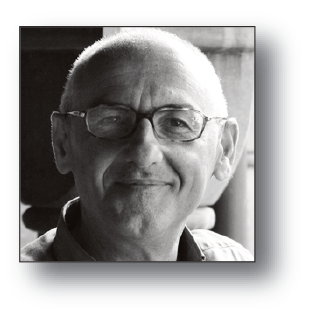
GIUSEPPE BARZAGHI
Una connessione logicamente necessaria: identità e alterità
![]()
 l tema è certamente un po' difficile e parte da quello che nella logica è il principio fondamentale, che costituisce il binario su cui corre ogni sapere dialettico: il principio di identità. La formulazione del tema non è altro che una declinazione di questo principio. Sul piano formale, cioè logico, ci troviamo con una formulazione essenzialmente astratta e quindi "universale", che vale cioè sempre, per tutti e comunque: un principio logicamente "indiscutibile".
l tema è certamente un po' difficile e parte da quello che nella logica è il principio fondamentale, che costituisce il binario su cui corre ogni sapere dialettico: il principio di identità. La formulazione del tema non è altro che una declinazione di questo principio. Sul piano formale, cioè logico, ci troviamo con una formulazione essenzialmente astratta e quindi "universale", che vale cioè sempre, per tutti e comunque: un principio logicamente "indiscutibile".
Ma proprio per questo, la nostra esigenza di concretezza richiede una "esemplificazione", una sua traduzione in "esempio concreto", quello che Tommaso d‘Aquino chiamava una conversio ad phantasmata, che si riferisce alla fantasia e viene in soccorso della ragione astratta-universale con qualche "esempio". In soldoni lo facciamo quando invitiamo qualcuno a comprendere qualcosa dicendo: “prova a immaginartelo”. Compito dell'intelligenza, secondo Tommaso d‘Aquino, è quello di cogliere il particolare nell'universale e l‘universale nel particolare. È in questa linea che occorre collocare la nostra riflessione sulla "identità nell'alterità e l'alterità nell'identità".
Parto da un "esempio" molto particolare: la fuga in sol minore BWV 578 di J.S. Bach, Come si sa, in musica si danno due modalità tonali: "maggiore", allegra, gioiosa, e "minore", dimessa, triste, luttuosa. Ebbene, Bach in questa "fuga", pur con una tonalità "minore", imposta un motivo gioioso. La fuga di Bach, pur essendo in sol minore, ci ricorda non una scena triste ma piuttosto un gioioso girotondo di bambini. È questa l'opera del genio: far cogliere la gioia nella tristezza, il positivo nel negativo, l'identità nell'alterità. È questo il compito dell'intelligenza, la conversio ad phantasmata di Tommaso d‘Aquino.
Passiamo ad un altro esempio, che ci avvicina di più alla logica formale. Quando dico: "Quest'orologio è mio", faccio contemporaneamente due operazioni contrapposte: un'affermazione-inclusione esplicita: "È mio", e una negazione-esclusione implicita: "Non è tuo, né di alcun altro". Ogni affermazione è una negazione, dice la logica medievale. In ogni positivo c‘è un negativo e viceversa. Il principio di identità della logica formale si esprime in maniera semplicissima: "A è A", “Giuseppe è Giuseppe”, e appunto per questo è evidente e incontrovertibile, ma non ci aiuta a conoscere né "A", né "Giuseppe". Se vogliamo conoscere e comprendere, non possiamo ripetere all'infinito “A è A”, ma dobbiamo cercare di esplicitare "che cosa è A" e la prima operazione da compiere è una "negazione": distinguere “A” da tutto ciò che non è A e quindi dire "A non è non A" (ogni affermazione contiene una negazione). Due negazioni affermano, ma in questo caso l'affermazione è precisata dalla esclusione di tutto ciò che non è A, tutto ciò che è "altro" da A: l'identità si precisa quindi con l'alterità. È quanto già nell'antichità era stato affermato da Platone che nel Sofista insegna come, per scoprire l'identità di una realtà, bisogna sempre relazionarla con l'alterità che la delimita e la precisa. L'identità è nell'alterità e viceversa: non può sussistere l‘una senza l'altra. Inclusione ed esclusione in questo caso non sono contraddittori ma complementari: nell'identità di A viene incluso ciò che viene escluso, cioè tutto il resto. L'alterità, quindi, si presenta come necessaria per qualificare l'identità. La totalità dell'universo (l'alterità) si rivela necessaria alla comprensione dell'identità anche della più piccola parte di esso. Identità e alterità sono logicamente e necessariamente interconnesse.
Il passo teologico
Cerchiamo adesso di calare il discorso sul piano che più ci interessa, cioè quello teologico1. Che cosa qualifica l'identità cristiana alla luce di quanto si è detto? Per una risposta ci viene in aiuto una lettura attenta e contemplata della Sacra Scrittura. Prendiamo un episodio del Vangelo. I discepoli dicono a Gesù: "Abbiamo visto alcuni che cacciavano i demoni nel tuo nome e non erano dei nostri e glielo abbiamo proibito". Gesù li rimprovera perché ciò che quelli avevano operato era stato loro concesso dal Padre e conclude: "Chi non è contro di noi è per noi" (Mc 9,39). Tale conclusione suona in contrasto con l'altra: "Chi non è con me è contro di me" e potrebbe indurci in confusione.
Ma, riflettendo, la seconda espressione vuole indicare che dinanzi a Gesù non si può rimanere indifferenti: o con Lui o contro di Lui, tertium non datur, non c'è la scappatoia dell'indifferenza neutrale. Mentre nel primo caso si trattava di gente che "operava nel suo nome" e quindi erano "con Lui", anche se i discepoli dicono: "Non sono dei nostri". Così si spiega l'apparente contraddizione: "Chi non è contro di me è per me", perché se non è "contro" è "per". È proprio questa seconda formulazione che merita un approfondimento: "Chi non è contro di me è per me", perché qui abbiamo due negazioni, "non... contro", che costituiscono, anche logicamente, un'affermazione e, precisamente, un‘affermazione di appartenenza a Cristo. Insomma, tanto per intenderci rapidamente: o bianco o non-bianco, ma basta esser non-non-bianco per esser bianco. La doppia negazione è l'affermazione.
Certo non si tratta di un'affermazione esplicita; essa va esplicitata e illuminata con altri passi e insegnamenti del Maestro. Ne ricordo qualcuno.
Alla fine dei tempi molti diranno: "Maestro siamo stati con te, abbiamo mangiato con te […], ma egli dichiarerà: In verità, non vi conosco [...] (Lc 13,26). “Ora io vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti" (Mt 8,11). Riflettendo su questi passi, tra i quali va ricordato tutto il discorso sulla fine dei tempi, quelli che dicevano di appartenere a Lui sono cacciati via e quelli che non appartenevano a Lui, ma "gli hanno dato da mangiare, da bere [...]”, che non lo conoscevano, che "non erano contro", si sentiranno dire: "Venite benedetti [...]".
La donna siro-fenicia (Mc 7, 24-30), che chiede al Maestro la guarigione della figlia, si sente rispondere da Gesù in maniera dura che non si dà ai cagnolini il pane dei figli. Alla replica della donna per cui anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalle mense dei figli, Gesù impressionato dalla sua fede opera la guarigione: e si trattava di una donna pagana.
Lo stesso dicasi, nel contesto drammatico della crocifissione, del centurione, che riconosce nell'urlo straziante di Gesù che muore il "Figlio di Dio".
Sono esempi diversi di "appartenenza a Cristo", di chi "è con Lui" perché non è "contro di Lui". Forse tra questi esempi il più significativo è quello del centurione che, "avendolo visto morire in quel modo”, il più ignominioso, e udito emettere "un forte grido", un urlo, lo proclama "Figlio di Dio". Riuscire a vedere il Figlio di Dio nell'uomo che muore in quella maniera, significa per un pagano una appartenenza reale, forte, anche se invisibile e implicita. È questo tipo di appartenenza che ci deve far riflettere sul senso da dare alla nostra vita di fede in maniera da non sentirci dire: "In verità non vi conosco".
Un esempio geometrico
Per far comprendere meglio agli studenti questo tipo di appartenenza, sono solito portare l'esempio di una figura geometrica come quella di un triangolo. Un triangolo lo posso pensare bianco o di qualsiasi altro colore e non cambia niente, rimane sempre triangolo. Il colore è indifferente. Ma dinanzi a Cristo non è possibile essere indifferenti. O si è con Lui o contro di Lui. Similmente la linea (il lato) appartiene al triangolo ma non è il triangolo. Essa appartiene "essenzialmente" al triangolo, anche se non è il triangolo e tantomeno è "contro" di esso. Comprendiamo così un po' meglio l'appartenenza essenziale di chi "non è contro" dal detto di Gesù: Chi non è contro di me è con me, mi appartiene. Il centurione di Cafarnao, la donna siro-fenicia visibilmente "non appartengono" a Gesù eppure di loro è riconosciuta una fede impressionante. Gesù, e solo Lui, è capace di vedere la loro fede e dichiararne così l'appartenenza a Lui.
La fede come estetica
Queste riflessioni ci inducono a ripensare la nostra appartenenza a Cristo, al significato che dobbiamo dare alla nostra vita cristiana in maniera "essenziale" anche se "invisibile"; sostanziale e non "accidentale". Al riguardo è necessario per noi acquisire il gusto di Dio e la sensazione del divino, che vanno al di là della visibilità sociale, ma sono capaci di cogliere la bellezza del mistero.
La fede così intesa diventa una "visione estetica", la scelta della bellezza divina, di Gesù, "in cui sono nascosti tutti tesori della sapienza e della scienza" divina, "in cui gli angeli desiderano fissare lo sguardo" (1 Pt 1,12). È questo quanto viene realizzato dai "mistici", coloro che colgono ed esperimentano ciò che non è esprimibile. (La radice del termine mistico significa essere chiuso, essere muto). L'esperienza mistica è la contemplazione inesprimibile del mistero della bellezza divina. Ciò che può avvicinarci a tale esperienza è la musica in certe pagine dei grandi geni, in cui si coglie la sintesi "indicibile" di positivo e negativo, di gioia e tristezza, di serenità e tragedia, di finito e infinito.
L'integrazione e la solidarietà
Dalla musica e dalla fede si può imparare in concreto che cosa significhi integrazione e solidarietà, perché sono l'educazione più intima della coscienza.
Di per sé l'integrazione sarebbe una operazione dialettica, come ho detto: l'inclusione dell'esclusione. Integrare può significare tre cose:
a) l'azione che porta all'integrità di qualcosa,
b) l'azione che colma una mancanza reciproca,
c) l'azione che scopre l'integrità nascosta.
Le prime due azioni partono dal negativo e lo devono negare. La terza parte dal positivo e lo esplicita. La terza è il modo concreto della fede cattolica: kata olou vuol dire secondo l'intero. Ed è lo sguardo sull'intero dal punto di vista di Dio. Esclude la violenza dell'imposizione e include la dolcezza della posizione originaria. L'originalità sta infatti nell'idea di scoperta: l'invenzione del medio della composizione o sintesi. Il medio non è lo strumento ma il centro, ciò che sta nel mezzo. 
Qui sta il rispetto delle coscienze: avere in sé l'altro da sé così come l'altro ci porta in sé, perché tutto sia custodito e cioè integro. Ciascuno custodisce tutto e ogni altro perché è custodito dal tutto e da ogni altro. Questa è la ricchezza infinita di ciascuna coscienza che sta nel riversarsi reciproco, il conversare. Forse è proprio lì che alberga la misericordia, la compassione che intesse l'intera creazione. “Conversatio nostra in coelis est”: la nostra conversazione è nei cieli (Fil 3,2). E così, la musicalità delle voci e delle idee risuona infinitamente in quello che papa Francesco ha definito come il poliedro, che “è uno ma ha facce differenti”2 .
In termini estetici potrei tradurre questa immagine in un caleidoscopio: l'unità nella diversità polivoca delle somiglianze e delle similitudini. E il conversare sarebbe l'edificio solido (solidus, solus, olos cioè ancora intero e integro) della vita nuova: Calandosi Onestamente Nella Velata E Ricca Sensibilità Altrui Reciprocamente Edificarsi. E il solidale è chi Scopre Ovunque L'Intero Dove Altri Lo Escludono.
NOTE:
1 Ho sviluppato in modo più articolato queste riflessioni in G. BARZAGHI, L'intelligenza della fede. Credere per capire, sapere per credere, ESD, Bologna 2012.Ho sviluppato in modo più articolato queste riflessioni in G. BARZAGHI, L'intelligenza della fede. Credere per capire, sapere per credere, ESD, Bologna 2012.
2 Cf. «Avere coraggio e audacia profetica». Dialogo di papa Francesco con i gesuiti riuniti nella 36ª Congregazione Generale, in “La Civiltà Cattolica”10 dicembre 2016, p. 426.
 IT
IT  EN
EN 



















