
DANIELA BIGNONE

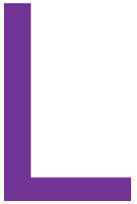 ’Agenda 2030, approvata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è il prodotto di un percorso articolato di grande valore semantico. Nel loro libro, pubblicato nel 2017, Felix Odd (Membro del Global Research Institute, affiliato senior all'Università del North Carolina e Associato all'Istituto Tellis), l'Ambasciatore David Donoghue (Rappresentante permanente dell'Irlanda alle Nazioni Unite) e Jimena Leiva Roesch (Senior Policy Analyst all'International Peace Institute), attraverso il vissuto della preparazione, offrono un’analisi dettagliata della costruzione dei SDGs e introducono novità concettuali e metodologiche che si prestano al confronto con il pensiero sociale cristiano.
’Agenda 2030, approvata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è il prodotto di un percorso articolato di grande valore semantico. Nel loro libro, pubblicato nel 2017, Felix Odd (Membro del Global Research Institute, affiliato senior all'Università del North Carolina e Associato all'Istituto Tellis), l'Ambasciatore David Donoghue (Rappresentante permanente dell'Irlanda alle Nazioni Unite) e Jimena Leiva Roesch (Senior Policy Analyst all'International Peace Institute), attraverso il vissuto della preparazione, offrono un’analisi dettagliata della costruzione dei SDGs e introducono novità concettuali e metodologiche che si prestano al confronto con il pensiero sociale cristiano.
Panoramica generale
Il capitolo 4 racchiude nel termine ‘transformational’ una implicita valutazione sul documento. Nella lingua italiana questo termine è usato in relazione alla grammatica generativa che “possiede regole in grado di trasformare le strutture profonde delle frasi in strutture superficiali diverse”1. Esso indica quindi capacità di trasformazione profonda, a livello strutturale. Nel testo è ricorrente l’espressione 'never before': mai prima un unico accordo globale era riuscito a collegare in modo così chiaro e vincolante le maggiori sfide che il mondo di oggi si trova ad affrontare: sradicare la povertà, proteggere il nostro pianeta dal degrado ambientale, creare le condizioni per una crescita economica equilibrata e sostenibile; mai prima un insieme di obiettivi e sotto-obiettivi ne ha riconosciuto a livello mondiale l'indivisibilità e la necessità di un approccio olistico; mai prima il mondo dei 193 Stati Membri delle Nazioni Unite ha negoziato e si è impegnato in un unico, universale piano di azione di questo tipo. Nel capitolo 5 sono espresse le sfide che sottostanno all'impegno preso di non lasciare nessuno indietro (“ensure that we leave nobody behind” pag.130) e quelle che si presentano già all'orizzonte: migrazioni globali e spostamenti forzati, connessione fra clima, acqua, energia e cibo (Nexus approach), pace e sicurezza, salute, industrializzazione dirompente (biologia sintetica, bio informazione, stampa 3D, intelligenza artificiale). Fortemente innovativa la convergenza con la Terza Conferenza Internazionale sulla Finanza per lo sviluppo, in Addis Abeba e con il Paris Agreement on Climate Change con cui c’è stato uno sforzo di dialogo, coordinamento e ricerca di coerenza. I SDGs hanno infatti dato particolare enfasi agli strumenti finanziari, tecnici, politici e istituzionali e di controllo.
Fasi dei lavori
I primi due capitoli ripercorrono le tappe che hanno portato al 2015: le importanti conferenze internazionali degli anni '902 , lo snodo centrale della Dichiarazione del Millennio, l’avvicinamento a Rio 2012 che da summit sull’ambiente si è trasformato in uno “staging post” per il 2015. Importanti eventi hanno dominato la scena dei primi 10 anni del nuovo secolo: la questione della sicurezza, la grande crisi finanziaria del 2008 che ha gettato in povertà ulteriori 53 milioni di persone, la primavera araba. I miglioramenti innegabili, rilevati con le prime operazioni di monitoraggio dei MDGs3 (2005, 2010 e 2013) hanno evidenziato anche la permanente e strutturale inequità nella distribuzione della ricchezza, lamentando un generale orientamento ai sintomi della povertà più che alle sue cause. Ms. Paula Caballero, direttore degli Affari Economici, Sociali e Ambientali del Ministero degli Esteri Colombiano, rappresentante del suo Paese nella fase preparatoria di Rio +20, ha colto la necessità di lavorare ad una nuova serie di obiettivi adatti alle nuove sfide comuni e ha giocato un ruolo centrale nella genesi dei SDGs. Si è spesa per affermare i due principi completamente innovatori: riconoscere che è impossibile incidere sulle sfide sociali senza incorporarvi fattori e opportunità economiche e ambientali e applicare gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile a tutti i Paesi. Una netta e diretta presa di distanza dai MDG, inizialmente molto ostacolata. Una fine opera di convincimento, portata avanti con incontri ufficiali e informali, ha ottenuto che “When the zero draft appeared in January 2012 something remarkable became clear: the SDG were included in it”. Con Rio+20 è stato avviato un processo intergovernativo comprendente varie iniziative promosse dal Segretario Generale delle Nazioni Unite fra cui due percorsi paralleli per la preparazione del summit del settembre 2015: l’High-Level Panel of Eminent Persons (24 membri principalmente governativi e 3 presidenti che pubblicato un rapporto contenente 12 obiettivi e 54 sotto-obiettivi) e l’Open Working Group che doveva essere composto da 30 rappresentanti governativi nominati dalle 5 aree del globo per lavorare ad una proposta da presentare all’Assemblea Generale.
L’anno 2015 è stato un anno di intenso lavoro (4 giorni al mese) per poter arrivare nel mese di giugno a discutere la prima bozza dell'Agenda. Co-facilitatori di questa fase finale di negoziazioni intergovernative sono stati l'Ambasciatore Macharia Kamau del Kenia e David Donoghue dell'Irlanda, uomini capaci di una precisa regia e di un fine e paziente lavoro di coinvolgimento per il superamento delle divergenze. Il percorso descritto offre importanti segnali in quanto a metodo, chiarezza nelle controversie su temi sensibili, partecipazione, ruolo della leadership e prospettive.
Metodo
La metodologia del lavoro è stata finalizzata al massimo confronto. E' cambiato il processo di interazione fra stati membri e stakeholders: i copresidenti hanno previsto una pratica secondo la quale le delegazioni erano invitate ad incontrare stakeholders e agenzie delle Nazioni Unite ogni mattina per una ora prima delle sessioni ordinarie. Numerose le sessioni informali.
Da sottolineare il fatto che i temi controversi, che sono stati oggetto di confronto anche aspro, si sono riproposti ad ogni livello delle negoziazioni e in modo generale hanno fotografato le visioni, a volte diametralmente opposte, dei Paesi sviluppati (WEOG4) da una parte e di molti Paesi del G77 dall’altra su: parità di genere e questione femminile, integrazione del tema sui cambiamenti climatici nella visione principale, inserimento del punto sulla pace e società inclusive. Nella sessione di giugno sono stati affrontati altri punti cruciali: apparente selettività degli obiettivi citati nel preambolo i WEOG sostenevano la valenza comunicativa dell'elenco puntato nell'esposizione del preambolo, molti dei G77 non ne vedevano il valore aggiunto condiviso supporto all'approccio “5 Ps”: people, planet, prosperity, partnership, peace insoddisfazione dei G 77 che volevano il riferimento al principio CBDR (Common but Differentiated Responsability) parte di ogni obiettivo opposizione costante dei G77 sul rimettere in discussione alcuni dei sotto-obiettivi, come ripetutamente richiesto dai WEOG stand off dei WEOG sulla proposta di riferimento al diritto allo sviluppo, mentre auspicavano il rafforzamento dei riferimenti sui diritti umani (che i Paesi Africani ritenevano già troppo enfatizzati) e sulla parità di genere Israele e altri Paesi WEOG sfidavano il riferimento presente nella bozza a persone sotto occupazione straniera richiesta di menzione degli effetti positivi della migrazione sullo sviluppo richiesta di sottolineatura del ruolo dei Parlamenti nazionali richiesta di chiarimento sul ruolo delle Nazioni Unite nell'attuazione dei SDGs e comune auspicio di un riferimento alla riforma del sistema ONU C’era una generale avversione ad organizzare i 17 obiettivi in gruppi, temendo di riproporre una concezione a comparti, quando il cammino fatto aveva portato al comprenderne l’interconnessione.
In ogni fase di avvicinamento al summit del 2015 c'è stata un'ampia partecipazione, con consultazioni incrociate ad ogni livello:
- consultazioni secondo le tematiche (ciascuna affidata ad una o più delle principali agenzie ONU e a un Governo)
- consultazioni nazionali
- consultazioni Global Compact5 per offrire il contributo dei leaders aziendali sulle priorità per una sostenibilità aziendale
- consultazioni con il mondo della finanza (Comitato intergovernativo di esperti sulla finanza per uno sviluppo sostenibile, creato nel 1992)
- consultazioni con task team delle Nazioni Unite
- alleanze informali raggruppate in 3 aree: Stati membri interessati ad un particolare argomento creano un ‘friends group’ di approfondimento (friends of water, friends of sustainable energy for all, friends of children ….), un gruppo di stakeholder organizza un laboratorio, agenzie o programmi ONU organizzano work-shops e riunioni su un argomento.
Importante il contributo dei 9 gruppi di stakeholders nati nel summit del 19926 e altri stakeholders7.
Emerge da tutto il testo l'importanza di una leadership determinata e aperta ogni contributo. I co-facilitatori si sono guadagnati fiducia e autorevolezza, trovando l'equilibrio fra coinvolgimento e partecipazione a 360 gradi (vedi modalità di lavoro) e praticità operativa, con la capacità di un controllo calmo ma fermo che ha permesso loro di “holding the pen” fino alla fine.
Secondo gli autori, importanti fattori faciliteranno l'attuazione del progetto: il fatto che gli obiettivi sono specifici, chiari, orientati all'azione, misurabili; che sono definiti gli indicatori che guideranno gli Stati a svilupparne di propri per monitorare l’attuazione; che sono chiari i compiti e competenze.
Il documento è proposto come un percorso aperto che coinvolgerà governi, parlamenti, società civile, accademica, comunità di ricerca, ma, soprattutto, persone ordinarie di tutto il mondo il cui contributo è valorizzato in quanto si tratta di una agenda “by, for and with the people” (pag.129).
Conclusioni
La fase di preparazione dell’Agenda 2030 come emerge dal testo in esame è stata un laboratorio di costruzione e composizione. Colpisce la ricorrente sottolineatura di valori che attengono di solito alla sfera dell'etica e della religioni: sono stati considerati importanti ingredienti del successo l’atmosfera collaborativa e la dinamica positiva che ha accompagnato il lavoro dei 400 delegati. I co-facilitatori, nelle fasi più difficili e definite di ‘solitudine’, sapevano che “... the first and most important precondition for success in these negotiations was agreement between themselves” (pag. 97). Colpisce come idee e intuizioni di una parte, passato il vaglio della critica, della negoziazione, della riformulazione siano state sposate e fatte proprie da tutti. I risultati del OWG, per es., al momento di essere presentati all'Assemblea Generale sono stati difesi proprio dai Paesi G 77 e dalla Cina, alcuni membri dei quali, ripetutamente e su alcune tematiche, avevano dissentito. Si parla di 'enfasi' dei G77 “on the sanctity of the OWG outcome” (pag. 72).
Colpisce la valorizzazione dell’intervento di Papa Francesco all’Assemblea Generale e l’importanza attribuita alla sua mediazione per l’inserimento del riferimento alle moderne forme di schiavitù e traffico di esseri umani nell’obiettivo 8.7.
Anche per questi motivi ritengo che il testo si presti al confronto con un aspetto del pensiero sociale cristiano che emerge dalla esortazione "Evangelii gaudium”. Nel documento programmatico del suo pontificato Papa Francesco dedica il capitolo III al “Bene comune e la pace sociale”. Pace che “ha che fare con la distribuzione delle entrate, l’inclusione sociale dei poveri e i diritti umani” aspetti che “non possono essere soffocati con il pretesto di costruire un consenso a tavolino o un’effimera pace per una minoranza felice”. Il n. 221 della E.G. recita: “Per avanzare in questa costruzione di un popolo in pace, giustizia e fraternità, vi sono quattro principi relazionati a tensioni bipolari proprie di ogni realtà sociale. Derivano dai grandi postulati della Dottrina Sociale della Chiesa, i quali costituiscono «il primo e fondamentale parametro di riferimento per l’interpretazione e la valutazione dei fenomeni sociali». Sono criteri guida che si scorgono implicitamente presenti nel modus operandi che emerge dal testo recensito:
1. Il tempo è superiore allo spazio: “ ... Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici” (222)
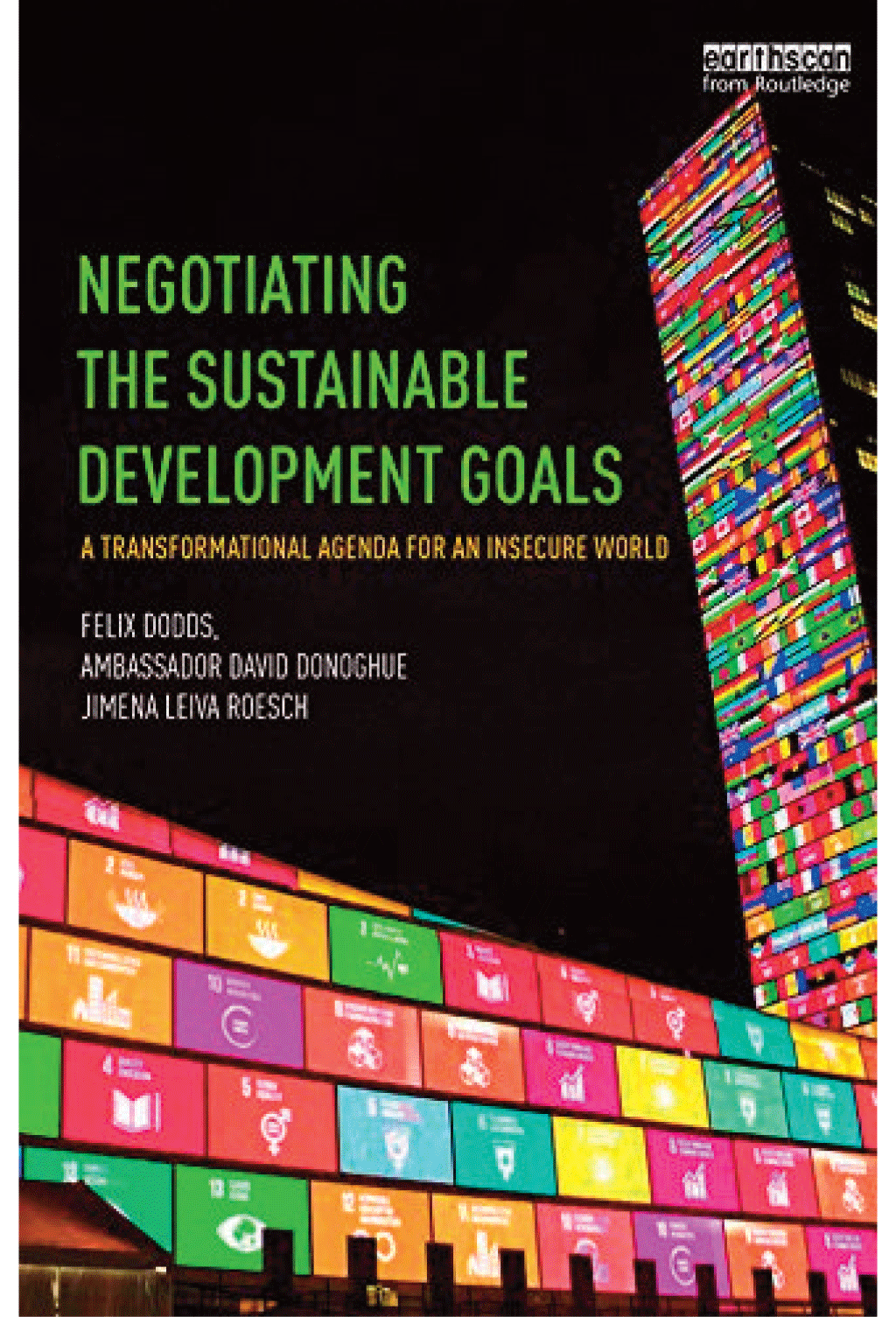
Il procedere dei lavori, fin dalle sue fasi preliminari, è stato caratterizzato dal coinvolgimento, da un modus operandi che prediligeva il processo prima ancora dei risultati. Nonostante le limitazioni di tempo, la stanchezza di sessioni molto lunghe, i co-facilitatori hanno sempre sottolineato che gli stati membri erano liberi di sollevare qualsiasi questione: “There were no taboos area” – “This work should not be rushed” (pagg. 82-83).
Nell'introduzione gli autori si augurano che il testo abbia anche la funzione di ispirare la prossima generazione, i funzionari governativi e stakeholders che saranno impegnati nell'attuazione di questa Agenda e chi comincerà a pensare a come sarà sostituita nel 2030.
2. L’unità prevale sul conflitto: “La solidarietà, intesa nel suo significato più profondo e di sfida, diventa così uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita. Non significa puntare al sincretismo, né all’assorbimento di uno nell’altro, ma alla risoluzione su di un piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto”. (228)
I conflitti anche aspri non sono stati affrontati nell’ottica di un compromesso accomodante, ma con lo sforzo di giungere a una sintesi che contenesse gli opposti. E ciò per una precisa scelta di campo: innestare un processo inclusivo, in cui fossero argomento di dialogo anche il linguaggio da usare, le forme, la struttura del documento. Di fronte a punti nevralgici l’incoraggiamento alle delegazioni era quello “to step beyond their comfort zone in the search for agreement”. Significativo il fatto che “if a target proposed was not universally applicable, it would not be incorporated in the text”.
3. La realtà è più importante dell’idea: “Questo implica di evitare diverse forme di occultamento della realtà: i purismi angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi dichiarazionisti, i progetti più formali che reali, i fondamentalismi antistorici, gli eticismi senza bontà, gli intellettualismi senza saggezza” (231)
La maggioranza era d'accordo sul fatto che la dichiarazione doveva prendere le distanze dal linguaggio e dalla struttura tradizionali usate nei documenti delle Nazioni Unite, per servire come una chiamata che ispirasse all'azione. Le caratteristiche più volte auspicate nel corso dei dibattito sulla natura e la formulazione stessa degli obiettivi andavano in questa direzione: dovevano essere concreti, semplici, trasparenti, “nationally owned, multistakeholders in nature, promoting exchanges of best practices” (pag. 87). Pur con pungenti dibattiti, sono stati adottati come principi strutturali della dichiarazione i molto concreti 4 P (people, planet, prosperity, partnership), con l'aggiunta successiva del 5° Pace, tralasciando concetti più astratti come dignità, giustizia. Nella versione finale del preambolo è stata però aggiunto un riferimento alla dignità della persona umana (“borrowing from a recent papal encyclica” pag. 98)
4. Il tutto è superiore alla parte: “Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschinità quotidiana. Al tempo stesso, non è opportuno perdere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i piedi per terra.” (234)
Maurice Strong, padre spirituale dello sviluppo sostenibile, nel discorso che avrebbe dovuto tenere all'Assemblea Generale nel sett. 2014, riferendosi al documento finale del Gruppo OWG sui SDG, così esprime questo concetto: “Our essential unity as peoples of the Earth must trascend the differences and difficulties which still divide us ...” (pag. 4) e invita a prendere decisioni che uniscano ricchi e poveri, Nord, Sud, Est e Ovest in una nuova partnership globale. L’Open Working Group doveva essere composto da 30 paesi delle 5 regioni geografiche. Dopo 6 mesi di discussione su quali scegliere e non arrivando a nessuna soluzione, emerse un formato nuovo e creativo: il seggio poteva essere condiviso da più di un paese. “And this format made for a truly cross-regional and indeed universal process” (pag. 32), rendendo così presenti 70 Paesi.
 L’impressione che emerge fortemente dal testo è che sia stato avviato un processo che pare irreversibile. “No longer are we talking about development with a donor-recipient mind set” nota nella prefazione Mary Robinson. E si può leggere in quest’ottica l’enfasi condivisa dalle delegazioni circa la necessità di riforma del modus operandi delle Nazioni Unite richiesto soprattutto in una nuova concezione dei rapporti internazionali: “beyond the UN's structural reform, throughout the 2030 Agenda negotations, delegations kept repeating that there was a need to change the mind-set” (pag. 138).
L’impressione che emerge fortemente dal testo è che sia stato avviato un processo che pare irreversibile. “No longer are we talking about development with a donor-recipient mind set” nota nella prefazione Mary Robinson. E si può leggere in quest’ottica l’enfasi condivisa dalle delegazioni circa la necessità di riforma del modus operandi delle Nazioni Unite richiesto soprattutto in una nuova concezione dei rapporti internazionali: “beyond the UN's structural reform, throughout the 2030 Agenda negotations, delegations kept repeating that there was a need to change the mind-set” (pag. 138).
Bibliografia
Felix Dodds, Ambassador David Donoghue and Jimena Leiva Roesch, 2017. “Negotiating the Sustainable Development Goals. A transformational agenda for an insecure world”. Londra, U.K: Routledge
Papa Francesco. 2013. Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
NOTE
1 Garzanti linguistica
2 Wolrd Summit for Children – 1990; United Nations Conference on Enviroment and Development e Rio Earth Summit – 1992; International Conference on Population and Development – 1994; Fourth World Conference on Women – 1995; Second United Nations Conference on Human Settlements – 1996; World Food Summit – 1996;
3 Millennium Development Goals
4 Western European and Other Groups, uno dei 5 gruppi regionali non ufficiali delle N.U
5 Iniziativa volontaria lanciata nel 1999 da Kofi Annan -allora Segretario delle Nazioni Unite- in occasione del World Economic Forum (Davos, 1999), con l’obiettivo di promuovere a scala globale la cultura della responsabilità sociale d’impresa.
6 Commercio e Industria, Bambini e giovani, Agricoltori, Popoli indigeni, Autorità locali, ONG, Comunità scientifica e tecnica, Donne, Operati e sindacati
7 Entità educative e accademiche, Persone con disabilità, Gruppi di volontari, Persone anziane, Reti globali.
 IT
IT  EN
EN 
















