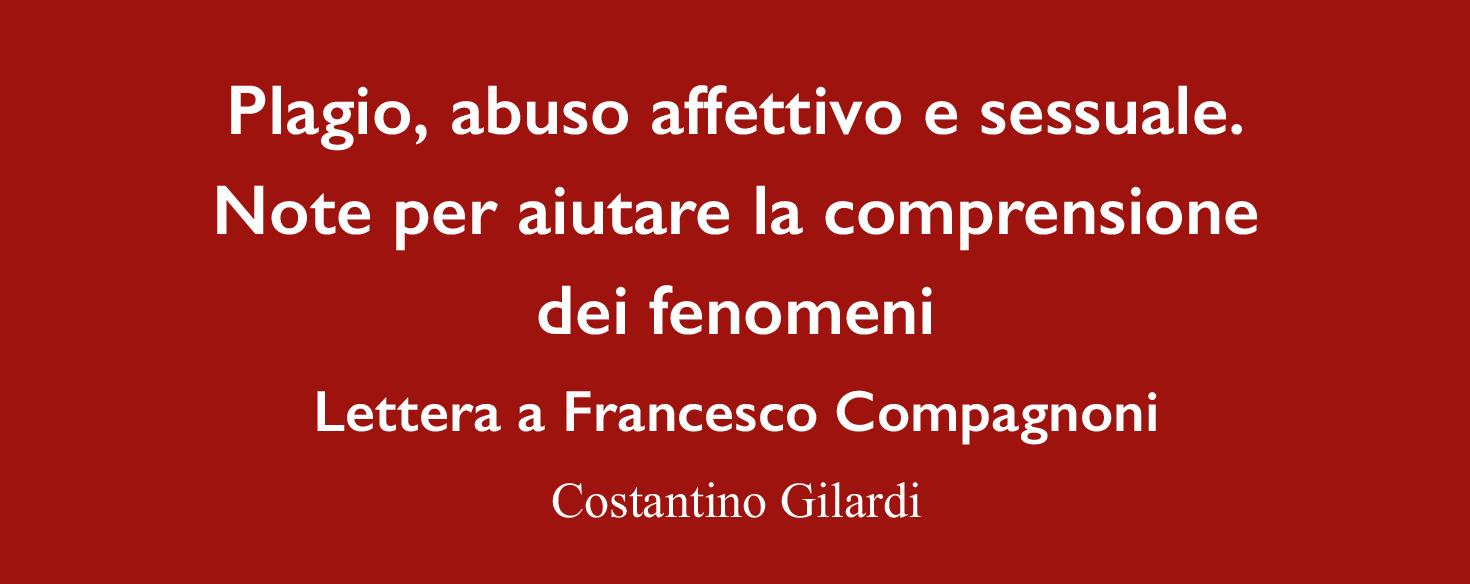
 aro Francesco, mi scuso per il ritardo con cui rispondo alla tua richiesta di un parere sull’articolo che mi hai inviato.
aro Francesco, mi scuso per il ritardo con cui rispondo alla tua richiesta di un parere sull’articolo che mi hai inviato.
Ho tardato pensando di poter ricuperare qualche opera di riferimento che ho in studio, ma il lockdown si sta prolungando.
Ti rispondo [24 maggio 2020] quindi con pochi riferimenti bibliografici, che cito a memoria. Se lo riterrai opportuno e utile, potrò completare in seguito il testo che ti invio con i riferimenti bibliografici e qualche citazione.
Cerco di enucleare alcuni punti attorno alle due questioni principali che l’articolo solleva: il plagio e l’abuso sessuale in senso ampio, comprensivo cioè di abuso affettivo, con sconfinamento teorico e pratico dell’uno nell’altro.
Alcuni punti (perversione, limite e duale) vorrebbero inserire i fatti in questione nell’articolo inviatomi nel contesto della mutazione antropologica in corso; gli altri punti vogliono situare alcuni nodi che ritengo imprescindibili.
Dopo il 3 giugno ho potuto consultare i libri conservati nel mio studio ed ho provveduto a più precisi riferimenti bibliografici e a qualche citazione.
1. Perversione
 I fatti riportati dagli articoli che mi hai inviato, principalmente e innanzitutto, da un punto di vista psichico, sono da situare nell’ambito della categoria clinica della perversione.
I fatti riportati dagli articoli che mi hai inviato, principalmente e innanzitutto, da un punto di vista psichico, sono da situare nell’ambito della categoria clinica della perversione.
La clinica psichiatrica ottocentesca, soprattutto tedesca, da cui lo stesso Freud mutua la “struttura” perversione, metteva l’accento sul fatto che il “perverso” spostava l’oggetto sessuale su oggetti diversi da quello “naturale”.
E qui si aprono più questioni ben note.
L’autore, non il primo, che classicamente ha sistematizzato questa materia è Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), con la sua Psycopathia sexualis, del 1886, più volte ristampata.
Il riferimento obbligatorio odierno è il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), arrivato alla sua quinta edizione.
Non amo questo manuale, nato in origine per le assicurazioni americane, poi evoluto, che ha l’innegabile vantaggio di usare una terminologia globalmente comprensibile e di permettere di fare una diagnosi comprensibile a New York piuttosto che a Pechino o a Dakar, ma troppo oggettivante e “medicalizzante”.
Per un approccio globale e sintetico della perversione in senso clinico / psicoanalitico, non esito a suggerire l’opera1 di Recalcati sulla clinica psicoanalitica, al capitolo Perversione.
La questione è di peso e di attualità.
L’associazione psicoanalitica cui appartengo2 ha dedicato numerosi convegni e pubblicazioni al tema della perversione, fino a farne la cifra interpretativa della cultura contemporanea, del funzionamento psichico e del funzionamento sociale oggi prevalenti.
Per dirlo in breve (da integrare e articolare): ai tempi di Freud il principale funzionamento psichico che produceva disagio erano le nevrosi, cui Freud (senza trascurare le perversioni e le psicosi) ha principalmente dedicato la sua attenzione teorica e clinica.
Nelle due forme fondamentali di nevrosi, l’isteria e la nevrosi ossessiva, è mantenuto il rapporto soggetto / oggetto con al centro la questione del desiderio3.
Nella nevrosi isterica il funzionamento psichico che la caratterizza potrebbe così essere ridotto all’osso: desidero (desiderio) avere un desiderio insoddisfatto (oggetto del desiderio).
Il tratto prevalente del funzionamento psichico isterico è l’insoddisfazione.
L’isterico / isterica va all’oggetto reale e lo butta via credendo fermamente (Lacan diceva: dur comme fer) che l’oggetto capace di soddisfarlo / soddisfarla pienamente, totalmente, interamente esista, anche se non lo ha ancora trovato.
Al cuore vi è la questione della mancanza e dei diversi modi di declinare il rapporto soggettivo alla mancanza.
Nella nevrosi ossessiva il soggetto rimane in una posizione prevalentemente immaginaria, dove tutto è possibile e dove tutto è impossibile.
Il tratto prevalente del funzionamento psichico ossessivo è l’impossibilità.
I tratti clinici più frequenti sono il dubbio, l’indecisione, il controllo di sé, dell’altro, delle situazioni, l’impossibile, lo scrupolo.
In passato, le declinazioni più frequenti di questo funzionamento erano legate alla colpa e ai microbi.
Nell’ambito dell’associazione cui appartengo, e non solo, si tende a dire che oggi, nel nostro sociale, il funzionamento psichico prevalente è la perversione e non più la nevrosi.
Il tratto prevalente di questo funzionamento può essere anche qui ridotto all’osso così: tutto e subito.
Vengono meno l’assenza dell’oggetto e il desiderio e si ha accesso, o si cerca di avere accesso, immediato all’oggetto, che viene subito buttato via e sostituito da un altro oggetto. Tratti rilevanti di questo funzionamento sono la soppressione del tempo dell’attesa e del desiderio.
Mi rendo conto che tutto questo può sembrare un po’ rapido e sollevare più punti interrogativi.
Per una trattazione meno rapida suggerirei due testi, uno del mio maestro Charles Melman, intitolato L’homme sans gravité, tradotto in italiano4 con una mia postfazione e l’altro testo molto ampio e articolato di un caro amico, psichiatra psicoanalista, Jean-Pierre Lebrun, La perversion ordinaire5, non tradotto in italiano.
Lebrun intende con l’aggettivo ordinaria quella perversione che individua come il funzionamento psichico dominante nella società contemporanea, non nel senso clinico classico, cui sono invece riferibili i comportamenti dei fondatori o dei direttori spirituali riportati dall’articolo che mi hai inviato: Abus dans l’Église : Le “maître spirituel” connaît les failles d’une âme6.
Ai casi citati dall’articolo sono da aggiungere almeno Maciel, fondatore dei Legionari, credo anche il fondatore di un nuovo istituto di Francescani e più casi minori, tra cui un seminario parallelo recentemente chiuso in una città del Nord Italia in seguito ad una visita apostolica richiesta dal nuovo vescovo ed un caso simile a Prato.
2. Limite
In un modo inedito rispetto al passato, strettamente legata alla questione della perversione è la questione del limite.
Jean-Pierre Lebrun, dopo aver scritto alcuni articoli che riprendevano il tema della nuova economia psichica e dei neo-soggetti proposto da Melman7, ha dedicato un intero volume alla questione del limite, intitolato Un monde sans limite8.
La perversione ordinaria è lo sbocco cui è giunto Lebrun partendo dal declino del nome del padre e dal declino del limite, sia nel funzionamento soggettivo sia nel funzionamento sociale contemporanei.
Nel 2002 si è costituito a Parigi un gruppo di lavoro su Soggettività e legame sociale per mettere a tema soprattutto la clinica delle cosiddette nuove patologie e il legame sociale. Hanno fatto parte di questo gruppo Charles Melman, Marcel Gauchet, Jean-Pierre Lebrun e alcuni altri.
Alcuni psicoanalisti, uno storico come Gauchet9 ed altri, hanno affrontato di petto la questione del limite (anche con preoccupazione): che cosa può venire a fare limite nel funzionamento sociale contemporaneo?
Questa domanda risuona ora per me in modo inedito in tempo di coronavirus, in cui siamo confrontati ad un inatteso e imprevisto limite!
Riguardo all’articolo inviatomi, credo di poter dire che nei casi presi in considerazione, senza subito andare alla questione morale, c’è innanzitutto una questione che riguarda il limite.
Quale sottile lama di rasoio separa il possibile dall’impossibile?
Quale sottile lama di rasoio separa la comprensione dalla complicità?
Quale sottile lama di rasoio separa l’intimità dall’erotismo agito?
Nella situazione di direttore spirituale o di fondatore la questione del limite si pone ineludibilmente e viene sfiorata o apertamente incontrata, con rischio di slittamento, a diversi titoli.
La persona diretta è in situazione di transfert positivo nei confronti del direttore spirituale.
La fiducia e l’apertura di coscienza impongono un necessario limite che da una parte può superare i limiti “abituali”, ma dall’altra non può essere “senza limiti”.
Uguale situazione per i “fondatori”: e non è solo questione di regole o regolette (il padre Thomas Philippe teorizzava che tra il direttore spirituale e la “diretta” tutto era possibile, ad eccezione della penetrazione).
Ed allora la domanda irrinunciabile da porre diventa: che cosa è incestuoso e che cosa non lo è.
Lévi-Strauss10 in Strutture elementari della parentela, entrando nel vivo (allora!) del dibattito natura-cultura, reperiva nella proibizione dell’incesto l’elemento comune alle molte centinaia di strutture di parentela che aveva preso in considerazione e come il punto minimale del funzionamento sociale, in cui natura e cultura sono inseparabili.
Per incesto, tema ripetutamente affrontato da Freud e dai suoi allievi, credo si debba intendere un tipo di rapporto in cui la confusione dei posti (di padre, di figlia, di educatore, di educato, di direttore, di diretto, di fondatore, di fondato) produce dei danni psichici che compromettono l’identità e il funzionamento psichico stesso del soggetto più giovane, o più debole.
Che una relazione diventi o non diventi incestuosa dipende dall’età, dalla struttura psichica, dalla società cui appartengono i due soggetti e da altri fattori di natura psichica ed etica.
3. Foro interno / foro esterno
Mi sono occupato a più riprese di questo tema da un punto di vista psicologico, soprattutto riguardo alla prima fase degli scritti di padre Luigi Rulla SJ e con particolare riferimento al fatto che gli psicoterapeuti e le psicoterapeute formati da Rulla facevano firmare una liberatoria al termine della psicoterapia per poter riferire i contenuti appresi durante la psicoterapia ai superiori del seminarista, del religioso o della religiosa che avevano seguito nel trattamento.
In alcuni dei primi scritti di Rulla vi erano in particolare due affermazioni molto problematiche rispetto a questo punto:
- la psicologia è propositiva e giudicativa, che tradotto in prassi significava che lo psicologo poteva valutare se il soggetto aveva o non aveva la vocazione.
- ed in secondo luogo il cortocircuito tra foro interno e foro esterno.
Far saltare il limite o confine tra foro esterno e foro interno è operazione che conduce ad una deriva totalitaria.
L’Istituto di Psicologia della Gregoriana ha riaggiustato il tiro, dovendo anche tener conto dell’articolo riguardante il segreto professionale previsto dalla legge che ha istituito l’Ordine degli Psicologi nel 1989.
Anche qui la domanda: nella psicoterapia, e analogamente nella direzione spirituale e nella confessione sacramentale, si deve fermamente mantenere la distinzione tra foro interno e foro esterno o si possono fare delle eccezioni?
La manifestazione di coscienza è una delle istituzioni più antiche della vita religiosa. Con accentuazioni diverse ne parlano Antonio, Evagrio, Basilio e Cassiano. Nel tempo, la manifestazione di coscienza si è distinta dall’accusa fatta nel sacramento della Confessione. Ignazio di Loyola e i primi legislatori gesuiti hanno considerato la manifestazione di coscienza come una delle istituzioni sostanziali della Compagnia. Alcune società religiose maschili o femminili si sono ispirate alle direttive di sant’Ignazio e hanno introdotto la manifestazione di coscienza nelle loro legislazioni. A partire dal 1854 la Congregazione dei Vescovi e Regolari emana direttive restrittive riguardo alla manifestazione di coscienza, che sfociano nel decreto del 17 dicembre 1890 che promulga una legge stretta e generale imposta a tutti gli istituti femminili e maschili11. Questo decreto è la fonte principale del canone 530 del Codice di Diritto Canonico del 1917 e del canone 630 del Codice del 1983. Il canone 630 § 5 esplicitamente dichiara:
I religiosi si rivolgano con fiducia ai superiori, ai quali possono palesare l’animo proprio con spontanea libertà. È però vietato ai superiori indurli in qualunque modo a manifestare loro la propria coscienza.
4. Stato d’eccezione
Esistono situazioni istituzionali, laiche o religiose, in cui vi sarebbe almeno una persona che non sia sottoposta alla legge cui gli altri sono sottoposti?
Esistono stati di eccezione12 e con quali conseguenze e con quali rischi?
Si potrebbero ricordare più esempi antichi e recenti; ne cito uno solo nell’ambito della complessa vicenda dei fondatori dei Cappuccini. Il capitolo del 1538 elesse come vicario generale fra Bernardino Ochino da Siena. Questo insigne predicatore si era attirata l’ammirazione unanime di tutti i religiosi e dei devoti dell’ordine, specie di Vittoria Colonna e del suo circolo di umanisti, per il suo amore all’osservanza della regola, per la sua austerità, il suo fervore senza affettazione e le sue doti di governo. Disimpegnò con soddisfazione di tutti il primo triennio di governo e fu rieletto nel capitolo generale del 1542. Dopo l’elezione mutò totalmente il suo modo di vivere, si rilassò nella regolare osservanza, si dispensò dalla vita comune e ottenne privilegi personali in considerazione delle sue attività apostoliche. Il 22 agosto 1542, da Firenze, scrive una drammatica lettera a Vittoria Colonna in cui ufficializza la sua decisione di intraprendere la strada dell’esilio. Depone l’abito francescano in casa della duchessa Cybo e da Mantova, passando per Zurigo, si dirige verso Ginevra, per ricominciare una nuova vita all’età di 55 anni13.
Un fondatore o un personaggio di autorità, morale o istituzionale, è certamente più esposto di altri a considerarsi l’almeno uno non sottomesso alla legge comune.
Da un punto di vista psicologico, individuale e gruppale, questo è un comportamento di tipo perverso.
Questo tipo di “eccezione”, con declinazioni leggere o molto marcate, può verificarsi in istituzioni civili ed anche religiose.
Senza generalizzazioni scorrette, un esempio che tutti conosciamo è quello di alcuni poliziotti che sgommano, passano col rosso, viaggiano a velocità proibite anche quando non vi è un motivo di ordine pubblico che possa giustificare l’eccezione.
Si aprirebbe qui la lunga lista di collegi, seminari, carceri, carceri minorili …
Lo stato d’eccezione può non avere o avere risvolti “sessuali” in senso ampio, sia nella versione “punizione” che nella versione “privilegio”, da situare nell’ambito di quanto detto sopra sull’incesto.
È da prendere in considerazione se il comportamento sia teorizzato o non teorizzato e quale teoria sia addotta per giustificarlo.
5. Abuso del transfert
In riferimento ad alcuni nodi sollevati dall’articolo che mi hai inviato, ritengo molto utile la analogia tra il transfert nell’ambito della psicoterapia e il transfert nell’ambito del rapporto direttore spirituale-diretto o fondatore-fondato.
Esiste una ampia letteratura riguardante l’abuso del transfert nell’ambito della psicoterapia; faccio qui riferimento soltanto a Gabbard14:
La maggior parte degli analisti e degli psicoterapeuti che hanno avuto relazioni sessuali con i loro pazienti ricadono in una di queste quattro categorie: 1) disturbi psicotici; 2) psicopatia predatoria e parafilie; 3) mal d’amore; 4) resa masochistica15.
Psicopatia predatoria e parafilie
All’interno della categoria della psicopatia predatoria, includiamo non solo i veri e propri disturbi antisociali di personalità, ma anche gravi disturbi narcisistici di personalità con evidenti caratteristiche antisociali. In altre parole è il comportamento sessuale a essere predatorio e psicopatico. Benché non tutti i clinici che soffrono di parafilie o di perversioni siano necessariamente predatori psicopatici, coloro che agiscono i loro impulsi perversi con i pazienti hanno solitamente una grave patologia del carattere sul continuum narcisistico-antisociale. Questi terapeuti sono di solito uomini e hanno manifestato comportamenti sessuali predatori durante tutta la loro vita […].
Altra variante del predatore è l’analista profondamente narcisista che ha raggiunto l’apice della carriera; egli può occupare una posizione di notevole responsabilità all’interno di organizzazioni locali, nazionali o internazionali. Può essere famoso a livello internazionale per i suoi scritti e riverito come maestro. L’adulazione che riceve lo intossica al punto che comincia a credere di essere diverso, superiore agli altri […]. Quando vengono alla luce le trasgressioni sessuali di questi clinici, molti colleghi ricordano altri episodi che avrebbero dovuto mettere in allarme, ma che furono ignorati. I colleghi avevano spesso colluso con l’onnipotenza dell’analista, ammirandone la flessibilità “non ortodossa” dimostrata quando si vantava di utilizzare in modo creativo azioni o interventi che esulavano dalla tecnica analitica classica […]16.
Mal d’amore
La maggioranza degli analisti che hanno delle relazioni sessuali con i loro pazienti mostra caratteristiche del mal d’amore, di resa masochistica o di entrambi. L’analista malato d’amore presenta solitamente alcune caratteristiche tipiche, tra cui una notevole vulnerabilità narcisistica. Quando l’analista in questione è un uomo, la situazione classica è quella in cui un professionista di mezza età si innamora perdutamente di una paziente molto più giovane. L’infatuazione si verifica in genere durante un periodo molto difficile della vita dell’analista […]. Questa vulnerabilità narcisistica a volte è mascherata da un funzionamento e da un sostegno sociale sufficientemente buono fino al momento in cui nella vita dell’analista non scoppia una grave crisi […]. I temi narcisistici di questi analisti malati d’amore comprendono generalmente un immenso bisogno di conferma da parte dei pazienti per regolare la propria autostima […]17.
6. Duale
Nell’ambito del nostro funzionamento sociale si è affermato negli ultimi decenni un funzionamento sempre più duale, intendendo con questo un funzionamento faccia a faccia, speculare, con un prevalere della legge del più forte, sia a livello di individui che di comunità, che di nazioni (si pensi a quanta poca forza hanno le risoluzioni dell’ONU e si pensi alle numerose situazioni di ingerenza di potenze o superpotenze in alcuni scenari geopolitici).
Anche qui, per dirla in modo troppo semplice, se Giovanni impone la sua legge a Maria e Maria impone la sua legge a Giovanni, il rapporto sarà sempre cannibalico: o io mangio te o tu mangi me.
Soltanto il riferimento ad un terzo permetterà a Giovanni e a Maria di essere entrambi sottomessi ad un terzo, appunto, che li trascende e può permettere loro di non “distruggersi”.
La minima delle constatazioni riguardanti l’uso dei termini terzo e terzietà induce ad operare qualche distinzione e minimalmente – riprendendo le pertinenti osservazioni a questo proposito di Charles Melman e di Jean-Pierre Lebrun – la distinzione tra terzo sociale o incarnato e terzo simbolico […].
Il riferimento ad una norma riconosciuta, ad un padre comune, ad ideali condivisi, ad una trasmissione è profondamente incrinato e perduto o in mutazione, secondo i differenti punti di vista. Per alcuni tutto ciò è fortunatamente perduto, per altri purtroppo.
È un fatto riconosciuto ed un criterio di analisi sociale ampiamente recepito che ci troviamo in una società pluralista in cui i riferimenti sono molteplici e da situare in funzione di soggetti che appunto fanno riferimento a differenze culturali, religiose, sociali. Il confronto con minoranze diversificate rende non più possibile il riferimento ad un terzo unico e centralizzatore.
Un altro aspetto di rilievo è l’impossibilità di costruire norme che potremmo chiamare, per comodità, oggettive ma ciò che sembra essere in gioco è piuttosto la possibilità di costruire norme con i soggetti stessi delle diverse situazioni e tenendo conto delle differenze/diversità che caratterizzano le odierne modalità di convivenza, almeno per il mondo occidentale.
La diffidenza verso un terzo (o grande Terzo) regolatore che funzionerebbe con un riferimento oggettivo spinto fino all’esasperazione è certamente legata après-coup, tra l’altro, alle riletture che un mutato punto di vista ci porta a fare di massacri, occupazioni, distruzioni, deportazioni o quant’altro potrebbe essere riferito a queste modalità di “autorità” o di “terzietà”18.
Il nazismo e la Shoah, in particolare, hanno confrontato il XX secolo ad un ulteriore dubbio sul funzionamento di un terzo che possa essere considerato autorevole e su un funzionamento gerarchico con dei margini quasi inesistenti di non sottomissione, con effetti devastanti ed estremi.
Il riferimento terzo, e il rispetto dell’autorità che esso ha sempre comportato, è stato ampiamente percepito come incapace di impedire il peggio che invece si è realizzato19.
Sul versante in qualche modo opposto, che tenta di evitare questo tipo di impasse, giustamente invocando un riferimento plurale sorge la difficoltà riguardo ad un possibile legame sociale in un contesto di riferimenti pluralisti o troppo pluralisti.
La psicoanalisi ha per certi versi corroborato il funzionamento di un’istanza terza nello psichico e nel sociale, ma ha anche introdotto delle articolazioni che permettono di poter formulare la domanda riguardo a chi o a che cosa, di volta in volta, viene ad occupare questo posto.
Allora quale terzo possibile e in che cosa questo “nuovo” terzo si distinguerebbe dal funzionamento precedente?
La risposta più immediata e, parrebbe, prevalente va nel senso di affermare che non è più necessario un terzo incarnato.
Jean-Pierre Lebrun propone di distinguere patto e contratto situando il terzo sul versante del patto in quanto funzionamento che introduce una dimensione di esteriorità nei confronti dei soggetti.
Sarebbe questo tipo di dimensione che dovrebbe essere salvaguardato nella mutazione in corso, e questo non per partito preso o per devozione, ma per interrogare il clivage fondamentale tra il mantenimento o l’abolizione di qualunque terzietà20.
Due distinzioni si impongono: fra chi occupava il luogo terzo e quindi le diverse declinazioni storiche di figure terze (re, stato, legge, …) e il luogo occupato ed in secondo luogo se questo luogo d’eccezione è un luogo sottomesso alla legge o è un luogo fuori-legge.
Le monarchie assolute europee, in forme diverse non sono mai state, a livello di diritto, dispotiche in modo assoluto: esistevano forme di temperamento del funzionamento assoluto (forme di controllo, senati, camere) e soprattutto al di sopra del re vi era la legge divina alla quale anche il re era sottomesso.
L’avvento della democrazia ha fatto saltare questo funzionamento opponendo oggettivo e soggettivo, collettivo e individuale, eteronomia e autonomia, con una mutazione di ordine simbolico.
La modernità, con un lento lavoro durato due secoli, ha sloggiato il grande Terzo prima trascendente e poi trascendentale dal luogo che occupava.
L’immaginario sociale contemporaneo è la forma più o meno compiuta di questo lavoro della modernità.
La democrazia ha vinto molte battaglie contro l’eteronomia che ha sempre rifiutato ed ha voluto emanciparsi da ogni forma di trascendenza, ma questo processo sta prendendo volti sociali inattesi nel funzionamento sociale.
Gli individui, sembrerebbe, sono emancipati dall’ordine religioso, dalle tradizioni, da forme collettive di riferimento come la famiglia o la nazione, dalla riverenza gerarchica, da legami di obbedienza a varie forme di autorità, ma siamo confrontati ad una inedita impossibilità di un riferimento comune ed a forme di “perversione generalizzata”21.
Godiamo di una inedita libertà di potere su noi stessi, ma ognuno per conto suo, ognuno per i fatti propri.
La conseguenza maggiore di questo funzionamento sembra essere lo svilupparsi di un immaginario sociale in cui non c’è più posto per un consenso ad una perdita di godimento individuale a favore di un funzionamento collettivo, non solo nelle declinazioni trascendenti e trascendentali che abbiamo ricordato, ma anche nella declinazione proposta da Freud.
Nel nuovo che si afferma, ovviamente si possono incontrare formazioni “patologiche” che inevitabilmente accompagnano ogni trasformazione storica, ma anche promesse e invenzioni.
È il cambiamento di regime simbolico ciò che sovverte i nostri abituali riferimenti:
- figli di Dio nel funzionamento politico-religioso dell’Ancien Régime,
- figli della scienza nel funzionamento della modernità che ha dichiarato il cielo vuoto senza cancellare il luogo dell’Altro.
Ma quale filiazione nella nostra contemporaneità o se si preferisce nella postmodernità?
Chi opta per il mantenimento di una terzietà, ritenendola un fatto di struttura, irrinunciabile nel funzionamento sociale e individuale, funzionamenti che come ricorda Freud in Psicologia delle masse non possono essere separati essendo: “La psicologia individuale anche fin dall’inizio psicologia sociale”22, può optare per un terzo non più trascendente o trascendentale.
È l’accettazione di una dissimetria iniziale che permette al soggetto di accedere alla alterità.
La dissimetria dei posti bambino e adulto – almeno finora ed a meno di altre possibili economie – è ciò che finora ha funzionato come trasmissione di un posto che fa eccezione e che è determinante per il funzionamento psichico.
Questo rinvia all’economia che organizza gli scambi tra bambino e genitori che d’ufficio organizzano la scena di questo apprendimento.
Non a caso uno dei luoghi più sensibili in cui possiamo incontrare delle difficoltà per un riferimento terzo è proprio l’ambito della educazione23.
L’uso della parola implica di poter sostituire alla cosa un vocabolo che non ha alcun legame con quella cosa.
Il linguaggio strutturalmente introduce una dimensione terza ma non riconducibile ad un nuovo grande Terzo o ad una nuova trascendenza, sia pure laica.
L’iscrizione nella parola comporta che il desiderio si organizzi a partire dall’assenza dell’oggetto e questa assenza è correlata al linguaggio24 che costringe ad una perdita di godimento, marchiando ogni oggetto con una delusione di cui non è possibile fare l’economia e con una insoddisfazione non riducibile.
La questione del terzo, in riferimento alla parola, ci confronta alla questione della trasmissione: “in quale modo questa attitudine alla parola, e cioè l’attitudine degli umani a sostenersi in riferimento ad un vuoto25, si è da sempre trasmessa di generazione in generazione?”26.
Nel processo di soggettivazione il bambino è confrontato ad un posto che fa eccezione, ieri trascendente, oggi logico.
L’attuale immaginario sociale tende a preferire statuti di eguaglianza, la permutabilità dei posti e proprio per questo un posto che faccia eccezione è tendenzialmente letto come un vestigio, una traccia dell’abuso di potere del padre in regime di patriarcato, mentre invece una qualche terzietà è un minimo da preservare perché qualcosa di individuale, e quindi di soggettivo, possa esistere, come anche di collettivo, evitando la deriva verso il funzionamento massa ben segnalato da Freud.
È attraverso la stessa operazione di sottrazione di godimento che si produce sia la singolarità che il luogo del collettivo; è l’iscrizione e il riconoscimento di una perdita che organizzano sia la struttura individuale che la struttura collettiva.
In passato il luogo di questa perdita era abitato da un grande Terzo e la nevrosi che ne conseguiva prendeva la forma di un rimprovero a lui rivolto d’avere occupato questo posto o troppo o non abbastanza.
Oggi siamo piuttosto confrontati alla “perdita nuda” e le forme per affrontarla prendono più volentieri le vie del diniego27 piuttosto che della rimozione28.
Sembra essere questo il nodo che permette di situare una cosiddetta “nuova” clinica ed anche nuove modalità di transfert29.
Quali modalità dovrà adottare la direzione della cura confrontata alla perversione che alcuni chiamano “ordinaria” per distinguerla da una perversione strutturale?
La perdita, diversamente significata in passato, prende nel funzionamento sociale di oggi vie diverse: quella dell’assenza di norme valide per tutti, quella del venir meno delle più comuni certezze, quella della pluralità di reti e di mondi differenti.
Il terzo sociale ed il terzo individuale sono entrambi, come già segnalato da Freud nel Disagio della civiltà, confrontati ad una perdita di godimento nell’irriducibile lavoro di soggettivazione per far addivenire sia il soggettivo che il collettivo30.
Alcune osservazioni conclusive
a) Il “direttore spirituale” e il “fondatore” sono due posizioni a rischio maggiore sia sul versante plagio sia sul versante abuso per il particolare tipo di transfert che si stabilisce tra il direttore e il diretto e tra il fondatore e il discepolo.
b) Una situazione transferale analoga si produce tra lo psicoterapeuta e il “paziente”.
Esiste su questo tema una vasta letteratura.
Freud la affronta precocemente in due piccole opere31, di “consigli” ai “medici” che esercitano la psicoanalisi: la “regola”, secondo Freud, riguardante questo punto è quella della astinenza32.
Qualora il setting di una cura psicoterapeutica o psicoanalitica non possa essere mantenuto in situazione di “astinenza” ed il rapporto si trasformi in una forma di relazione diversa, la cura deve essere interrotta.
c) Un altro nodo sarebbe imprescindibile e riguarda la dimensione gruppale. Che cosa fa sì che un gruppo33 tolleri o subisca, temporaneamente o lungamente, una posizione o delle posizioni abusanti?
d) Tendo a pensare che in diversificate situazioni che per comodità metto sotto il cappello “relazioni di aiuto” si possano produrre situazioni in cui:
- la comprensione rischia di scivolare o scivola verso la complicità
- l’intimità rischia di scivolare o scivola verso l’erotismo agito.
Ritengo che il punto cruciale perché la relazione possa restare “d’aiuto” e, cosa ancora più rilevante, non produca danni, sia la possibilità e la fattibilità di un rientro della relazione nell’ambito strutturale che la caratterizza; in caso contrario, la relazione “d’aiuto” deve essere interrotta, poiché diviene una relazione di tipo totalitario.
Costantino Gilardi
Torino, 24 maggio 2020
NOTE
1 M. Recalcati, Jacques Lacan. La clinica psicoanalitica: struttura e soggetto, Raffaello Cortina Editore, 2016, pp. 395-451.
2 Association Lacanienne Internationale.
3 M. Recalcati, Jacques Lacan. Desiderio, godimento e soggettivazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2012; Id., La forza del desiderio, Qiqajon, Bose 2014; Id., Ritratti del desiderio, Raffaello Cortina, Milano 2018.
4 Ch. Melman, L’uomo senza gravità, Bruno Mondadori, Milano 2010.
5 J.-P. Lebrun, La perversion ordinaire, Denoel, Paris, 2007.
7 Ch. Melman, La nouvelle économie psychique. La façon de penser et de jouir aujourd’hui, Érès, Toulouse 2009.
8 J.-P. Lebrun, Un monde sans limite. Essai pour une clinique psychanalitique du social, Érès, Toulouse 1997, riedito nel 2009.
9 M. Gauchet, Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica, Vita e Pensiero, Milano 2011.
10 C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté (1949), trad. it. Feltrinelli.
11 Per una sintetica e lucida trattazione si veda M. Desdouits, Manifestazione di coscienza, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, V, 1973, coll. 880-887.
12 G. Agamben, Lo stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003.
13 M. Gotor, Ochino Bernardino, in Dizionario Biografico degli Italiani, 79 (2013).
14 G. O. Gabbard, Violazioni del setting, seconda edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2017. Ringrazio Nicolò Terminio per la segnalazione.
15 Ibid., p. 44.
16 Ibid., pp. 44-45.
17 Ibid., p. 47.
18 J.-P. Lebrun, Un monde sans limite. Essai pour une clinique psychanalitique du social, Erès, Toulouse 1997, pp. 83-84; 97-105.
19 C. Gilardi, Verso quale terziarietà (terzietà), in Coppie, a cura di M. Drazien, Carocci, Roma 2007, pp. 29-30.
20 R. Chemama, Clivage et modernité, Erès, Toulouse 2003.
21 Ch. Melman, L’Homme sans gravité. Jouir à tout prix, Denoël 2003, pp. 63-74.
22 OSF, Psicologia delle masse e analisi dell’io, IX, p. 261.
23 J.-P. Lebrun, Incidence de la mutation du lien social sur l’éducation, in “Le débat”, 132 (2004) pp. 151-176. L’intero numero della rivista è dedicato a “L’enfant-problème”.
24 Melman, L’Homme sans gravité, pp. 108-123.
25 C. Lefort, Démocratie et avènement d’un lieu vide, in “Psychanalistes”, 2, 1982, p. 17.
26 J.-P. Lebrun, La distinction des tiers, in J.-P. Lebrun-E. Volckrick, Avons-nous encore besoin d’un tiers, p. 122.
27 Diniego come operazione psichica propria della perversione: H. Rey-Flaud, Le démenti pervers, Aubier, Paris 2002.
28 Rimozione come operazione psichica propria della nevrosi.
29 Chemama, Dépression, pp. 114-120; Melman, L’Homme sans gravité, pp. 123-131, 220-227.
30 C. Gilardi, Verso quale terziarietà (terzietà), in Coppie, a cura di M. Drazien, Carocci, Roma 2007, pp. 29-35. Modificherei e aggiungerei oggi alcune cose rispetto a quelle scritte in questo contributo, che ha però il merito di aver posto la questione.
31 S. Freud, Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico (1912), in S. Freud, Opere, Boringhieri, vol. VI, pp. 532-541; Ibid., Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi (1913-1914), vol. VII, pp. 333-374, ed in particolare il terzo saggio, Osservazioni sull’amore di traslazione, pp. 362-374; Vie della terapia psicoanalitica, 1918, in S. Freud, Opere, Boringhieri, vol IX, pp. 19-28.
32 “Ho già lasciato intendere che la tecnica analitica fa obbligo al medico di rifiutare alla paziente bisognosa d’amore il soddisfacimento richiesto. D’altronde la cura deve essere condotta in stato di astinenza” (Osservazioni sull’amore di traslazione, pp. 367-368).
33 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921), in S. Freud, Opere, Boringhieri, vol. IX; O. F. Kernberg, Le relazioni nei gruppi. Ideologia, conflitto e leadership, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999; mi permetto rinviare al mio articolo scritto dopo il G8 di Genova: C. Gilardi, Usi e abusi della paura, in “Nuvole”, 24 (2004), pp. 68-74.
 IT
IT  EN
EN 











