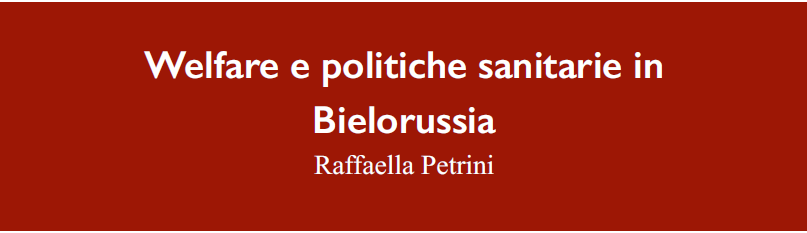
Salute e benessere
La salute, infatti, è un fattore che ha contribuito ad ampliare le disuguaglianze all’interno dei Paesi dell’ex blocco comunista come la Bielorussia, non solo perché la transizione ha creato situazioni di maggiore vulnerabilità ed esposizione ai rischi, ma anche perché i sistemi sanitari non sono riusciti ad adeguarsi con sufficiente rapidità, né a rispondere con altrettanta efficacia, ai nuovi bisogni della popolazione. La pandemia di COVID-19 ha presentato una sfida ulteriore anche per la Bielorussia, in un momento storico di instabilità e insoddisfazione interna, segnato dalle contestazioni che hanno seguito le elezioni presidenziali dell’agosto 2020, con la conferma di Alexander Lukashenko alla guida del Paese.
Dopo la crisi inattesa dovuta alle drammatiche conseguenze della diffusione del virus SARS-CoV-2, secondo alcuni analisti, senza precedenti nella storia moderna (Schwab, Malleret, 2020, p. 11), tra le politiche sociali una particolare rilevanza continuerà ad essere assunta proprio dalle politiche sanitarie, che già ne costituiscono una tipologia essenziale. La salute, infatti, continuerà a rappresentare un fattore fondamentale del benessere sociale perché, come ha ben evidenziato anche Marmot (2005, p. 1103), dalla sua tutela dipenderà non solo la riduzione delle diseguaglianze e il miglioramento dello stato generale medio della popolazione, ma anche una maggiore fiducia di quest’ultima nell’interesse delle istituzioni verso i suoi bisogni e nella volontà effettiva di soddisfarli.
La transizione dei sistemi sanitari
Il passaggio dal comunismo al post-comunismo dei Paesi dell’Europa centrale e orientale ha comportato profondi cambiamenti dei sistemi politici, economici e sociali delle repubbliche che costituivano l’Unione Sovietica, estendendosi naturalmente anche ai sistemi sanitari. Fino ad allora essi si erano sviluppati principalmente intorno al modello sovietico Semashko1. Questo era contraddistinto da una pianificazione centralizzata, fondata su numerose e poco efficienti strutture ospedaliere, su rigidi programmi verticali – per il trattamento di patologie psichiatriche, tubercolosi e tumori – e su un’organizzazione capillare di servizi di base e di strutture specialistiche territoriali (Maciocco, 2017)2. Tale modello, che assicurava la copertura sanitaria universale gratuita, funzionò piuttosto bene in URSS fino alla metà degli anni Sessanta, permettendo, in particolare, un più stretto controllo delle malattie infettive, che consentì di raggiungere significativi miglioramenti nello stato di salute della popolazione, molto vicini a quelli registrati nel più ricco e industrializzato Occidente.
La successiva transizione dei sistemi sanitari dal modello Semashko è stata guidata dalle istituzioni internazionali, in particolare dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale, che hanno assunto il ruolo privilegiato di advisors dei Paesi in transizione (Maciocco, 2009, p. 96). Ciononostante, l’impatto delle trasformazioni del sistema sanitario nei Paesi dell’ex-Unione Sovietica, si è rivelato traumatico, perché la perdita del ruolo centrale dello stato del modello Semashko, forte al di là dell’inefficienza, è stato accompagnato da altri eventi critici a diversi livelli, quali crisi economiche ripetute, instabilità politica e gravi conflitti etnici (Maciocco, 2009, p. 97). In molti Paesi (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kirghizistan, Moldavia), alle riforme si è associata una caduta del PIL pari anche al 50%, con prevedibili conseguenze di povertà diffusa, disoccupazione prolungata, crescente emarginazione sociale e drastica riduzione del benessere sociale. Anche in Russia si sono registrati effetti pesanti, in termini di perdita della rete di protezione dalle malattie fino ad allora garantita dallo stato. La privatizzazione dei servizi, infatti non è stata seguita dall’introduzione di adeguate strutture alternative di protezione o tipologie di assicurazioni sociali, a causa della scarsità delle risorse disponibili, dell’instabilità politica causata dalla transizione, ma anche di problemi di corruzione diffusa (Maciocco, 2009, p. 105).
La scarsa accessibilità ai servizi e la qualità mediocre delle prestazioni sanitarie, unitamente alla crisi economica del 1998, hanno contribuito a provocare una repentina discesa della speranza di vita della popolazione, aggravata dallo stress psicologico legato al grave disagio economico, ma anche alla perdita d’identità, alla disoccupazione, e al totale collasso delle reti di protezione sociale. Ciò ha indotto, soprattutto tra gli strati sociali meno istruiti, dei mutamenti negativi negli stili di vita, con una più alta incidenza delle malattie cardiovascolari e la diffusione dell’alcolismo.
Le politiche sanitarie bielorusse
A seguito dell’indipendenza dall’Unione Sovietica raggiunta nel 1991, la Bielorussia ha goduto di una certa stabilità economica, grazie ad una campagna di riforme moderate, sostenuta anche dalle forniture energetiche a basso costo provenienti dalla Federazione Russa. Sul piano sanitario, il sistema ha mantenuto molti degli elementi che avevano caratterizzato il modello Semashko, con carenze, tuttavia, sul piano della governance, a causa della sostanziale mancanza di una definizione legale degli ambiti di competenza, nonché delle risorse disponibili e allocate alle autorità locali. Seppure, infatti, la responsabilità relativa all’erogazione dei servizi sanitari sia demandata localmente, spesso si aprono dei vuoti in termini di competenza e di capacità finanziaria, con conseguenti carenze sul piano operativo (UNDP, 2005).
La percentuale della spesa sanitaria sul PIL bielorusso (5,6) è piuttosto contenuta anche rispetto agli altri Paesi membri della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e ancora lontana dalla media dei Paesi OCSE, pari a 8,8% nel 2019 (OECD, 2020)3.
È opportuno premettere che le ricerche sullo stato di salute della popolazione in Bielorussia non possono non tener conto del profondo impatto causato dall’incidente al reattore nucleare di Chernobyl, nel nord dell’Ucraina, avvenuto il 26 aprile 1986 e risultato il più grave nella storia. Negli anni successivi all’incidente sono stati avviati diversi programmi sanitari diretti a monitorare lo status di salute dei diversi gruppi coinvolti: i sopravvissuti alle radiazioni dirette, i cosiddetti “liquidatori”, chiamati a ripulire le scorie dell’esplosione, le popolazioni residenti nelle aree contaminate (WHO, 2006, pp. 115 ss.). Dispensari ad hoc sono stati creati per svolgere il duplice compito di raccogliere dati sulla morbilità e assistere i pazienti.
Negli anni più recenti, in Bielorussia come in altri Paesi membri della CSI, si sono registrati una sensibile decrescita della fertilità e un aumento dei tassi di mortalità, dovuti soprattutto a malattie non trasmissibili (MNT), generalmente suddivise in quattro grandi gruppi: malattie cardiocircolatorie, tumori, malattie respiratorie (principalmente asma e bronco pneumopatia cronico ostruttiva), diabete. A queste, come conferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO), è imputabile oltre il 70% dei casi di morte nel mondo e, più specificatamente, di circa 15 milioni di donne e uomini in età compresa tra i 30 e i 69 anni di età ogni anno (WHO, 2014). Costituendo una sfida notevole per tutti i Paesi del mondo, la loro drastica riduzione è stata integrata, come prevedibile, anche tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite4.
Nell’ultimo decennio l’aspettativa di vita alla nascita in Bielorussia è aumentata di 4 anni, passando a 69 anni per gli uomini e a 79 per le donne nel 2018 (WHO, 2019). È ancora significativo, tuttavia, il divario esistente rispetto agli altri Paesi europei: 9 anni per gli uomini e 10 per le donne (WHO, 2019). Il fumo appare uno dei determinanti sociali della salute più significativi, soprattutto per le donne, tra le quali, negli ultimi vent’anni, il consumo si è triplicato fino a raggiungere il 12% nel 2017. Il consumo di alcol, invece, altro problema preoccupante per la salute pubblica, è sceso significativamente negli ultimi cinque anni, ma ancora merita piena attenzione. Altri fattori di rischio legati alla mortalità per MNT sono una dieta sbilanciata (uso di sale in eccesso) e la scarsa attività fisica (WHO, 2019). Più recentemente è stata promossa una stretta collaborazione intersettoriale per promuovere la salute a livello nazionale. In questo contesto, sono state introdotte severe misure legislative contro il fumo, la cui efficacia potrà essere valutata solo nel prossimo futuro.
Riguardo all’impatto sulla popolazione delle malattie trasmissibili (MT), secondo i dati a disposizione (WHO, 2019), è ancora alta in Bielorussia l’incidenza del virus HIV e della tubercolosi. Obiettivo principale delle più recenti politiche sanitarie bielorusse, in generale, è stato quello di colmare il divario assistenziale tra le campagne e le città, assicurando maggiore equità nella distribuzione dei servizi sanitari e trasferendo risorse finanziarie dal settore ospedaliero alle cure primarie, come promosso dall’OMS in più occasioni e, in particolare, ad Astana, nel corso della Conferenza Globale dedicata a questo tema (WHO, 2018).
La risposta alla pandemia di COVID-19
L’OECD (2020) riporta che durante la prima fase della pandemia di COVID-19, l'impatto della crisi sanitaria sulla salute pubblica nei sei Paesi partner orientali (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina) si è rivelato più ridotto rispetto ai Paesi dell’Europa occidentale. La limitata mobilità intra-regionale ha contribuito inizialmente a contenere la diffusione del virus.
Nei mesi compresi tra marzo e dicembre 2020 il governo bielorusso ha introdotto lievi restrizioni e misure di allontanamento fisico, pur non precludendosi l’eventuale applicazione di norme più severe di fronte ad un repentino peggioramento della situazione (HSRM, 2020)5. È stato richiesto l'isolamento sociale solo per chi era affetto dal virus, per coloro che avevano avuto un contatto con un caso di positività accertato, o erano di ritorno da un’area geografica con un’alta diffusione del virus, anche se asintomatici. Il Ministero della Salute ha emanato restrizioni per vietare le visite non essenziali e i raduni di massa, nonché raccomandazioni sull’uso dei trasporti pubblici e sui contatti ravvicinati con persone particolarmente vulnerabili (anziani, persone affette da malattie croniche, donne in stato di gravidanza). L’utilizzo di mascherine protettive è stato reso obbligatorio per tutti coloro che lavoravano nei servizi sociali, gli impiegati degli uffici postali e i volontari che a diverso titolo fornivano prestazioni a domicilio. Limitazioni sono state imposte anche allo svolgimento di eventi culturali, sportivi e scientifici con partecipazione internazionale. Nello stesso periodo il governo ha anche elaborato delle misure ad hoc per potenziare i trasporti pubblici e aumentarne la frequenza, rivedendo i programmi scolastici, e cercando di contenere così il sovraffollamento durante le ore di punta, almeno nelle città. Le ferrovie bielorusse hanno introdotto nuovi piani per assegnare posti a sedere a bordo dei treni, con spazi sedili riservati ai passeggeri, per mantenere la necessaria distanza fisica negli scompartimenti.
Nell’aprile 2020, in considerazione dell’aumento dei contagi, la città di Minsk decideva di introdurre più severe misure di contenimento, incluso il divieto di partecipazione ad eventi pubblici, accompagnate da sanzioni amministrative in caso di violazione. Si sono tenute, tuttavia, le elezioni programmate per il 9 agosto 2020 e in quella occasione il Ministero della Salute ha emanato delle raccomandazioni specifiche. Il distanziamento sociale è stato imposto fino alla fine dell’anno 2020, unitamente all’utilizzo dei dispositivi di protezione.
La tutela della salute dopo la pandemia
Nell’ottobre 2020 la Bielorussia ha iniziato i propri test vaccinali contro il COVID-19 utilizzando il siero Sputnik V sviluppato in Russia, e avviando la vaccinazione di massa nel dicembre 2020, privilegiando il personale medico e quello a contatto diretto con gli ammalati COVID (AP News, 2020). Nel marzo 2021 si è iniziato ad utilizzare anche il vaccino cinese prodotto da Sinopharm, come pubblicamente annunciato dal Ministro della Sanità, Dmitry Pinevich. Al momento di andare in stampa Johns Hopkins University (2021) riportava che fossero stati amministrati in Bielorussia 924.926 vaccini, con 313.938 persone che avevano completato il ciclo vaccinale ed una copertura nazionale raggiunta del 3,32%.
Sul piano internazionale, l’Unione Europea e l’Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa, come dichiarato più volte, intendono lavorare insieme per sostenere la diffusione dei vaccini COVID-19 e la vaccinazione nei sei Paesi del Partenariato orientale, tra cui la Bielorussia. A tal fine, UE e OMS hanno stanziato un budget di 40 milioni di euro in tre anni – l’azione congiunta UE-OMS più consistente mai realizzata nella Regione Europea – che dovrebbe sostenere iniziative di solidarietà globale e regionale, per poter garantire un più esteso accesso ai vaccini nei Paesi coinvolti (WHO Europe, 2021). Tra queste iniziative va menzionata certamente quella relativa al COVAX Facility, co-guidata dall’OMS, per favorire la distribuzione equa dei vaccini e rafforzare i sistemi di immunizzazione nei singoli Paesi del Partenariato, come ribadito anche in occasione del recente Global Health Summit svoltosi a Roma il 21 maggio 2021. Accanto agli sforzi distributivi del progetto COVAX, sarà importante rafforzare anche all’interno del Partenariato le capacità di sviluppo e di produzione del siero, a livello locale e regionale.
Gli sforzi contro la pandemia non possono, tuttavia, essere oggetto esclusivo di attenzione delle politiche sanitarie bielorusse. Come menzionato, la sfida presentata da altre MT nel Paese è ancora viva e urgente. In particolare, la lotta contro la diffusione della tubercolosi richiederà lo sforzo coordinato delle istituzioni politiche e civili operanti in diversi settori della società. Anche le MNT rappresentano una minaccia significativa, sia per la salute della popolazione che per lo sviluppo economico della Bielorussia. Un Rapporto stilato nel 2018 dall’Ufficio regionale europeo dell’OMS ha quantificato l’onere economico delle MNT per il Paese, tanto in termini di costi diretti, ovvero legati all’aumento delle spese sociosanitarie e di sostegno al welfare, quanto in termini di costi indiretti, riconducibili al crescente tasso di assenteismo dal lavoro e alla riduzione della produttività del personale. Il Rapporto in questione stima una spesa nel 2015 di circa 3,3 trilioni di rubli bielorussi per il trattamento di quattro principali MNT: malattie cardiovascolari, malattie metaboliche e del sistema endocrino, malattie respiratorie croniche (WHO Europe, 2018, pp. 24 s.).
Sarà, quindi, importante per la Bielorussia continuare a rafforzare la legislazione di controllo sull’uso del tabacco, in particolare negli ambienti pubblici dove esistono già dei divieti, imponendo restrizioni sui prezzi e limitando le possibilità di accesso dei più giovani. Le stesse misure restrittive dovrebbero essere adottate in relazione all’uso dell’alcol, alla riduzione del consumo di sale nell’alimentazione, alla promozione di una dieta sana e dell’esercizio fisico.
In conclusione, con uno sguardo al futuro, oltre all’implementazione di misure idonee a contrastare la corrente pandemia, in linea con le indicazioni dell’OMS, nel medio-lungo periodo anche la Bielorussia sarà chiamata a prendere decisioni strategiche per la tutela della salute, bene pubblico fondamentale per il benessere sociale.
In tale prospettiva, tuttavia, è bene fare due premesse generali sui sistemi di welfare sanitario, che appaiono particolarmente significative in vista di eventuali riforme del sistema bielorusso. La prima è che gli attori che operano nell’ambito dei welfare nazionali sono molteplici (Saraceno, 2021, p. 5). Più soggetti, infatti, concorrono a favorire il benessere dei membri della società e ciò è ancor più vero in una società globalizzata, in cui le relazioni di dipendenza e interdipendenza si fanno più forti e più complesse. Tradizionalmente è stata utilizzata l’immagine del diamante per identificare i diversi soggetti coinvolti nella produzione di welfare: lo stato, il mercato, la famiglia, e il variegato mondo del terzo settore, che è parte integrante della società civile.
In tale scenario, mantengono sempre un ruolo di rilievo le politiche pubbliche, soprattutto in ambito sanitario. Nel corso della recente pandemia, queste hanno garantito in molti Paesi l’accesso ai vaccini e la tutela prioritaria dei soggetti più fragili, stabilendo i criteri di priorità per la loro distribuzione. Inoltre, esse sono essenziali per delineare un quadro legislativo che permetta ai diversi soggetti di cui sopra di operare in maniera collaborativa e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Lo stato, pertanto, dovrà continuare a svolgere un ruolo cruciale nel garantire sia la tutela della popolazione vulnerabile, sia l’implementazione di quelle linee guida fondamentali formulate a livello internazionale per assicurare la protezione della salute globale della popolazione, oggi esemplificate almeno in parte dai già citati SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
La seconda premessa, strettamente legata alla prima, è che, in questo processo di profonda trasformazione, i welfare nazionali stanno diventando sempre più permeabili ai propri confini: ai flussi di persone e capitali, ma anche a suggerimenti, sollecitazioni, imposizioni degli organismi sovranazionali, che ne complicano la governance (Saraceno, p. 142). Alcuni, tuttavia, mantengono un più alto livello di permeabilità e, in alcuni casi, ciò può essere di ostacolo alla riduzione delle disuguaglianze, nonché all’attuazione di politiche più collaborative e coordinate sul piano internazionale, informate da valori condivisi. Certo è che le politiche sanitarie oggi, essenziali per lo sviluppo del benessere sociale, richiedono tale coordinamento per poter essere efficaci, soprattutto di fronte a tendenze epidemiologiche che sembrano indicare una maggiore frequenza delle pandemie. Inoltre, le politiche sanitarie, come le altre politiche sociali dirette ad incrementare il welfare e, dunque, lo “stare bene” dei cittadini (Saraceno, p. 5), chiamano in causa direttamente la tutela pubblica dei diritti della persona.
Alla luce di queste due premesse, per superare i retaggi strutturali del modello Semashko ed adeguarsi alle esigenze dei moderni “sistemi di salute” (WHO, 2000, p. 5), la Bielorussia dovrà riformare il proprio sistema sanitario, per orientarlo al raggiungimento di quelli che vengono considerati tre obiettivi fondamentali: a) migliorare la salute della sua popolazione, b) rispondere anche alle aspettative non mediche che ne derivano per le persone, c) continuare a fornire protezione finanziaria contro i costi legati alle malattie (Missoni, Pacileo, 2016, p. 181). Questi tre obiettivi appaiono coerenti con la definizione di salute elaborata dall’OMS già nel 1946, quale stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto come mera assenza di malattia o di infermità (Grad, 2002, p. 981). Si tratta evidentemente di un concetto esteso ed inclusivo di varie dimensioni della vita umana, che supera il modello “biomedico” della salute in favore del modello “sociale” (Blaxter, 2004, pp. 11-19). Dal punto di vista personalista, i due modelli sono piuttosto “integrati” all’interno di una visione della salute umana che include più dimensioni relative alla natura ontologica unitaria della persona, nella sua realtà esistenziale di anima-forma e corpo-materia (Sgreccia, 2007, pp. 148-155). Tali dimensioni riguardano tanto la sfera individuale organica, psichica e spirituale, quanto la sfera ecologico-sociale ed etica, direttamente riconducibile al contesto in cui si svolge la vita comune.
In questo senso, la salute umana rinvia ad una nozione complessa ed “integrale”, che coinvolge pienamente anche le condizioni di partecipazione della persona all’interno dei citati sistemi organizzativi in cui concretamente si svolge la sua esistenza quotidiana: stato, mercato, famiglia e società civile6. È importante osservare, infatti, che questi sistemi interdipendenti sono chiamati a mediare costantemente il rapporto degli individui con la natura circostante per la soddisfazione di bisogni di varia natura.
In generale, è facilmente immaginabile che vi siano dei trade-off tra sistema politico, economico e sociale, affinché vengano fornite le infrastrutture, i servizi, le norme e i contesti adeguati e necessari a rendere disponibili e usufruibili sia i beni materiali, che i beni immateriali, inclusa la salute e l’accesso alle cure. Ciò implica, inevitabilmente, delle scelte di natura etica, oltre che di politica sanitaria.
Recentemente, la Bielorussia è stata inclusa tra i Paesi del board esecutivo dell’OMS, dunque tra quelli chiamati a definire l’agenda dell’Organizzazione stessa e ad applicarne le strategie (WSJ, 2021). Questa decisione fa presupporre che anche la Bielorussia debba sostenere appieno un concetto di ‘salute’ più ampio, coerente con quello definito dall’OMS nella sua Costituzione. Tale concetto, anche grazie all’apporto di importanti economisti come il Premio Nobel Amartya Sen, oggi implica l’ampliamento delle cosiddette «basi informative» del welfare, con cui «i diversi soggetti-agenti si muovono nel prendere le proprie decisioni ed effettuare le proprie scelte» (Marzano, 2011, p. 207). È necessario, cioè, estendere i criteri per la misurazione del welfare al di là del mero reddito, includendo in esso, oltre ai tradizionali beni “materiali” legati al profitto e ai servizi, anche altri beni “immateriali” essenziali e socialmente rilevanti, tra cui la salute, ma anche i diritti e le libertà individuali attorno a cui si strutturano i sistemi interdipendenti di cui sopra.
La Bielorussia non potrà non confrontarsi con quei “conflitti di interessi” che costituiscono «una situazione di rischio presente molto diffusamente nel settore della tutela della salute» (Dirindin, Caruso, 2019, p. 168). In ambito sanitario, infatti, è bene riconoscere che sempre si sviluppa «una fitta rete di relazioni» tra molteplici soggetti portatori di interessi spesso, almeno in parte, anche divergenti: medici, pazienti, aziende farmaceutiche, decisori (Dirindin, Caruso, p. 168). Il raggiungimento primario del mantenimento o miglioramento della salute individuale e collettiva può facilmente intrecciarsi con obiettivi di diversa natura, politica, economica e commerciale, di gratificazione personale o avanzamento professionale. Il livello di consapevolezza circa l’esistenza di questi conflitti è il primo passo per poter elaborare strategie di contenimento degli stessi. La collaborazione internazionale “esterna” richiesta per la tutela della salute, resasi particolarmente evidente con la recente pandemia, ma egualmente necessaria per portare avanti le strategie di implementazione degli SDGs, esige una corrispondenza “interna”. Una maggiore esposizione al rischio dei conflitti d’interesse in ambito sanitario, infatti, non solo provoca perdite in termini economici e di efficacia nel tutelare la salute dei cittadini, sottraendo risorse alle cure, ma induce anche perdite di natura sociale (Dirindin, Caruso, p. 172).
La crescente attitudine collaborativa tra Paesi e istituzioni, la sperimentazione di nuove forme di partenariato pubblico-privato che recentemente si sono concretizzate nell’ambito della produzione e della distribuzione dei vaccini contro il COVID-19, esigono un generale rafforzamento di quella «alleanza terapeutica» che dovrebbe riequilibrare l’asimmetria informativa tipica delle relazioni paziente-medico e paziente-istituzioni in campo sanitario (D’Agostino, Palazzani, 2007, p. 124). Per questo è necessaria una maggiore trasparenza informativa, condizione essenziale per promuovere la prevenzione e l’impegno di ogni cittadino a «considerare la propria vita e quella altrui come un bene non soltanto personale, ma anche sociale» (Sgreccia, 2019, p. 235), proteggendo pure il consenso informato del paziente, al quale viene riconosciuta la libertà di scelta, anche nella condizione di vulnerabilità aggravata dalla malattia.
Salute, diritti e libertà si presentano, dunque, intrinsecamente connessi e ancor più correlati alla luce della definizione estesa di salute promossa dall’OMS fin dalla sua istituzione. La Bielorussia si trova ora di fronte ad un bivio estremamente delicato, chiamata ad assumere un ruolo decisionale a livello internazionale in materia sanitaria, in un momento difficile della sua storia. Il futuro proverà se le sue istituzioni saranno in grado di sostenere questa sfida radicale, non solo nel periodo post-pandemico, al fine di assicurare ai propri cittadini un livello di welfare adeguato, che includa gli elementi materiali ed immateriali necessari a garantire la salute “integrale” della persona.
Raffaella Petrini
Fonti e riferimenti bibliografici
AP News (2020), Volunteers in Belarus get shots in virus vaccine trial, 1 ottobre, https://apnews.com, ultimo accesso 13 giugno 2021.
Blaxter Mildred (2004), Health, Cambridge, Polity Press.
D’Agostino Francesco, Palazzani Laura (2007), Bioetica, Brescia, La Scuola.
Dirindin Nerina, Caruso Enza (2019) Salute ed economia, Bologna, il Mulino.
Grad Frank (2002), The Preamble of the Constitution of the World Health Organization, «Bulletin of the World Health Organization», LXXX, 12, pp. 981-984.
HRSM: Health System Response Monitor (2020), Belarus, https://eurohealthobservatory.who.int, ultimo accesso 12 giugno 2021.
Johns Hopkins University (2021), Coronavirus Resource Center, https://coronavirus.jhu.edu, ultimo accesso 12 giugno 2021.
Maciocco Gavino (2009), Politica, salute e sistemi sanitari, Roma, Il Pensiero Scientifico Editore.
Maciocco Gavino (2017), 100 Anni dalla Rivoluzione d’Ottobre, «Salute internazionale», 12 ottobre, https://www.saluteinternazionale.info, ultimo accesso 3 maggio 2021.
Maciocco Gavino, Santomauro Francesca (2017), La salute globale, Roma, Carocci Faber.
Marmot Michael (2005), Social Determinants of Health Inequalities, «The Lancet», n. 365, pp. 1099-1104.
Marzano Ferruccio (2011), Lezioni di economia pubblica, Roma, EuRoma.
Missoni Eduardo, Pacileo Guglielmo (2016), Elementi di salute globale, Milano, FrancoAngeli.
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (2020), COVID-19 crisis response in Eastern Partner Countries, https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-eu-eastern-partner-countries-7759afa3/, ultimo accesso 28 aprile 2021.
Piketty Thomas (2013), Le capital au XXIe siècle, Paris, Seuil.
Saraceno Chiara (2021), Welfare. Tra vecchie e nuove disuguaglianze, Bologna, il Mulino.
Schwab Klaus, Malleret Thierry (2020), COVID-19: The Great Reset, Geneva, Forum Publishing.
Sgreccia Elio (2007), Manuale di bioetica, Vol. 1, Milano, Vita e Pensiero.
Sgreccia Palma (2019), Vulnerabili, bisognosi e capaci di scelte, Roma, Angelicum University Press.
UNDP: United Nations Development Programme (2005), Belarus: addressing imbalances in the economy and society. National Human Development Report 2004-2005, https://planipolis.iiep.unesco.org, ultimo accesso 13 giugno 2021.
WHO: World Health Organization (2000), The World Health Report, World Health Organization, Geneva, https://apps.who.int, ultimo accesso: 15 giugno 2021.
WHO (2006), Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes, https://www.who.int, ultimo accesso 11 giugno 2021.
WHO (2014), Global status report on noncommunicable diseases 2014, https://apps.who.int, ultimo accesso 13 giugno 2021.
WHO (2018), Health Coverage and the Sustainable Development Goals, https://www.who.int, ultimo accesso 30 aprile 2021.
WHO (2019), Biennial Collaborative Agreement (BCA)2020-2021, https://www.euro.who.int, ultimo accesso 10 giugno 2021.
WHO Europe (2018), Prevention and control of noncommunicable diseases in Belarus. The case for investment, https://www.euro.who.int , ultimo accesso 13 giugno 2021.
WHO Europe (2021), The Solidarity for Health Initiative, https://www.euro.who.int, ultimo accesso 12 maggio 2021.
WSJ: Wall Street Journal (2021), All the WHO’s Dictators, 1 giugno, https://www.wsj.com, ultimo accesso 3 giugno 2021.
NOTE:
1 Nikolay Semashko (1874-1949), medico e professore di Igiene sociale, membro dell’Accademia delle Scienze mediche, fu nominato commissario del popolo per la sanità pubblica nel 1918 ed è considerato uno dei maggiori ispiratori delle riforme sanitarie in URSS.
2 La Bielorussia ha il numero più elevato di posti letto ospedalieri pro capite tra i Paesi della CSI e dell'Europa centrale e orientale.
3 La Comunità degli Stati Indipendenti identifica l’organizzazione internazionale di cooperazione economica, politica e militare, costituitasi nel 1991 a seguito scioglimento dell’URSS. Comprende attualmente Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Federazione Russa, Uzbekistan.
4 L’OMS ha riconosciuto al governo bielorusso di aver assunto un ruolo di leadership nella regione, soprattutto con riguardo alla promozione degli SDGs, attraverso l’integrazione dei relativi indicatori nelle politiche sanitarie nazionali (WHO, 2019). Il governo ha nominato un Coordinatore nazionale per gli SDGs ed è stato istituito un Consiglio nazionale per lo sviluppo sostenibile.
5 Il COVID-19 Health System Response Monitor è un’iniziativa congiunta promossa dall’Ufficio Regionale per l'Europa
dell’OMS, la Commissione europea e l’Osservatorio europeo sui Sistemi sanitari e sulle Politiche sanitarie, al fine di raccogliere ed organizzare i dati correnti sulle politiche avviate nei diversi Paesi per affrontare la pandemia, in particolare relativi alle risposte dei vari sistemi sanitari e alle iniziative attuate a tutela della salute pubblica.
6 La società civile, con i suoi corpi intermedi – soggetti educativi, culturali, religiosi, accanto alla cellula fondamentale di base che è la famiglia – è preposta a garantire tutte quelle condizioni necessarie affinché l’uomo possa vivere la sua dimensione relazionale e affettiva, potendosi così realizzare pienamente fino a giungere al suo senso ultimo. Al mercato, invece, nello scambio efficiente e nella produzione efficace di beni e servizi spetta fornire tutto ciò che è fisiologicamente necessario alla vita nella sua quotidianità (es. alimenti, abbigliamento, trasporti). Lo stato, infine, è tradizionalmente preposto a garantire la sicurezza, deputato all’ordine interno e alla difesa dalle minacce esterne.
 IT
IT  EN
EN 











