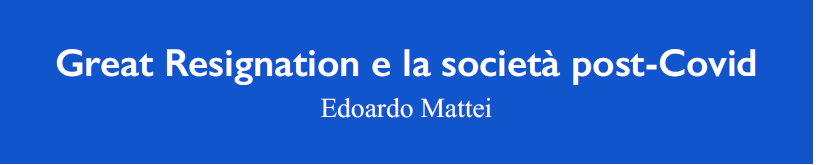![]() Il fenomeno Great Resignation, l’aumento costante e continuo di dimissioni volontarie dal lavoro, entra saltuariamente nel dibattito italiano senza raccogliere l’interesse che merita. Colpisce, nell’attuale difficile contingenza, la scelta volontaria di abbracciare un periodo di precarietà lavorativa anziché ricercare un solido ancoraggio esistenziale. Le spiegazioni di natura economica non convincono fino in fondo e molte domande rimangono irrisolte.
Il fenomeno Great Resignation, l’aumento costante e continuo di dimissioni volontarie dal lavoro, entra saltuariamente nel dibattito italiano senza raccogliere l’interesse che merita. Colpisce, nell’attuale difficile contingenza, la scelta volontaria di abbracciare un periodo di precarietà lavorativa anziché ricercare un solido ancoraggio esistenziale. Le spiegazioni di natura economica non convincono fino in fondo e molte domande rimangono irrisolte.
Il presente contributo affronta questi interrogativi attraverso un’analisi più ampia del fenomeno e propone una visione sul possibile sviluppo futuro.
1. I dati della Great Resignation
Il 10 maggio 2021, Antony Kloz, professore associato di management alla Texas A&M University, rilasciava un’intervista a Bloomberg in cui annunciava: «sta arrivando la Great Resignation»1. Infatti, nei mesi seguenti, ben 47,4 milioni di lavoratori statunitensi si sono dimessi dai loro impieghi e molti senza avere pronte delle alternative.
A metà settembre, l’Harvard Business Review2 pubblicava un’analisi su più di 9 milioni di lavoratori in oltre 4.000 aziende, da cui risultò che la tendenza più forte alle dimissioni era nella fascia di età 30-45, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno, ricordava Derek Thompson su Atlantic3, era comparso anche negli anni ’60 e ’70 ma in presenza di un’economia più florida, scomparendo con la crisi del decennio seguente per la paura di perdere, se disoccupati, i benefici dell’assistenza sociale.
Kathryn Hymes, su Wired4, riportava che il 40% dei lavoratori intervistati progettava di dimettersi nei seguenti 3-6 mesi e il 18% lo riteneva certo. Il sondaggio, effettuato in Australia, Canada, Singapore, USA e Regno Unito, riportava risultati incredibilmente omogenei. Persino gli imprenditori erano concordi (54%) nel percepire un turnover maggiore del solito e molti (64%) si aspettavano un peggioramento. In generale, chi pensava di dimettersi non aveva ancora trovato un’altra occupazione nel 36% dei casi.
Anche l’Italia è stata colpita da questo fenomeno.
Analizzando le Note trimestrali del II trimestre 2021 del Ministero del Lavoro5, si scopre che tra aprile e giugno (inizio della Great Resignation) sono terminati 2.587.000 contratti. Il 59% di questi si è concluso con le dimissioni volontarie dei lavoratori segnando l’incremento record del 37% rispetto al trimestre precedente, dell’85% su base annua e del 10% rispetto al 2019. Il rapporto Excelsior6 del mese di ottobre 2021 evidenzia come, a fronte di 2,4 milioni di disoccupati, ci siano ben 505.000 posti vacanti, specialmente nel settore ICT, con una crescita del 29% rispetto al 2019.
ISTAT conferma che nel 2021 l’Italia ha recuperato 650 mila occupati, per il 60% con impieghi precari - infatti mancano ancora 286 mila per tornare al febbraio 2020. Non bisogna farsi ingannare da letture quantitative o statistiche. Da inizio pandemia (appunto, febbraio 2020) l’Italia ha perso quasi mezzo milione di forza lavoro (481 mila per la precisione). Il ritorno al 59% del tasso di occupazione, lo stesso del pre-Covid, è artefatto contabile: il divario si è chiuso solo a livello di tasso di occupazione, non di occupati.

Il quadro generale è piuttosto fluido e contraddittorio: alta disoccupazione, grande offerta di impiego, aumento delle dimissioni dal lavoro, crescita economica. Quali sono le cause che si ipotizzano? Quali sono le soluzioni prospettate?
2. Un problema economico?
Le prime reazioni collocavano il problema all’interno delle dinamiche industriali e lavorative, proponendo soluzioni ingenue o semplicistiche. Ad esempio, si accusava il deterioramento delle relazioni e la scarsa capacità di coinvolgimento dei collaboratori da parte dei responsabili. Così Jill Hauwiller di Forbes7, basandosi su una ricerca dell’Harvard Business Review8 in cui si notava l’incapacità del 37% dei manager di dare feedback positivi, consigliava di esprimere gratitudine in modo efficace.
Gli osservatori economici si concentrarono sulla staticità del lavoro nell’ultimo anno. Il fenomeno si giustificava con la ripresa del mercato che, avendo liberato le domande in attesa, le vedeva sovrapporsi e sommarsi alle normali richieste del periodo in corso. Altri ipotizzarono una reazione al burnout, il punto di rottura dello stress raggiunto quando l’impegno quotidiano diventa superiore alle proprie forze. Si cercò di frenare l’emorragia di lavoratori anche con l’aumento dei salari, ma si crearono le condizioni favorevoli affinché si cercassero nuove occupazioni più redditizie. Non ultima, venne la critica ai sussidi sociali. L’accusa ricorrente era di disincentivare la ricerca e l’impegno nel lavoro. L’aumento dell’assistenza alla disoccupazione era stato visto da molte aziende come un premio all’ozio. Inoltre, le minori occasioni di spesa, causa lockdown e restrizioni, aveva permesso l’accumulo straordinario di risparmio tale da affrontare con meno affanno i periodi di inattività.
Marco Bentivogli, ex segretario generale Fim-Cisl ed oggi Coordinatore Nazionale di Base Italia, ha cercato di portare la Great Resignation al centro della discussione con articoli e interviste sulla stampa nazionale. Anche nel suo ultimo libro affronta questo tema9. Bentivogli mette in evidenza una perdita di senso del lavoro come strumento di autorealizzazione notando che «il ‘valore’ del lavoro non corre di pari passo con l’importanza soggettiva del suo senso […] la vera sfida è ripensare un lavoro che renda più umani»10. L’ex sindacalista, portatore di una nuova visione del mondo industriale, auspica un “lavoro ad umanità aumentata”, un lavoro che «richieda la nostra dote più incontendibile con le macchine e cioè la nostra #umanitàaumentata»11. Per fare questo, occorre «valorizzare la libertà di scelta delle persone e le motivazioni che orientano i loro percorsi»12. Rilevando come il lavoro sia anche relazione, afferma che «ritessere la comunità di lavoro è fondamentale proprio per ricostruire il nuovo senso del lavoro»13.
Sono osservazioni sicuramente valide, ma ancora nel solco dell’analisi economica ed ignare degli aspetti antropologici e sociali di due anni di pandemia. Uno sguardo interdisciplinare, capace di guardare alla poliedricità dell’animo umano, mostra motivazioni e tendenze che sfuggono ad economisti ed imprenditori.
3. Workism e Crisi Sociale
Le spiegazioni fin qui riportate, sono sicuramente vere ed importanti, ma non spiegano un fenomeno così particolare e duraturo. Great Resignation e ‘lavoro ad umanità aumentata’ sono definizioni che raccontano le increspature in superficie. Manca il racconto del riallineamento in atto fra lavoro e vita personale, lì dove si inserisce la riscrittura del senso del lavoro. Nella ricerca di questo bilanciamento, la riflessione si deve allargare e farsi inclusiva della famiglia, degli amici, della vita spirituale. Come afferma la già citata K. Hymes, dobbiamo comprendere e descrivere un nuovo evento, abbandonare termini e concetti non più attuali, «dobbiamo sviluppare un vocabolario più ampio su come il lavoro si stia evolvendo alla luce della pandemia»14.
Una delle parole da ripensare è burnout, frettolosamente usata per giustificare o condannare qualsiasi comportamento. Dovremmo allargarne il concetto ed includere il complesso di sentimenti d’impotenza rabbiosa e disperata provati per la morte di tante persone che non erano estranei, ma familiari, amici, colleghi; della privazione del contatto fisico, del pianto nascosto nell’intimità di un abbraccio, delle relazioni costruite sulla condivisione della vita. A differenza di altri eventi drammatici e terribili, dagli incidenti ai terremoti, la pandemia persiste nel tempo e rinnova dolori e sofferenze. A questo si aggiungono le preoccupazioni per la guerra in atto e le sue conseguenze. Per questo motivo, la morte si percepisce così vicina, tutti i giorni, fino ad interrogarci sul perché delle nostre azioni, lo scopo, il fine, l’eskaton. La vita si rivela per quello che è: fragile, breve, meravigliosa. Davvero, vale la pena sacrificarla per il lavoro? Cosa fornisce senso, appagamento, soddisfazione felicità all’esistenza?
Con le scuole in DAD, la maggioranza delle donne ha dovuto rinunciare al proprio lavoro per stare con i figli. Lo smart working può averle aiutate, ma laddove lo era anche il compagno chi avrebbe cucinato, fatto la spesa, pulito la casa? Il lavoro da casa e le restrizioni hanno favorito la costruzione di una comunità di lavoro online, ristabilito o mantenuto i legami che il distanziamento fisico stava rompendo. La pandemia ha riportato le famiglie in una situazione relazionale pre-industriale, dove tutto il gruppo viveva e lavorava in spazi comuni. La riscoperta della dimensione familiare ha imposto una riflessione personale sul lavoro: vale il sacrificio della mia famiglia, dei miei hobby, dei miei interessi? Se lo facessi per la mia famiglia, che senso avrebbe se non possiamo stare insieme? Sono domande urgenti per le categorie più svantaggiate che devono lavorare il doppio per ottenere i benefici riconosciuti ai lavoratori più privilegiati. Parlo di donne con paghe inferiori agli uomini, di migranti, di precari. Il sussidio statale può essere apparso come una compensazione dei torti subiti o aver dato una sicurezza temporanea a quanti volevano abbandonare un lavoro malpagato o irregolare e cercare un’opportunità migliore.
Anche queste spiegazioni sono vere, eppure non sono ancora sufficienti per una motivazione esaustiva. Infatti, devono essere lette sullo sfondo del progressivo abbandono del workism, un processo in atto in tutto il mondo, Cina compresa.
Derek Thompson definisce il workism «la convinzione che il lavoro non sia solo necessario alla produzione economica, ma anche il fulcro della propria identità e dello scopo della vita; e la convinzione che qualsiasi politica volta a promuovere il benessere umano debba incoraggiare sempre più lavoro»15. Un tempo il lavoro era finalizzato alla sopravvivenza e a soddisfare le necessità più urgenti della vita. Con l’industrializzazione, i bisogni primari sono stati soddisfatti e si è rivolta l’attenzione alla produzione e consumo dei beni effimeri, indicatore del livello di realizzazione personale16. Il lavoro, da mezzo di sopravvivenza, è diventato carriera e la scrivania è diventata l’altare su cui sacrificare la propria vita. Così facendo si sono soddisfatte le esigenze del mercato lasciando inappagati i desideri personali.
Non è un caso che siano i Millennials i protagonisti della Great Resignation. Più istruiti delle generazioni precedenti e da queste convinti che il duro lavoro avrebbe ricompensato i sacrifici, si ritrovano dal 2008 al centro di una continua crisi. Il sentimento prevalente è di tradimento e di inganno tanto da chiedersi: «vale la pena sacrificare la propria vita per tutto questo?»
Persino in Cina è sorto un movimento culturale analogo. Lying Flat is Justice è il nome di un post di Luo Huazhong, un giovanotto della provincia del Sichuan che ha lasciato il posto fisso per vivere di lavori saltuari girando liberamente il paese in bicicletta. Il Lying Flat ha avuto subito successo tanto da convincere il New York Times ad intervistare Huazhong17 e la censura governativa a cancellare il post18. Le motivazioni sono le stesse: un ritmo di vita insostenibile, promesse non realizzate, desiderio di maggiore tempo per sé.
In definitiva, nel nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata, il lavoro non è più il fulcro dell’identità. Uno studio della Harvard Business School19 ha mostrato come la stragrande maggioranza dei lavoratori è felice quando sta con familiari ed amici ed i neolaureati ambiscono lavori che lascino loro tempo sufficiente per coltivare interessi personali ed hobby.
La facoltà di scienze sociali della Cambridge University ha condotto una ricerca sull’employment dosage20, cioè la quantità ottimale di lavoro retribuito per mantenere la “sanità mentale”. Meno di un giorno di lavoro retribuito a settimana genera depressione, di più non produce vantaggi apprezzabili se non il rischio di stress e burnout. «Nei prossimi decenni potremmo vedere l'intelligenza artificiale, i big data e la robotica sostituire gran parte del lavoro retribuito attualmente svolto dagli esseri umani», ha affermato il dott. Daiga Kamerāde, capo ricercatore di Employment Dosage. «Se non c'è abbastanza lavoro per tutti coloro che vogliono lavorare a tempo pieno, dovremo ripensare le norme attuali. Ciò dovrebbe includere la ridistribuzione dell'orario di lavoro, in modo che tutti possano ottenere i benefici per la salute mentale di un lavoro, anche se ciò significa che lavoreremo tutti per settimane molto più brevi».
Ad inizio 2020, la premier finlandese Sanna Marin ha proposto un orario di lavoro flessibile di 24 ore settimanali (quattro giorni per sei ore), come ulteriore riduzione delle 30 ore lavorate allora, secondo l’OCSE, la media europea è di 30 ore settimanali e in Italia ne lavoriamo 33, in Svezia e in Germania si lavorano 26 ore, in Olanda 28 e 29 in Francia.
È possibile che nel futuro lavoreremo solo un giorno a settimana?
4. Crisi del capitalismo
Luciano Floridi ritiene equivoca la definizione di ‘Intelligenza Artificiale’ perché ipotizzerebbe una qualche capacità razionale del tutto assente in un dispositivo tecnologico digitale. La meraviglia, secondo il filosofo, è la capacità di svolgere perfettamente dei compiti a ‘zero intelligenza’, cioè l’Intelligenza Artificiale altro non sarebbe che la capacità dell’uomo di far eseguire ad una macchina priva di intelligenza il lavoro di un uomo intelligente ed esperto21.
L’Intelligenza Artificiale è fondamentale per l’Industria 4.0 e Bentivogli afferma che «le vere aziende 4.0 inseriscono negli obiettivi la “zerofatiche”, perché la fatica è sempre più inutile e costosa e con essa gli eccessivi carichi posturali, la scarsa ergonomia»22. È un processo in cui le macchine a zero intelligenza sostituiscono il lavoratore umano, generico o specializzato (sicuramente una risorsa con intelligenza). La narrazione comune vuole che il progresso tecnologico crei più posti di lavoro di quanti ne distrugga. Oggi siamo ancora sotto i livelli occupazionali di pre-pandemia che, a loro volta, erano sotto i livelli del 2008 e, nonostante tutto, aumenta la produzione e il prodotto interno lordo. Grazie alla tecnologia si produce di più, con meno costi e meno lavoratori umani. La tecnologia sembra produrre pochi posti di lavoro oltretutto precari, malpagati e non appaganti. Si cercano persone con alti livelli di studi e di preparazione che, di contro, nutrono forti aspettative disattese dalle condizioni di lavoro offerte23. Spesso l’adagio «non trovo personale adatto» dovrebbe completarsi con «non trovo personale adatto alle condizioni che voglio pagare».
È un problema che nasce da lontano ed oggi si manifesta in tutta la sua virulenza.
Fino agli anni ‘70 il sistema economico riusciva ancora a garantire un progresso e ogni incremento di produttività determinava un aumento di occupazione con trasferimento proporzionato delle ricchezze al lavoratore. In questa fase, è ancora attivo lo sgocciolamento24 della ricchezza dalle classi abbienti verso le classi sociali più basse. L’industrializzazione permise di aumentare la quantità di beni prodotti, l’abbassamento dei prezzi ed aumenti salariali che permettevano la creazione di nuovi mercati, cioè la possibilità di spendere maggiormente e diversificare gli acquisti. Si lavorava tanto e con sacrificio, ma si migliorava la qualità della vita. Intere generazioni hanno tratto vantaggio da questo sviluppo potendo accedere ai beni primari tanto da iniziare a rivolgere l’attenzione a quelli superflui, segnando il passaggio dall’economia di scarsità all’economia dell’abbondanza. Ogni famiglia aveva il padre assunto con posto fisso ed un reddito sufficiente per accumulare un risparmio, mandare i figli a scuola, curarsi, avere un’auto, villeggiare. Il benessere determinò la saturazione del mercato dei beni primari e la conseguente richiesta di prodotti personalizzati e diversificati. La nuova domanda impose processi di ristrutturazione aziendale e il contenimento dei costi di produzione, obiettivo che si raggiunse ricorrendo alla meccanizzazione ed ai licenziamenti. Il tentativo di correzione generò un modello definito “neoliberalismo”25 che, a sua volta, è stato messo in crisi dalla progressiva introduzione delle tecnologie digitali e robotiche.
Lo studio di Erik Bryniolfsson e Andrew McAfee26, dimostra come l’occupazione nell’industria privata non cresca più nonostante l’aumento della produttività: le industrie producono di più ma non assumono. In Italia, Domenico De Masi27 e Roberto Ciccarelli28 parlano della fine del lavoro, della scomparsa della manodopera e della necessità di ripensarne le categorie. Il primo passo in questa direzione è considerare superato e superabile il modello produttivo attuale. Domandiamoci: siamo nella condizione migliore possibile e non ci sono ulteriori opzioni? Dobbiamo accettare che il (neo)liberalismo sia il sistema economico ottimale? Se non ci fosse un’alternativa significherebbe che l’evoluzione economica umana avrebbe trovato un limite invalicabile. Così formulato, il postulato è difficile da credere in modo convincente: colonizzeremo Marte nell’arco di due secoli, faremo innesti cibernetici ma non cambieremo sistema produttivo?
Josh Bivel e Lawrence Mishel29 hanno dimostrato che, dal 1980 ad oggi, a fronte dell’aumento della produttività del 72%, la quota di ricchezza trasferita ai produttori è stata del 63%. Nello stesso periodo la crescita del reddito medio è stata del 42,5%, ma l’aumento del reddito mediano solo 8,7%. Grazie alla tecnologia si fanno più guadagni con meno persone e con retribuzioni più basse. L’evoluzione cui stiamo assistendo sta estromettendo gli uomini dalla produzione aprendo un problema sociale ed antropologico nuovo. «Senza un approccio sistematico alla costruzione di una nuova economia, e senza la solidarietà strutturale che occorrerebbe per far passare un simile cambiamento»30 i lavoratori sono destinati alla povertà o peggio ad ingrossare la classe dei lavoratori poveri31.
Dunque, il lavoro sembra sia sempre più appannaggio dei sistemi tecnologici confinando l’uomo in un angolo di povertà più o meno estrema. Se è questo il nostro futuro, quale alternativa si può ipotizzare? Davvero domani ci sarà più occupazione, il lavoro sarà più gratificante, umano e ben pagato? Davvero varrà la pena continuare a sacrificarsi aspettando questo futuro? I Millennials non ci credono più e le nuove generazioni addirittura non riescono ad entrare nel mondo del lavoro.
5. Il lavoro umano
Non lavorare o, peggio, non sacrificarsi nel lavoro appare una blasfemia, quasi la volontà di sfuggire alla punizione comminata dal Signore ad Adamo ed Eva: guadagnarsi da mangiare «con la fatica e il sudore della fronte» (Gen 3, 17-19). L’esegesi rabbinica non giustifica questo senso di colpa32. Il Signore punisce la Terra per le sue disubbidienze ed a lei rivolge la condanna: “cardi e spine produrrai” (Gen 3, 18). Adamo, sentendolo, domanda: «dovrò mangiare con gli animali nella stessa greppia?». Impietosito, il Signore risponde: «con il sudore della tua fronte mangerai» (Gen 3,19). È un comando positivo e non una punizione. Il lavoro è orientato verso un bene, è capace di significare la peculiarità umana, di rispettarne la dignità. Il lavoro positivo, benché con sudore, meglio si accorda con il vero lavoro cui era destinato l’uomo: «il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen 2, 16). Esiste un lavoro buono, bene-detto in cui l’uomo può sentirsi felice, in armonia e relazione con il prossimo, il creato e Dio. È il modello cui possiamo ispirarci per la costruzione di una società migliore.
Il lavoro appartiene alla condizione originale umana e non è una punizione o una maledizione. Diventerà fatica dopo il peccato di Adamo ed Eva, ma rimarrà la memoria del riposo settimanale come limite alla tentazione di sfruttamento o asservimento al lavoro. L’attività umana è pensabile anche come partecipazione all’opera creatrice e della redenzione, un mezzo di santificazione e animazione delle realtà terrene nello Spirito di Cristo.33 C’è una nobiltà nel lavoro a condizione che il lavoro sia rispettoso della dignità umana: «non c’è, infatti, alcun dubbio che il lavoro umano abbia un suo valore etico, il quale senza mezzi termini e direttamente rimane legato al fatto che colui che lo compi è una persona».34
Papa Francesco ha più volte denunciato la disumanizzazione del lavoro attraverso l’esasperazione del profitto e delle tecnoscienze, quella cultura digitale invisibile che governa il mondo e fa accadere eventi, come sembra volerci dire nella Laudato Si. Cambia la dimensione oggettiva del lavoro, le condizioni, le tecniche e le risorse con sui viene eseguita l’attività umana, e cambia anche la dimensione soggettiva, la consapevolezza del suo agire ed il significato che ne attribuisce. Già Bartolomeo Sorge richiamava alla necessità «di un nuovo patto sociale, fondato su un rinnovato senso di solidarietà e di partecipazione, condiviso sia dagli imprenditori, sia dai lavoratori. Con ogni probabilità si dovranno prevedere forme di lavoro a tempo parziale; si dovranno ridurre i tempi di lavoro per facilitare l’alternanza di manodopera […] ciò vuol dire che il nuovo ordine economico per essere efficiente, dev’essere animato eticamente»,35
In conclusione, si sta inaugurando un periodo di rinnovamento delle condizioni oggettive di lavoro. Si apre la possibilità di abbandonare una visione antropocentrica dei beni della terra e riconoscerci quali amministratori in una visione dove i beni sono assoggettati alla duplice regola del possesso personale e insieme dell’uso comune36. In un mondo in cui il lavoro va quantitativamente diminuendo, bisogna progettare migliori forme di condivisioni della ricchezza e dei beni prodotti, e svincolare il benessere personale dal successo professionale o dal possesso di beni.
6. Una proposta per il futuro
Il futuro è un’epoca in cui lavoreremo sempre meno. Alcuni, come gli accelerazionisti37, desiderano favorire questo futuro ed accelerare il piano di transizione digitale per liberare l’uomo dalla necessità e dall’obbligatorietà del lavoro. Lavorare diventerebbe una scelta o una necessità minimale, come le 8 ore settimanali per la propria “sanità mentale”. Non siamo preparati culturalmente a questo passaggio. Abbiamo bisogno di imparare a non identificarci con o per il nostro lavoro ed iniziare a valutarci in base all’utilizzo del tempo libero.
In Europa sono in corso esperimenti sociali che voglio sperimentare proprio questi nuovi contesti. Uno dei primi fu effettuato in Finlandia a partire dal 2017. Duemila disoccupati tra i 25 e 58 anni hanno ricevuto per due anni un reddito garantito (circa il 50% di un affitto medio) indipendentemente se lavorassero o meno. A luglio 2021, il governo islandese ha reso noti i risultati di un test definito un «successo travolgente»: riduzione della settimana a 4 giorni lavorativi mantenendo gli stessi livelli di retribuzione e produttività. Unilever, colosso britannico dell’alimentazione, ha avviato a fine 2020 un esperimento in Nuova Zelanda: quattro giorni lavorativi alle stesse condizioni dei cinque precedenti. L’Accademia delle Belle Arti di Amburgo ha assegnato una borsa di studio a tre studenti per studiarne il comportamento nel periodo di inattività. Ad agosto 2020, la piattaforma Mein Grundeinkommen e l’Istituto per la Ricerca Economica Diw Berlin hanno avviato un esperimento con 122 persone che riceveranno un reddito di € 1.200 al mese per tre anni senza lavorare.
Cosa farà l’uomo senza il lavoro? Le arti liberali, le cui origini per alcuni risalgono ai tempi di Pitagora, Platone e Aristotele in Grecia, di Cicerone, Seneca e Quintiliano a Roma, erano attività peculiari degli uomini liberi, liberi dalla necessità (o schiavitù) del lavoro. Questi uomini si potevano dedicare alle arti, alle lettere, alla scienza, alla res pubblica: attività non certo noiose i cui prodotti sono ancora oggi oggetto di studio ed ammirazione. Lo stesso Vangelo ci invita a più riprese a valutare meglio e con saggezza il lavoro e quello che ne possiamo trarre: i gigli non filano e non mietono (Mt 6, 28; Lc 12, 27); l’instabilità delle ricchezze (1 Tim 6, 17); chiusura del cuore (1 Gv 3,17) e soprattutto l’inutilità dall’accumulo (Lc 12, 16-20).
La preoccupazione delle attuali politiche di ripresa non dovrebbe essere rivolta a come riorganizzare il lavoro, quanto a governare la rivoluzione culturale cui andiamo incontro. Dobbiamo liberarci dall’idea che la promozione del bene comune si possa realizzare solo attraverso politiche di incoraggiamento, sostegno o sviluppo del lavoro. Abbiamo necessità di misurare il benessere umano su metriche diverse dal PIL o dal reddito pro-capite e affidarci maggiormente a misurazioni come l’indice di Gini,
lo Human Development Index, l’Indice di Benessere Sostenibile, il Better Life Index e molti altri.
Liberati dalla necessità di lavorare per sopravvivere o per darci un’identità, avremmo eliminato numerose situazioni di conflitto. Con la pace e il tempo a disposizione, potremo conoscere e gestire meglio i nostri sentimenti, impegnarci con maggiore coscienza e responsabilità in progetti ed iniziative. Oggi il tempo libero è una risorsa rara. Diventa motivo di tristezza se non è possibile condividerlo con amici e familiari, se le agende non corrispondono e gli impegni della vita lo impediscono38. Se molta della felicità personale passa per la condivisione del tempo libero, non si può negare lo stato attuale di infelicità. Bisogna essere preparati alle relazioni personali. È il compito di questo tempo, insieme alla preparazione alla dismissione dal lavoro.
Siamo ad un crocevia della storia: il collasso del capitalismo maturo, l’ingresso in un’epoca storica (quella digitale) e la ripartenza post pandemia. Un’occasione unica e non ripetibile di correggere errori e riparare ingiustizie. Non si tratta di ritornare ad uno stato pre-pandemico basato su un sistema economico che ha prodotto morti, ingiustizie, povertà, inquinamento, egoismo, violenza. Non si tratta di trovare aggiustamenti o correzioni, come hanno provato a fare tutte le dottrine politiche dell’epoca industriale. Si tratta di entrare in un tempo nuovo e ricominciare dai rapporti sociali, dalle relazioni personali, dal riconoscere i legami che ci uniscono e ci spingono alla condivisione ed alla possibilità di vivere insieme nella pace. In questa ricostruzione, i cristiani sono portatori di un progetto sull’uomo che merita di essere ascoltato e portato al tavolo della discussione.
Edoardo Mattei
NOTE:
1 A Cohen, How to Quit Your Job in the Great Post-Pandemic Resignation Boom in Bloomberg BusinessWeek, 10 maggio 2021.
2 I. Cook, Who Is Driving the Great Resignation? in Harvard Business Review, 15 settembre 2021.
3 D. Thompson, The Great Resignation Is Accelerating in The Atlantic, 15 ottobre 2021.
4 K. Hymes, ‘The Great Resignation’ Misses the Point in Wired, 1° novembre 2021.
5 La Comunicazioni Obbligatorie, Nota relativa al II trimestre 2021 è stata pubblicata il 9 settembre 2021 ed è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro,
6 L’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (UnionCamere), in collaborazione con il Ministero del Lavoro, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e con l’Unione Europea, realizza, a partire dal 1997, insieme alle Camere di commercio, il “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” Excelsior, che ha l’obiettivo di monitorare le prospettive delle domande di lavoro e dei fabbisogni professionali, formativi e di competenze espressi dalle imprese.
7 J. Hauwiller, Gratitude May Be An Antidote To The Great Resignation in Forbes 10 novembre 2021.
8 J. Zenger, J.Folkman, Why Do So Many Managers Avoid Giving Praise? in Harvard Business Review, 2 maggio 2017.
9 M. Bentivogli, Il lavoro che ci salverà. Cura, innovazione e riscatto: una visione prospettica, San Paolo, 2021, pp 57-77.
10 M. Bentivogli, Le grandi dimissioni in La Repubblica,12 novembre 2021.
11 M. Bentivogli, Lavoro a umanità aumentata in La Repubblica, 23 novembre 2021.
12 ibidem.
13 ibidem.
14 K. Hymes, op. cit.
15 D. Thompson, Workism Is Making Americans Miserable in The Atlantic, 24 febbraio 2019.
16 Lo aveva già capito un secolo fa T. Veblen, Teoria della classe agiata. Studio economico sulle istituzioni, Einaudi, 2007
17 E. Chen, These Chinese Millennials Are ‘Chilling,’ and Beijing Isn’t Happy in New York Times, 3 luglio 2021.
18 Link del post originario: https://gnews.org
19 A. V. Whillans, E. W. Dunn, Valuing Time Over Money Predicts Happiness After a Major Life Transition: A Pre-Registered Longitudinal Study of Graduating Students, Harvard Business School, Working Paper 19-048, 2018
20 D. Kamerāde et all, A shorter working week for everyone: How much paid work is needed for mental health and well-being? Social Science & Medicine, Volume 241, 2019, 112353, ISSN 0277-9536, https://doi.org
21 L. Floridi, F. Cabitza, Intelligenza Artificiale. Uso delle nuove macchine, Bompiani, 2021, pp. 139-162
22 M. Bentivogli, Lavoro a umanità aumentata, op. cit.
23 Un articolo molto istruttivo al riguardo: J. Dsouza, The Truth About Data Science —Why It Isn’t As Rosy as You Might Imagine (https://bit.ly/3EpMcWG)
24 Trickle down, letteralmente “gocciolamento verso il basso”, è una locuzione che identifica le teorie economiche e politiche per cui ogni misura in favore delle classi abbienti stimolerà positivamente l’economia producendo degli effetti positivi che andranno a ricadere anche sulle classi meno abbienti. Tipicamente si afferma che i tagli alle tasse permettono di liberare del capitale per investimenti che potranno dare più lavoro e quindi diminuire la disoccupazione.
25 N. Srnicek, A. Williams, Inventare il futuro. Per un mondo senza lavoro, Nero, 2018, pp 92-93.
26 E. Brynjolfsson, A. McAfee, La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell'era della tecnologia trionfante, Feltrinelli, 2017, pag 178.
27 D. De Masi, Lavorare gratis, lavorare tutti, Rizzoli, 2017; Il lavoro nel XXI secolo, Einaudi, 2018
28 R. Ciccarelli, Forza lavoro. Il lato oscuro della rivoluzione digitale, DeriveApprodi, 2018.
29 J.Bivens, L. Mishel, Understanding the Historic Divergence Between Productivity and a Typical Worker’s Pay, EPI briefing paper #486, Figure A. http://tiny.cc/7xppaz.
30 A.Williams, N. Srnicek, Manifesto Accelerazionista, G. Laterza & Figli, 2018, nr. 5.
31 I working poors, secondo la definizione Eurostat, sono individui che, nonostante svolgano un’attività lavorativa ed abbiano lavorato per almeno sei mesi nell’anno preso in esame, hanno percepito una qualche forma di reddito da lavoro inferiore al 40, 50 o 60% del reddito mediano, inteso come il reddito che divide la metà inferiore dalla metà superiore della scala dei redditi nazionali. Si considerano quindi sia individui con un reddito da lavoro inferiore alla soglia di povertà, sia persone il cui reddito è più basso se calcolato come reddito familiare disponibile equivalente, rispetto ai carichi familiari.
32 L.Ginzberg, Le leggende degli ebrei, Adelphi, 1995, Vol. I, p. 88
33 Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 27
34 Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 6
35 B. Sorge, Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, Queriniana, 2001, p.204
36 Una visione lucida ed attuale, è stata esposta da Tommaso d’Aquino, S. Th. II-II, q.66 a.1-2
37 Si vedano i già citati A. Williams, N. Srnicek, Manifesto accelerazionista, Laterza, 2018; N. Srnicek, A. Williams, Inventare il futuro. Per un mondo senza lavoro, Nero, 2018
38 Rimando al mio articolo Calendario come organizzazione sociale in Gruppo Domenico 800 (GD800), 2 agosto 2020 (https://www.gd800.it)
 IT
IT  EN
EN