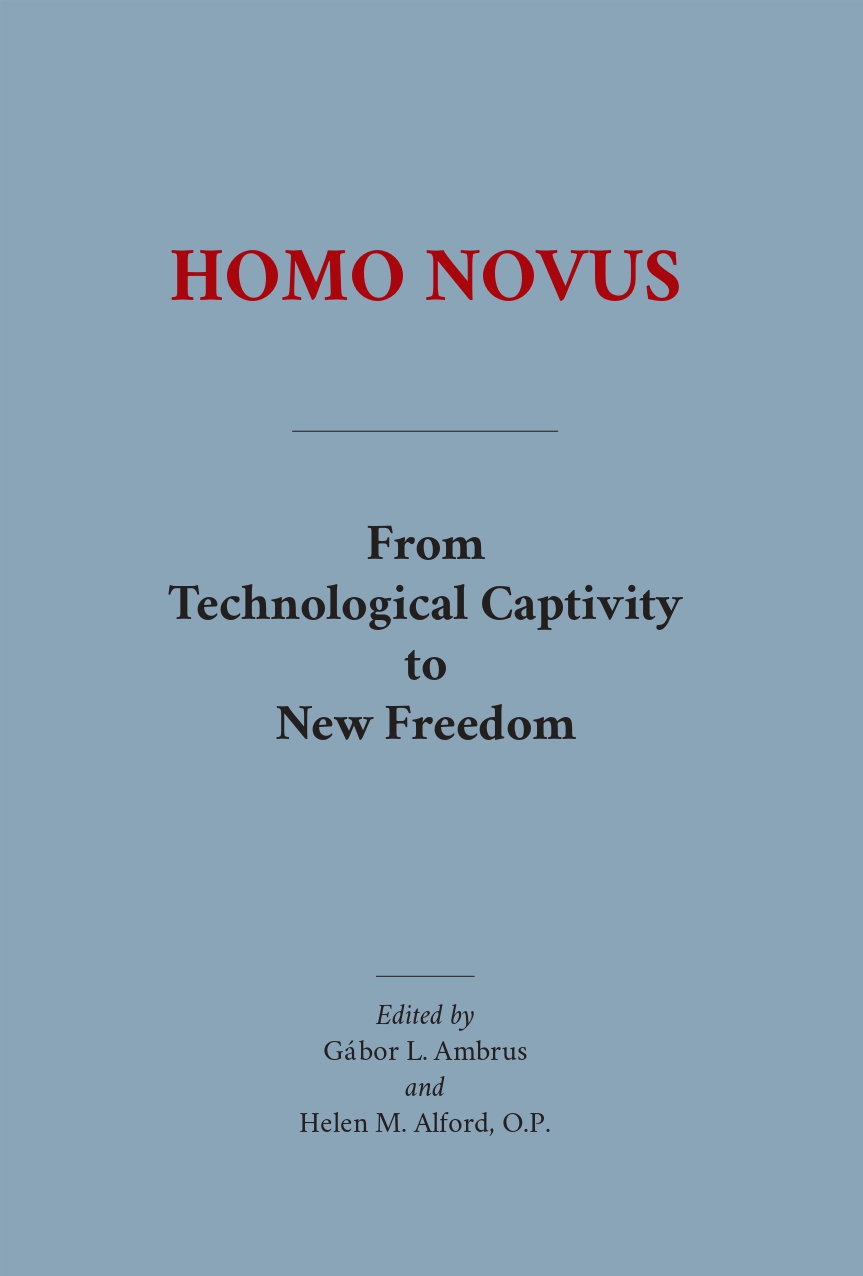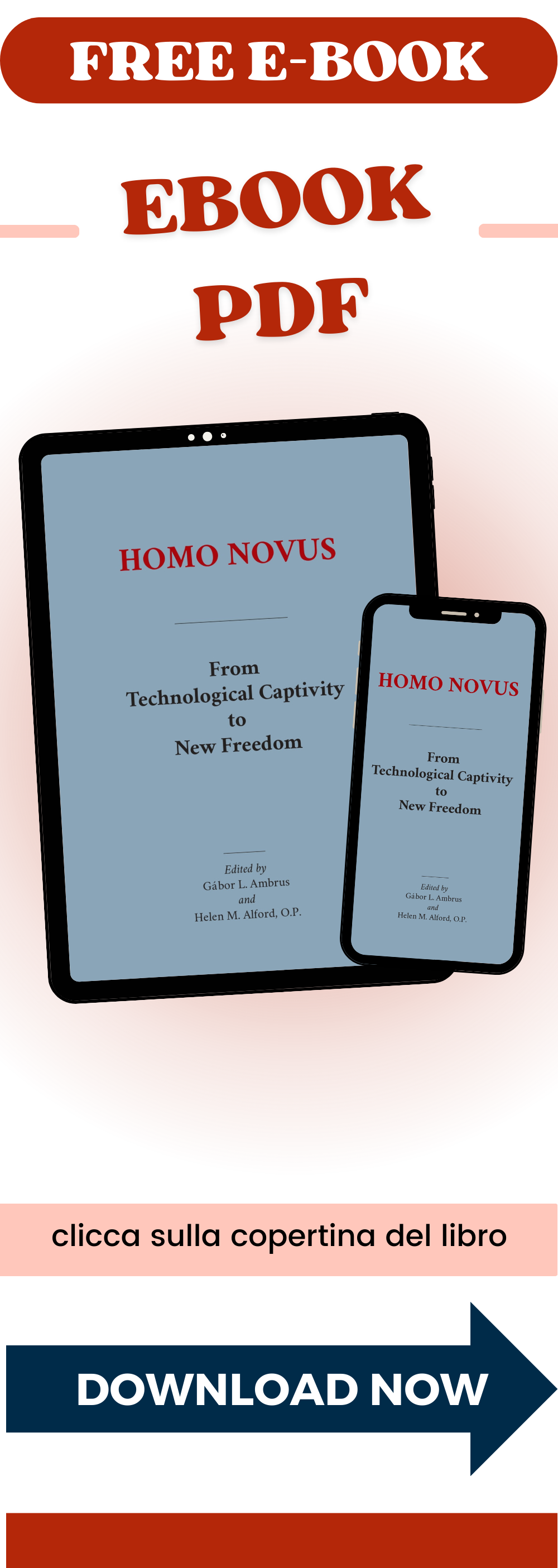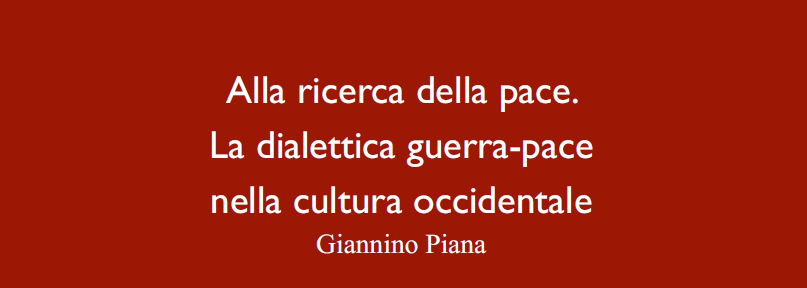
![]() La questione della guerra e della pace è antica quanto la storia dell’umanità. In tutte le culture, a partire da quelle più lontane nel tempo, gli interrogativi circa la legittimità (o meno) della guerra e circa le vie da percorrere per costruire la pace hanno occupato un ruolo centrale nella riflessione antropologica ed etica. Etnologia e antropologia culturale hanno messo in evidenza come tale questione, pur con differenze anche consistenti nell’approccio e nella ricerca di soluzioni, ha sviluppi assai ampi nelle varie comunità: dalle aggregazioni tribali alle unità nazionali fino al costituirsi degli Stati1.
La questione della guerra e della pace è antica quanto la storia dell’umanità. In tutte le culture, a partire da quelle più lontane nel tempo, gli interrogativi circa la legittimità (o meno) della guerra e circa le vie da percorrere per costruire la pace hanno occupato un ruolo centrale nella riflessione antropologica ed etica. Etnologia e antropologia culturale hanno messo in evidenza come tale questione, pur con differenze anche consistenti nell’approccio e nella ricerca di soluzioni, ha sviluppi assai ampi nelle varie comunità: dalle aggregazioni tribali alle unità nazionali fino al costituirsi degli Stati1.
Le riflessioni qui proposte si limitano a ricostruire l’itinerario percorso dalla cultura occidentale a partire dagli inizi della sua storia fino ad oggi. Si partirà dunque da una rapida messa a fuoco delle posizioni delle due grandi matrici che hanno contrassegnato fin dalle origini la cultura dell’Occidente (tradizione greco-latina ed ebraico cristiana) (I) per fermare in seguito l’attenzione sulla dottrina patristica e medioevale (II); e mettere poi in luce l’evoluzione che il tema ha assunto nella modernità (III); e, infine, concludere con un’ampia riflessione sulle forme che devono caratterizzare oggi l’impegno per la costruzione della pace (IV).
I. Alle origini della cultura dell’Occidente
Tanto la tradizione classica greco-romana quanto quella ebraica riconoscono la legittimità della guerra e sviluppano tuttavia, sia pure in modi diversi, proposte e prospettive di costruzione della pace. Il mondo greco e poi quello romano sono stati attraversati da pesanti (e ripetuti) conflitti, al punto che il termine “pace” è proposto prevalentemente in un’accezione di segno negativo come semplice “assenza di guerra” e che la pax romana è concepita come la cessazione temporanea della guerra, una sorta di armistizio dopo la vittoria conseguita attraverso un’azione militare con l’imposizione del proprio ordine a un popolo conquistato mediante le armi.
La tradizione ebraica, in sintonia con i modelli culturali del tempo dà senza esitazione (sia pure con varianti dovute alle diverse epoche storiche in cui i vari testi biblici si collocano) il proprio consenso a guerre motivate da ragioni politiche e religiose che la giustificano: la “guerra di religione” risulta teorizzata come una forma di reazione nei confronti di chi mette gravemente a repentaglio la fede di Israele nel Dio unico, Jahvè. La shalom biblica si discosta tuttavia dalla eirene greca e pax romana per la presenza di un concetto di “pace” più positivo: il quale coincide con uno stato di integrità e di benessere, frutto del verificarsi di una situazione di giustizia, la quale avrà piena attuazione nei tempi messianici.
Non mancano, d’altra parte – come si è accennato – nell’una e nell’altra area culturale segnali importanti della volontà di costruire la pace. Lo sviluppo della virtù della “giustizia sociale” nell’ambito della filosofia greca – è sufficiente ricordare qui l’importante contributo di Aristotele – e l’elaborazione del concetto di polis, in ambedue i casi con il tentativo di tradurli in esperienze concrete, pur con i limiti dovuti al contesto del tempo, forniscono elementi preziosi che non possono essere trascurati. A, sua volta, l’introduzione nel mondo latino della categoria di “diritto” impedisce, da un lato, che l’agire umano si abbandoni a una logica del tutto libertaria (e arbitraria) e concorre, dall’altro, a fissarne i limiti in vista della realizzazione di relazioni positive con gli altri. Giustizia sociale, democrazia e diritti sono altrettanti fattori che contribuiscono alla crescita di una convivenza civile ordinata ed armonica, che è la base della costruzione della pace.
Il mondo ebraico persegue con rigore questo stesso indirizzo. È vero – come si è ricordato e come viene messo soprattutto in luce dalla letteratura profetica (in particolare quella del periodo dell’esilio) – che la piena realizzazione della pace è demandata ai “tempi messianici”, ma questo non impedisce che il suo perseguimento si verifichi fin da quaggiù, in primo luogo con la promozione della giustizia e del diritto soprattutto a favore dei più deboli – significativa è, al riguardo, l’introduzione e la pratica dell’anno giubilare in cui si assiste alla redistribuzione dei beni tra tutti i membri della comunità – ; ma poi anche con una serie di indicazioni preziose offerte dai libri sapienziali per vincere la conflittualità, tanto nei rapporti interpersonali che in quelli sociali, e favorire l’edificazione di una comunione, che ha come presupposti il dialogo e l’aiuto vicendevole, l’esercizio della misericordia e del perdono.
II. Dalla patristica alla Scolastica
Una vera e propria svolta si produce con l’avvento del cristianesimo e la sua prima diffusione nell’area del Mediterraneo. Il Nuovo Testamento sottolinea l’esigenza della costruzione della pace come uno dei compiti fondamentali dell’impegno cristiano.
Accanto alla “beatitudine” presente nel Discorso della montagna: “Beati gli operatori (i facitori) di pace perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5, 9) – il titolo più alto assegnato a tutti i “beati” – numerosi sono gli interventi che confermano questo messaggio affermatosi con forza nei primi secoli del cristianesimo. La radicalità della proposta evangelica ha spinto infatti la primitiva comunità cristiana a fare proprio l’ideale pacifista, fino a darne testimonianza mediante la scelta (in realtà motivata anche da ragioni religiose: il rifiuto del culto all’imperatore del tempo) dell’obiezione di coscienza.
A mettere in discussione questa posizione è stato Agostino di Ippona, che ha introdotto per primo nella riflessione etico-teologica il concetto di “guerra giusta”2. Egli, pur riconoscendo che la promozione della pace (tranquillitas ordinis) costituisce il compito più importante della comunità politica, non esita a riconoscere in alcuni casi l’ineluttabilità della guerra, mettendo in evidenza le condizioni che la giustificano. A determinare questo suo “sì” è, da un lato, il pessimismo antropologico che non lo ha mai del tutto abbandonato – si pensi alla differenza sostanziale (e persino all’opposizione) che egli istituisce tra la “città dell’uomo” e la “città di Dio” – e, dall’altro, il cambiamento intervenuto nell’ambito della politica imperiale romana con l’ammissione del “diritto di cittadinanza” della Chiesa e i relativi obblighi che ne derivano. Ma la ragione di fondo (o, se si vuole, l’argomentazione in base alla quale egli perviene a questa conclusione) e che giustifica anche la partecipazione dei cristiani alla guerra, è l’interpretazione che egli fornisce del Discorso della montagna, ridotto a criterio ispiratore dei sentimenti interiori e delle opzioni private, dunque non applicabile alle opzioni pubbliche.
Agostino non si limita tuttavia a questo. L’introduzione del concetto di “guerra giusta” lo obbliga a precisarne le cause e a istituire i criteri sulla base dei quali formulare il giudizio circa la sua plausibilità. Egli è convinto infatti che non ogni tipo di guerra possa godere di legittimità, e che occorra allora stabilire dei limiti precisi al suo esercizio. Prende corpo, in questo contesto, il cosiddetto ius ad bellum, che riguarda le condizioni per le quali è possibile dichiararla ed entrarvi; condizioni che vengono fissate nella “giusta causa”, nella “retta intenzione” e nella dichiarazione da parte della “autorità legittima”. Come risulta fin dall’inizio – è bene sottolinearlo – il concetto di “guerra giusta” non ha come obiettivo quello di avvallare tout court la guerra (ogni tipo di guerra), ma quello di restringere il campo del suo esercizio a situazioni limitate e ben circoscritte3.
La Scolastica medioevale riprende questo concetto. Tommaso d’Aquino, pur considerando la pace un bene da perseguire con tutte le proprie energie, riconosce l’esistenza di situazioni nelle quali, a causa delle gravi violazioni dei diritti di un popolo, la guerra diviene legittima. Egli aggiunge poi alle condizioni poste da Agostino due altre, che introducono, accanto allo ius ad bellum, lo ius in bello. Si tratta della extrema ratio, del fatto cioè che siano stati esperiti tutti i tentativi di trovare, attraverso il dialogo tra le forze in campo, un accordo per via diplomatica; e del debitus modus, cioè della limitazione dell’intervento all’uso di mezzi legittimi e della protezione dei civili4.
III. Gli sviluppi nella modernità
La piena formulazione della dottrina della “guerra giusta” si ha in epoca moderna. A provocarne gli sviluppi ha concorso tanto la nascita degli Stati nazionali (a regime assolutistico), che avocano a sé il monopolio della forza, quanto il ricupero del diritto alla legittima difesa, trasposto dal piano individuale a quello sociale, estendendo la possibilità di intervento anche in ragione della progressiva restrizione delle condizioni ricordate soprattutto (e talora in modo esclusivo) alla “autorità legittima”, essendo divenuto il “principio di autorità” il perno fondamentale dell’intera azione politica.5
La guerra, sia difensiva che offensiva, viene così giustificata come la via normale di regolamentazione e di soluzione dei conflitti; essa è anzi persino ritenuta – è questa la tesi di Carl von Clausewitz6 – “la continuazione della politica con altri mezzi”. Si assiste in tal modo alla “politicizzazione” della guerra – Carl Schmitt afferma che la politica si fonda sul concetto di “nemico”7 – con forme di militarismo radicale, che, oltre alle guerre coloniali, cui non manca di dare il proprio contributo anche il giovane Regno d’Italia, sfociano nella Prima e nella Seconda guerra mondiale. L’enorme quantità di morti, che hanno contrassegnato l’una e l’altra delle due tragiche esperienze, non ferma del tutto il flusso della violenza e della sua legittimazione ancorata a rigidi presupposti ideologici.
Non sono mancate in questo periodo, in concomitanza con queste prese di posizione talvolta persino deliranti, testimonianze di pensiero e di azione, che si muovevano controcorrente. È sufficiente ricordare qui il pacifismo di Lev Tolstoj8, che si ispira peraltro alla radicalità evangelica o, per rimanere in Italia le battaglie condotte da Capitini9; ma su tutte spicca l’esperienza (unica) del Mahatma Gandhi, promotore a livello politico delle pratiche di difesa nonviolenta in più occasioni da lui sperimentate con successo10. A provocare un atteggiamento diffuso di diffidenza nei confronti della guerra concorre in seguito soprattutto la disponibilità di un potenziale di enorme portata distruttiva: dalle armi chimico-batteriologiche all’atomica. Si fa così strada un profondo mutamento nella percezione del significato della guerra, destinata a rendere possibile la distruzione dell’intera umanità.
Si inserisce in questo contesto la promulgazione della Pacem in terris di Giovanni XXIII (1963), che rifiuta il concetto di “guerra giusta”, giungendo ad affermare che è “del tutto irragionevole (alienum a ratione) pensare che nell’era dell’atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia” (n. 67). Le ragioni addotte dal pontefice non sono soltanto di ordine sociopolitico; egli non manca di fare appello alla beatitudine evangelica, quella dei “facitori di pace”, e a inserire la propria proposta in un contesto culturale caratterizzato da profondi cambiamenti che coinvolgono gli individui e i popoli e reclamano la creazione di nuove prospettive di giustizia e il riconoscimento di nuovi diritti. In linea di massima (e con apporti diversi legati anche ai rapidi cambiamenti intervenuti nel frattempo nella situazione mondiale) è questa la dottrina che è prevalsa (e prevale) nel magistero successivo della Chiesa, fino alle ultime prese di posizione di papa Francesco che, a proposito del conflitto Russia-Ucraina in corso, non ha esitato a parlare di follia11.
IV. L’impegno per la costruzione della pace
L’impegno per la costruzione della pace comporta, in negativo, alcuni interventi, che vanno messi in atto (anche con l’uso delle armi) in situazioni cruciali, per evitare mali maggiori; e, in positivo, una serie di azioni che creano le condizioni per prevenire le conflittualità che possono condurre alla guerra o per affrontarle, se già sussistono, con mezzi pacifici. A questi due versanti si riferiscono queste ultime note, che non hanno alcuna pretesa di esaustività, ma intendono semplicemente fornire orientamenti e indirizzi, che meritano di essere presi in seria considerazione.
1. L’ingerenza umanitaria e l’intervento di polizia internazionale
La gravità di alcune situazioni in cui si sono consumate atrocità inaudite, con violenze, stupri e veri e propri genocidi – determinante è stato quanto si è verificato nei Balcani – ha provocato l’esigenza di intervenire, anche con le armi, per arrestare, fin dove possibile, assurde forme di barbarie. È nata per questo la dottrina della “ingerenza umanitaria” e delle “operazioni di “polizia internazionale”. L’obiettivo è qui quello di dare soccorso alle vittime dell’aggressione mediante il coinvolgimento della comunità internazionale. Si tratta di istituti che si differenziano radicalmente dalla guerra, sia per il fine perseguito – fermare e quanto meno contenere un processo di grave violenza –, sia per le modalità di esecuzione, caratterizzate da un intervento chiaramente circoscritto e destinato esclusivamente a prestare aiuto alle vittime e a disarmare l’aggressore.
La legittimità di queste azioni è strettamente dipendente dal verificarsi di alcune condizioni, quali l’imparzialità, la volontà di promuovere una vera de-escalation della violenza e la prudenza nell’uso delle armi. Per questo la loro plausibilità è tale solo in presenza di situazioni estreme, nelle quali l’uso coercitivo della forza è reso necessario tanto dal fallimento della trattativa politica quanto dalla considerazione che gli effetti negativi del mancato intervento risulterebbero più gravi di quelli prodotti dall’intervento stesso. O ancora: per questo è necessario quale garanzia di imparzialità il controllo delle grandi organizzazioni internazionali in grado di valutare, al di là e al di fuori di interessi particolaristici, l’opportunità (e persino la necessità) di intervenire12.
2. Le “buone pratiche” da promuovere13
Ma, accanto al rifiuto della guerra in tutte le sue forme, la pace ha bisogno per affermarsi della promozione di iniziative, che contribuiscano alla costruzione di una coscienza pacifica e che favoriscano forme di dialogo e di confronto diplomatico. Ciò a cui si deve mirare è, in questo caso, la diffusione di una “cultura di pace”, uscendo da uno sterile utopismo e lottando perché si producano i cambiamenti necessari a rendere sempre più plausibile a tutti i livelli il progetto pacifista. Tre sembrano essere, a tale proposito, gli ambiti da privilegiare: la costruzione di un sistema basato sulla giustizia e sui diritti, l’adozione della nonviolenza come forma attiva di soluzione dei conflitti e, infine, l’esercizio del diritto di resistenza, della disobbedienza civile e dell’obiezione di coscienza.
Il primo ambito – quello della giustizia e dei diritti umani – non può non fare i conti con la crescita esponenziale delle diseguaglianze non solo tra i popoli – basti qui ricordare il divario tra Nord e Sud del mondo – ma anche tra le classi sociali con un forte incremento delle povertà anche nei Paesi cosiddetti sviluppati. Le aspre tensioni rinfocolate da motivazioni vere (o presunte) di carattere ideologico o religioso sono, in larga misura, dovute a ragioni economiche; sono espressione cioè di una reazione violenta alla violenza istituzionale di un ordine (o disordine) mondiale, che mantiene in uno stato di minorità un’ampia area della famiglia umana.
L’incapacità di dare vita a un sistema basato sulla giustizia distributiva e sull’equità è la causa principale di situazioni socialmente conflittuali che sfociano nelle guerre (numerose) che devastano oggi il nostro pianeta. Non vi è pace senza giustizia o – come ricordava Paolo VI nell’enciclica Populorum progressio – la giustizia è il vero nome della pace. Il capitalismo totalitario, tuttora egemone, va dunque superato mediante la edificazione di un ordine nuovo, che abbatta le strutture ingiuste (le quali sono in sé stesse violente e generatrici di violenza) e risponda in maniera adeguata alle esigenze fondamentali dell’intera comunità a partire da quelle dei più poveri. A dover essere riconosciuti e salvaguardati sono i diritti della persona (di ogni persona), non dimenticando che, in un’epoca di globalizzazione come l’attuale, questo può avvenire soltanto allargando la sfera di azione alla comunità mondiale.
Il secondo ambito – quello della nonviolenza come forma attiva di soluzione dei conflitti – impone l’adesione a un modello nonviolento, non come scelta tattica e contingente, ma come opzione di principio. Le difficoltà a mettere in atto questa scelta si sono oggi moltiplicate. Non solo per l’accentuarsi dei conflitti e il loro radicalizzarsi, ma anche per l’avanzare di una mentalità giustificazionista che, in nome del realismo politico, rifiuta di prendere in considerazione ogni tentativo di affrontare le situazioni conflittuali senza ricorrere alla violenza. Questo significa che è anzitutto necessario riscoprire le radici antropologiche della nonviolenza che vanno ricercate nel rifiuto a considerare l’altro come “nemico”, riducendolo a semplice “oggetto” e negandogli ogni dignità personale14.
La pace esige dunque il superamento della distanza dall’altro e la positiva elaborazione dei conflitti originati dalle “differenze”. La persistenza nell’uomo di profonde ambivalenze, che hanno la loro sede nell’io profondo, esige il ricorso a un’educazione positiva della coscienza volta a interiorizzare valori quali la fiducia nell’altro, il dialogo, la tolleranza, la mitezza, l’abnegazione, la pazienza, il coraggio, e ad accettare i propri limiti e la propria fallibilità15. Ma questo non basta. È necessario inserire tutto questo in un progetto di etica della nonviolenza (non come etica della violenza legittima e della guerra giusta), e predisporre gli strumenti per una soluzione pacifica dei conflitti quali la via diplomatica, il rafforzamento di istituzioni internazionali che promuovano lo sviluppo del sistema democratico, non solo in senso formale, ma nella direzione socioeconomica e politica.
Il terzo ambito, infine – quello del diritto di resistenza, della disobbedienza civile e dell’obiezione di coscienza – esige che si faccia spazio ad alcune forme di radicale testimonianza della nonviolenza, che conferiscano al pacifismo un carattere pratico e attivo da vivere dentro la storia. In questo modo è possibile mettere in campo azioni pubbliche che diano concretamente corso a una forma di nonviolenza con effetti immediati sul cambiamento sociale. Tra queste azioni meritano di essere ricordate le pratiche di difesa non violenta (purtroppo ancora poco conosciute e praticate), il diritto di resistenza e la disobbedienza civile, che comportano una vera e propria violazione della legge; violazione tesa a sollecitarne il cambiamento, e infine (ma non in ordine di importanza), l’obiezione di coscienza.
Una proposta da discutere
Una breve postilla per avanzare una proposta. Una delle questioni fondamentali – forse la più importante – che riguardano l’impegno per la costruzione della pace è l’acquisizione delle strategie e delle tecniche di difesa nonviolenta e la possibilità di una loro concreta messa in atto. È evidente che il primo soggetto di tale operazione è l’intera popolazione che va sensibilizzata per farle acquisire una mentalità fondata sui valori ricordati. Ma, al di là di questa diffusa azione formativa, che reclama il coinvolgimento delle diverse agenzie educative, c’è bisogno di una forza che abbia la capacità di rendere operativa, almeno in alcuni casi, tale pratica. Mi chiedo se essa non possa essere proprio l’esercito. So che può sembrare un paradosso. In realtà, oltre all’irrinunciabile preparazione militare, ci si può chiedere se esso non possa coltivare, in parallelo, un’apposita preparazione alla difesa nonviolenta. Si è ripetuta, in questi ultimi decenni, una serie di efficaci interventi di militari, che hanno prestato un importante servizio civile, soprattutto in situazioni di emergenza, ultima la pandemia (come non ricordare il prezioso contributo del generale Figliuolo?), manifestando la capacità di affrontare con intelligenza e competenza eventi particolarmente delicati e difficili. Non potrebbe essere questa un’occasione per fruire, da un lato, di una forza che fornisce garanzie di possibilità effettive di riuscita dell’impresa, e per contribuire, dall’altro, a fare di tale forza un’istituzione aperta a una molteplicità e varietà di funzioni, uscendo da una rigida forma di esclusivo militarismo?
Giannino Piana
NOTE:
1 Cfr. Aa. Vv., Grammatiche della violenza. Esplorazioni etnografiche tra guerra e pace, a cura di F. Dei – C. Di Pasquale, Pacini editore, Pisa 2013.
2 Una ricostruzione sintetica ma efficace ed esaustiva delle posizioni della tradizione cristiana sul tema della “guerra giusta” si trova in: L. SOWLE CAHILL, La tradizione cristiana della guerra giusta: tensioni e sviluppi, in: “Concilium”, 2 (2001), pp. 94-106.
3 Cfr. AGOSTINO, De civitate Dei, IV, 6, 15.
4 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-IIae, q. 40, art. 1.
5 Sullo ius belli una trattazione completa dalle origini della dottrina ad oggi si trova in: L. LABANCA, Lo ius belli: dal Decretum di Graziano al diritto internazionale. Ricognizione e analisi delle fonti canoniche e internazionali, EDUCatt., Milano 2019.
6 Cfr. C. von CLAUSEWITZ, Della guerra, Mondadori, Milano 2017.
7 Cfr. C. SCHMITT, La guerra di aggressione come crimine internazionale, a cura di C. Galli, Il Mulino, Bologna 2015.
8 Cfr. L. TOLSTOJ, Guerra e pace, a cura di J. Sibaldi, Mondadori, Milano 2012. Importante per un approfondimento della dottrina pacifista è: P. C. BORI – G. SOFRI, Gandhi e Tolstoj. Un carteggio e dintorni, Il Mulino, Bologna 1985.
9 Aldo Capitini è stato uno dei primi in Italia a cogliere e teorizzare il pensiero nonviolento gandhiano, al punto di essere chiamato il Gandhi italiano. A lui è dovuta il 24 settembre 1961 l’organizzazione della prima Marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli per le strade che da Perugia conducono ad Assisi; marcia che è tuttora annualmente attuata. Tra le sue numerose opere, ricordiamo qui, per un approccio globale al suo pensiero sulla non violenza: A. CAPITINI, Le ragioni della non violenza. Antologia degli scritti, a cura di M. Martini, ETS, Pisa 2016.
10 Cfr. MAHATMA GANDHI, Antiche come le montagne, ed. Comunità, Milano 1963.
11 Cfr. A. GIANELLI – A. TORNIELLI, Papi e guerra. Il ruolo dei Pontefici dal primo conflitto mondiale all’attacco in Iraq, Il Nuovo Giornale, Milano 2003.
12 L’opera più completa a tale riguardo è il testo di P. L. CONSORTI, L’avventura senza ritorno. Pace e guerra fra diritto internazionale e magistero pontificio, Feltrinelli, Milano 2004. Cfr. anche G. MATTAI – B. MARRA, Dalla guerra all’ingerenza umanitaria, SEI, Torino 1994.
13 Per una riflessione globale sulla pace, sulle possibili strategie e sugli strumenti operativi per attuarla, cfr. l’importante contributo di W. HUBER – H. R. REUTER, Etica della pace, Queriniana, Brescia 1993.
14 Su aspetti particolari di esercizio concreto della non violenza, cfr. G. SALIO, Il potere della non violenza. Dal crollo del muro di Berlino al nuovo ordine mondiale, EGA-Edizioni Gruppo Abele, Torino 1995; J. M. MULLER, Il Vangelo della nonviolenza, Editrice Lanterna, Genova 1977; Aa. Vv., Riflessioni bibliche sulla pace, AVE, Roma 1987; Aa. Vv., Al di là del “non uccidere”, edizioni Servitium, Sotto il Monte (BG) 1989.
 IT
IT  EN
EN