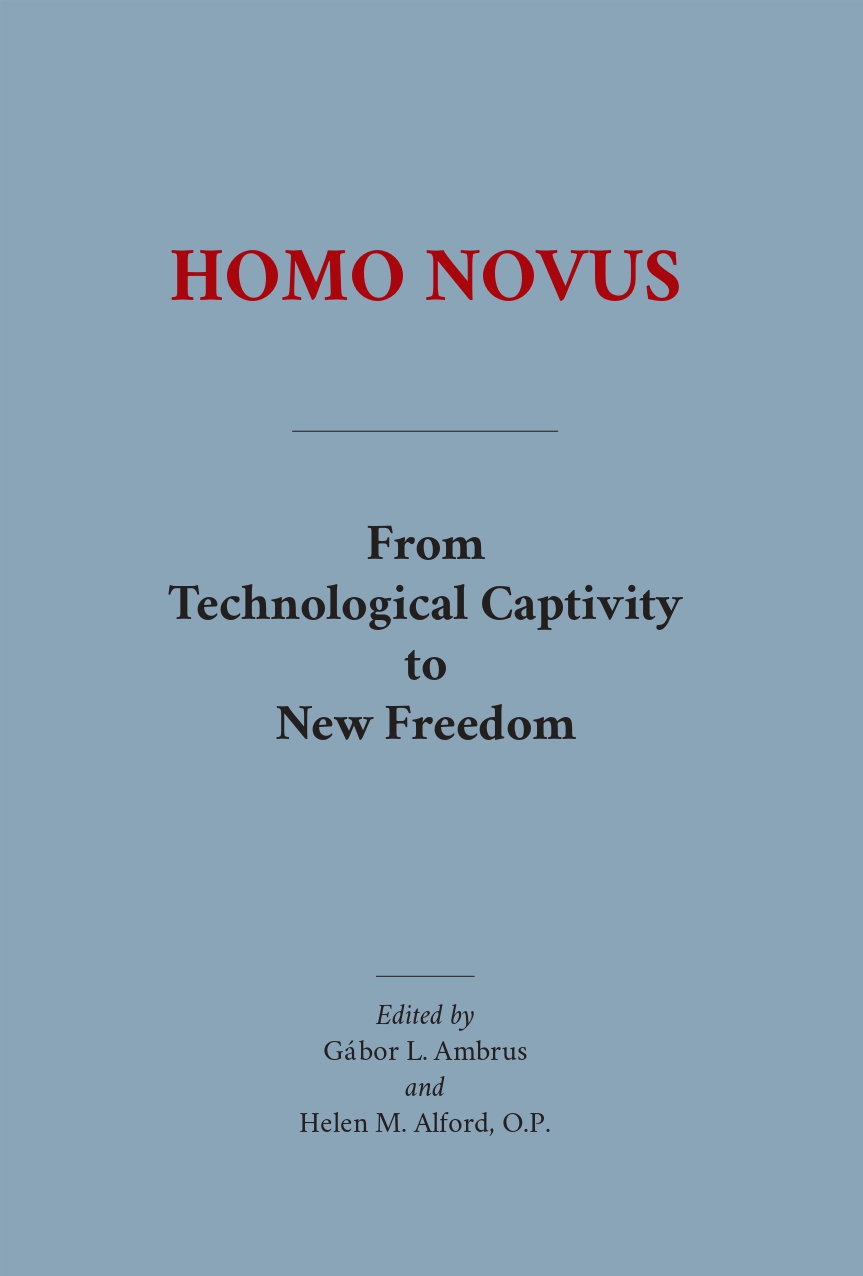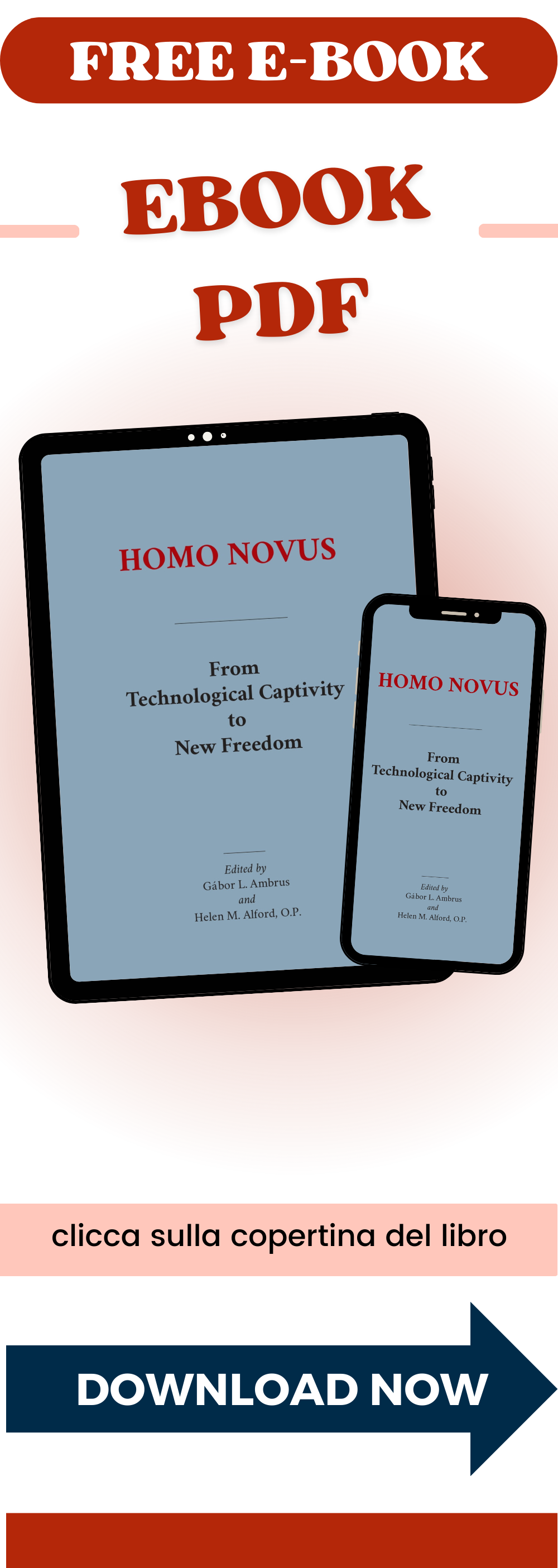![]() Il rapporto tra violenza e religioni è assolutamente centrale al cuore dell’interpretazione dell’evoluzione delle società nell’epoca post-moderna e occupa da anni non solo la riflessione teologica ma anche quella filosofica e sociologica. All’origine della questione c’è un paradosso: che si parli di religioni, di filosofie o di sistemi di potere, il vero problema scaturisce dalla convinzione di essere portatori di pace e di bene e che il male, o Satana in persona, appartenga esclusivamente agli altri. Quando si è convinti di incarnare “il bene”, ci si sente autorizzati ad ostacolare e combattere con qualunque mezzo tutto quello che si ritiene sia contrario ai propri principi. In particolare, ogni religione ritiene di avere l’esclusiva della fratellanza e della pace, ma la storia insegna che proprio in nome della religione gli uomini si sono scannati gli uni gli altri, uccidendo e massacrando per la difesa dei diritti del loro Dio o pensando di rendergli così l’omaggio di una fedeltà indefettibile. Naturalmente le motivazioni, per la guerra e per ogni violenza, sono sempre oscene e menzognere, ma rivestite di nobili intenti. «C’è una sorta di totalitarismo messianico che accomuna queste visioni: il tentativo estremo di rendere a Dio e alla religione i loro diritti in un mondo che li ignora e che, così facendo, a detta dei credenti, ha firmato la sua condanna. Bisognerebbe riflettere attentamente sulle ragioni storiche, sociali e teologiche di una tale visione, e approfondire il rapporto tra le religioni e la violenza o il perché le religioni sembrino legittimare le categorie mentali della guerra pur esortando o invocando più spesso la pace»1.
Il rapporto tra violenza e religioni è assolutamente centrale al cuore dell’interpretazione dell’evoluzione delle società nell’epoca post-moderna e occupa da anni non solo la riflessione teologica ma anche quella filosofica e sociologica. All’origine della questione c’è un paradosso: che si parli di religioni, di filosofie o di sistemi di potere, il vero problema scaturisce dalla convinzione di essere portatori di pace e di bene e che il male, o Satana in persona, appartenga esclusivamente agli altri. Quando si è convinti di incarnare “il bene”, ci si sente autorizzati ad ostacolare e combattere con qualunque mezzo tutto quello che si ritiene sia contrario ai propri principi. In particolare, ogni religione ritiene di avere l’esclusiva della fratellanza e della pace, ma la storia insegna che proprio in nome della religione gli uomini si sono scannati gli uni gli altri, uccidendo e massacrando per la difesa dei diritti del loro Dio o pensando di rendergli così l’omaggio di una fedeltà indefettibile. Naturalmente le motivazioni, per la guerra e per ogni violenza, sono sempre oscene e menzognere, ma rivestite di nobili intenti. «C’è una sorta di totalitarismo messianico che accomuna queste visioni: il tentativo estremo di rendere a Dio e alla religione i loro diritti in un mondo che li ignora e che, così facendo, a detta dei credenti, ha firmato la sua condanna. Bisognerebbe riflettere attentamente sulle ragioni storiche, sociali e teologiche di una tale visione, e approfondire il rapporto tra le religioni e la violenza o il perché le religioni sembrino legittimare le categorie mentali della guerra pur esortando o invocando più spesso la pace»1.
Tuttavia, è difficilmente contestabile il fatto che la violenza sia una costante antropologica prima ancora che religiosa e che, anche per questo motivo, le radici della violenza si trovano fin nel cuore delle religioni rendendole di per ciò stesso veicolo di violenza. Come negare il fatto che in ogni parte del mondo si registra un aumento di conflitti etnici, nazionali e sociali, dove la religione è direttamente sorgente di violenza? È proprio partendo da questa constatazione che René Girard, riflettendo sulla violenza fondatrice, analizza la dimensione sacrificale, propria delle religioni, come modo di uscire dalla spirale della violenza reale rimpiazzandola con una violenza simbolica (benché si debba ammettere che la struttura del sacrificio nel suo attuarsi include la violenza, non la esclude). Queste considerazioni molto generali sarebbero però insufficienti se non rilevassimo anche l’esistenza di un movimento di profonda critica teoretica alla violenza interna ad ogni tradizione religiosa, evidenziata e storicamente manifestata dall’azione di individui e di gruppi che rifiutano concretamente la violenza, pagano spesso di persona questo rifiuto e, tuttavia, continuano ad operare nella ricerca di vie di riconciliazione. Questo anche nella consapevolezza che la violenza primaria non è interessata all’aspetto religioso ma all’appoggio ideologico che può ricevere dalla religione.
Questa premessa ci pare offrire importanti chiavi di interpretazione dell’odierno contesto islamico. Esiste una letteratura ormai sterminata sul legame tra “Islam e Violenza” ed è innegabile, che una parte non indifferente di questa letteratura si componga di pamphlet islamofobi, molto utilizzati dalla politica urlata e polarizzante degli ultimi decenni, che poco contribuiscono ad una seria ed obiettiva ricerca sulla questione.
Che cosa rispondere a coloro secondo i quali l’Islam, essendo religione che rivendica l’universalità, che impone ai suoi seguaci “la lotta (jihâd) sulla via di Dio (fi sabîl allah)” con tutti i mezzi finché il suo messaggio non regni sovrano su tutta l’estensione dell’umanità, concludono che la violenza è una caratteristica ad esso consustanziale?
Sicuramente, la violenza è un tratto distintivo dell’Islam delle origini, perché esso sorge come potere. Il secolo che seguì la morte del Profeta Maometto fu molto sanguinoso e la guerra arabo-araba, o la guerra mussulmano-mussulmana non è mai finita (è un dato importante da non trascurare questo, perché evidenzia come la violenza sia, prima di tutto, intra-islamica). Questa violenza ha accompagnato la fondazione del primo califfato e attinge a certi versetti coranici e ai primi commenti del Testo. È una violenza che è stata istituzionalizzata, rispondendo perfettamente alle esigenze di una religione inizialmente di conquista e che ha esaltato l’istinto di potere e di possesso. Ma che ne è della mistica, della filosofia e della letteratura che si sono sviluppate, molto presto, all’interno dell’universo mussulmano? Gli intellettuali arabi più intransigenti farebbero subito notare che mistica e filosofia non fanno parte propriamente del pensiero islamico, che è composto solo di fiqh (giurisprudenza) e shar’ (Legge). Figure straordinarie del pensiero arabo, avrebbero utilizzato l’Islam come un velo, citando il Testo per giustificare le loro intenzioni e come un espediente per sfuggire ai processi e alle condanne. Quelli che non si sono preoccupati di indossare la “maschera dell’Islam ortodosso” per legittimare le loro posizioni, ci hanno rimesso la vita, come al-Hallāj (mistico sufi nato verso l’858-9 d.C., nell’attuale Iran, e messo a morte il 26 marzo 922 a Baghdad), o hanno dovuto accettare la distruzione delle loro opere.
Dunque, l’Islam è irriformabile? Definire l’Islam come un sistema chiuso e i mussulmani come una comunità monolitica e refrattaria ad ogni pluralismo, significa non solo adottare la definizione dell’Islam data dai fondamentalisti, ma ignorare superficialmente la complessità di questo universo. Indubbiamente, il discorso sul dogma fa parte di questo dibattito e oppone, a grandi linee, due scuole. Prima di tutto coloro che pensano che il dogma islamico sia un ostacolo alla secolarizzazione così come alla laicizzazione. L’argomentazione di questa corrente di pensiero evidenzia alcune criticità: l’Islam non conoscerebbe separazione tra religione e stato (din wa davlat), la sharia (la legge religiosa) sarebbe incompatibile con i diritti dell’uomo e con la democrazia, il credente non ha uno statuto individuale ma è identificato alla umma, la comunità dei credenti. A questa scuola di pensiero si oppongono i cosiddetti riformisti facendo riferimento ad una storia secolare di dibattiti teologico-filosofici, che testimoniano di una vitalità mai venuta meno. Per quest’ultimi la democratizzazione delle società va di pari passo con l’apertura teologica. Si tratta di operare una rivoluzione copernicana interpretativa: elaborare una nuova lettura laica del testo, auspicata da molti, che contempli una distinzione, profonda ed essenziale, tra pratica religiosa individuale e dimensione collettiva e sociale della vita. Si deve uscire da una confusione, per altro presente talvolta nel cristianesimo stesso e, certamente nell’ebraismo, tra religione ed identità. Soprattutto nei contesti della migrazione, per numerosi soggetti di origine mussulmana ma de-islamizzati, l’Islam permette di ricostruire una nuova identità, che non ha nulla a che vedere con una “lettura teologica” del vissuto quotidiano.
Ora i credenti mussulmani devono riconnettersi e imparare a dialogare non solo con nuovi contesti socio-culturali ma, più in genere, con una storia che cammina, con l’avanzata delle civiltà moderne. Per i primi riformisti del XIX e dell’inizio del XX secolo, si trattava di trovare un compromesso tra Islam e acquisizioni scientifiche moderne: adottare senza reticenze le scienze e le tecniche dell’Occidente, ma preservare integralmente il blocco delle credenze mussulmane e quello delle loro applicazioni giuridiche e sociali. Insomma, il ricorso alla ragione è un semplice sostegno e criterio della fede. Quest’approccio ha aperto la strada al salafismo (movimento riformista islamico sorto in Egitto verso la metà dell’Ottocento, che postula la rivivificazione dell’Islam attraverso il ritorno alle fonti originarie: il Corano e sunna del profeta), che cancella, di fatto, un discorso antropologico autonomo, inteso come riferimento pericoloso a quell’idea occidentale di auto-sufficienza del pensiero (come sorgente di cultura e produttore di arte), considerata un modo di rivaleggiare blasfemamente con Dio. Ora, il primo compito dei riformatori, non è tanto quello di far comprendere che lo stato di riforma non è un tradimento dei principi ma un tentativo di miglior comprensione degli stessi ma che, la mutazione è comunque già in corso, sta penetrando l’Islam ed è irreversibile. Si tratta quindi o di subirla, con maggiori rischi per delle conseguenze non controllabili e, eventualmente, nefaste, o di capirla, darne un senso religioso e, addirittura, farla diventare un’occasione di rinnovamento, anche spirituale.
Questo comporta una reinterpretazione radicale della nozione di “tradizione” (la più nobile per l’Islam, quella che da il nome alla seconda sorgente della fede, dopo il Corano: la sunna), secondo la percezione islamica. La fede islamica si fonda sull’idea che solo la ripetizione del passato può produrre un presente accettabile e questo porta a percepire “l’innovazione”, concetto al cuore della modernità in senso occidentale, come un’eresia. La radicalizzazione è il fenomeno mediante il quale si mettono in atto, forme violente d’azione legate ad una ideologia estremista di contenuto politico, sociale e, anche, religioso, proprio per contrastare il “veleno della modernità”. Si badi bene, la radicalizzazione politica precede sempre quella religiosa. La ragione principale di questo meccanismo, è una sorta di “ossessione” per un Occidente (molto spesso più immaginario che reale) reo di aver viziato la cultura mussulmana, minandola al suo interno, diffondendo il secolarismo e una concezione edonista ed egoista della vita (un’ossessione che accomuna, tra l’altro, fondamentalisti religiosi e terzomondisti a referenza islamica). Non è un giudizio semplicemente “morale” ma è l’espressione di due visioni opposte del mondo che, come abbiamo già sottolineato, sono il riflesso di una percezione troppo caricaturale e semplicistica dell’altro, oltre che ad una mancanza di lettura di processi irreversibili in atto nella storia.
Questo risentimento nei confronti dell’Occidente, ben inteso talvolta storicamente giustificato, non è però contestualizzato storicamente ma assume una valenza metafisica che vizia completamente l’elaborazione teologica. È un disagio accentuato da una sorta di “cattiva coscienza” suscitata dalla lancinante domanda: Dio dov’è in tutto questo? Il sentimento di essere stati abbandonati da Lui e l’impossibilità di chiedergli dei conti (palesamento del disagio islamico di fronte ad una apparente “impotenza divina”), suggerisce di prendere unilateralmente l’iniziativa, in nome Suo e dei suoi presunti “diritti calpestati”, per ristabilire la sua egemonia sulla storia. Ora, il Dio che ordinerebbe implicitamente la violenza in nome della legittimità dell’Islam, è Colui che non ha da giustificarsi di fronte all’uomo, ma che non può neppure essere sospettato di non prendere più la difesa degli oppressi. Ne risulta un Dio fustigatore che agisce esclusivamente attraverso il “tremendum”, regnando con il terrore e non come “Clemente e Misericordioso”, com’è, per altro, invocato in apertura della quasi totalità delle sure coraniche!
La risposta degli intellettuali riformisti, si è in genere tradotta opponendo a questo “Dio interventista”, il Dio mistico venerato dai sufi: un Dio che è polo del desiderio spirituale e non ha niente a che fare con la gestione degli affari umani. È una sorta di rifugio individuale fuori del mondo, che preserva la sua trascendenza in una spiritualità privata, senza pronunciarsi contro il Male. Una visione di Dio, questa, particolarmente interessante per i credenti che vivono ormai fuori dei territori storicamente culla dell’Islam, rifiutando la logica di difesa e di espansione geografica della umma (la comunità transnazionale dei credenti dell’Islam). Questi mussulmani non mettono tanto in causa la classica suddivisione binaria del mondo propria dell’islam, il dâr al-islam (la “dimora o spazio dell’Islam”, nel quale i musulmani sono la maggioranza, del quale possiedono il suolo e sul quale legiferano) e il dâr al-harb (la casa della guerra, territori dove si professano altre religioni e si governa secondo leggi altre rispetto alla Legge di Dio; spazio, dunque, potenzialmente pericoloso per un mussulmano) ma si preoccupano semplicemente di identificare le condizioni minimali che permettano loro di vivere in una società non mussulmana, senza tradire la loro appartenenza alla comunità dei credenti. All’inizio degli anni ‘90, un noto predicatore islamico in Occidente, Tariq Ramadan (influente intellettuale egiziano-svizzero vicino ai Fratelli Musulmani, recentemente caduto in disgrazia per problemi legati alla sfera morale), rispolverò, a questo proposito, il concetto di dâr al-sulh (letteralmente “spazio del patto” o anche “spazio della pace o della tregua”): un principio giurisprudenziale del X-XI secolo, che sospende, a tempo indeterminato, la necessità di condurre periodicamente spedizioni contro la dâr al-harb affinché l’Islam vi primeggi. Oggi, secondo Ramadan, la nozione di dâr al-harb è caduca perché non riflette più una situazione di insicurezza per i mussulmani (è talvolta vero il contrario: il fatto cioè che i mussulmani siano più a rischio in paesi a maggioranza islamica). È dunque necessaria una nuova lettura giuridica del presente, uscendo da una “opposizionista”, per ragionare in termini di collaborazione al cuore della società e nella costruzione della stessa.
Al netto dei dubbi, mai dissipati in Occidente, rispetto ad un tale discorso (talvolta sospettato di nascondere secondi fini di “penetrazione occulta”) e alle ambiguità del pensatore che per oltre un decennio ne è stato il maggior propugnatore, ci pare interessante coglierne alcune suggestioni, con riflessi non solo spirituali ma anche sociali. In contesto islamico, è ipotizzabile l’idea di una religione vettore di resistenza non-violenta, di speranza, di lotta e di redenzione qui ed ora e non solo in una prospettiva escatologica, come propugnano le teologie della liberazione cristiane? Fin dagli anni ‘60 si registra, soprattutto nel mondo sciita (in particolare in Iran), una critica al sistema economico capitalista (certo non così strutturata come nelle teologie della liberazione cristiane), ma anche dell’autoritarismo politico, pur senza la dimensione ecologica di questa denuncia (presente solo a livello di movimenti sociali senza riferimento religioso).
A fronte del rigore della sua critica teoretica, il cristianesimo non propone però, al contrario dell’Islam, una rivoluzione politico-sociale in nome della fede. La Rivoluzione iraniana del ‘79 con l’instaurazione della teocrazia, è l’avvento di una nuova teologia della repressione in nome di questa liberazione mitizzata contro l’occupazione “idolatra” degli “oppressori”. In sostanza, nella teologia della liberazione musulmana, c’è una palese difficoltà di superare la semplice denuncia profetica delle ingiustizie per elaborare una nuova strutturazione della società che dia la parola ai dominati e agli oppressi di sempre. Manca una riflessione critica che integri le dimensioni storiche del dominio sociale. Ecco perché si cade facilmente in concezioni manichee della storia, che trasformano molto presto la liberazione in una nuova oppressione, come è evidente nella rivoluzione degli ayatollah in Iran, dove si sostiene la violenza politica contro forme diverse di “sfruttamento idolatrico” di coloro che sono considerati nemici della fede! Una delle conseguenze di questa visione teoretica è la degenerazione violenta del jihadismo, la cui seduzione cresce proporzionalmente al grado di umiliazione, vera o presunta, generalmente attribuita all’Occidente. È una deriva, questa, che tocca una parte infima di mussulmani che, tra l’altro, combattono prima di tutto proprio contro la stragrande maggioranza dei loro correligionari, considerati alla stregua di munafiq, ipocriti o falsi credenti. In questo senso, il riformismo islamico dovrebbe lasciarsi interpellare da un aspetto fondamentale della teologia della liberazione cristiana. Per quest’ultima, la liberazione pur non essendo primariamente un programma politico, implica un impulso al cambiamento delle strutture economiche e sociali inique, cambiamento tuttavia indissociabile col messaggio evangelico nel quale l’amore a Dio non può essere separato dall’amore al prossimo. Ora, c’è una convinzione storico-teologica che ci accomuna, cristiani e mussulmani: quella di avere una "buona notizia" per l’umanità, che coincide con il contenuto della propria fede. Il cortocircuito tra Islam e Occidente, l’abbiamo analizzato, non è una resistenza nei confronti della modernità come progresso ma come libertà. La questione diventa: come vivere in conformità con una vocazione dell’uomo che viene da Dio? Quello che oggi pone degli enormi problemi in certe espressioni islamiche, è il fatto che l’affermazione del cosiddetto diritto divino, della legge divina, sembra andare contro la difesa dei diritti delle persone: come se Dio avesse bisogno di schiacciare le sue creature per affermare sé stesso! Come può ancora chiamarsi salvifica una religione di questo genere? Un secondo problema, è il tentativo di negare la nozione di individuo che come prima gravissima conseguenza comporta la negazione della nozione di libertà di coscienza. Ma è in nome di Dio che dovremmo poter affermare queste due nozioni: di un Dio creatore che non crea in serie ma che entra in rapporto personale con le sue creature (realtà, del resto, implicitamente affermata dalla dimensione profondamente individuale della preghiera islamica).
Per guarire dalla violenza religiosa non basta far riferimento a dei testi considerati sacri, occorre anche che il volto dell’altro lo sia! Ne segue una grande domanda: le religioni rendono più umani o semplicemente devoti? Evidentemente, la dimensione religiosa non esaurisce la complessità antropologica: noi siamo molto di più che il nostro essere religiosi! Questa convinzione ci costringe a prendere sul serio la questione della coscienza personale. Proprio per questo, i milioni di mussulmani che vivono in un Occidente secolarizzato, possono diventare le vere sentinelle di un modo nuovo di credere che fa riferimento non a un giudizio collettivo ma a uno personale.
“Not in my name” era l’hashtag sorprendente apparso qualche anno fa in seno alla comunità islamica europea, nei mesi dell’affermazione globale dell’ISIS (lo Stato Islamico) e dei suoi crimini altamente mediatizzati. L’hashtag accompagnava un video che dava un rilievo iconico all’appartenenza musulmana (aspetto di per sé rivoluzionario in riferimento ad una religione storicamente aniconica): un semplice susseguirsi di volti di uomini e donne, di età diverse, il capo a volte velato e a volte scoperto.
Era come una finestra aperta sulla soggettività investita della responsabilità nei confronti dell’altro, una responsabilità dalla quale è impossibile disertare senza rinnegare la propria vera soggettività, come direbbe Emmanuel Levinas. Una responsabilità che ci interpella come credenti, al cuore della società in cui viviamo e che rappresentiamo come cittadini.
Questo emergere di volti che si dissociano in prima persona dalla violenza religiosa, è una svolta che annuncia un’antropologia in fieri e una nuova comprensione del significato che molti credenti musulmani, soprattutto in Occidente, hanno iniziato a dare alla propria fede. La riflessione sui riflessi nel dialogo interreligioso della fratellanza umana, iniziata fin dal documento di Abu Dhabi, precisa che l’uscita da sé verso il fratello non è frutto solo di una dinamica religiosa, bensì costituisce il nucleo dell’autentica umanità che sa oltrepassare l’orizzonte di un’identità rigida e autoreferenziale. I mussulmani sono soliti citare il versetto 32 della Sura 5: «Chi uccide una persona è come se avesse ucciso l’intera umanità...» per esecrare atti di violenza di loro correligionari. Pochi di noi sanno però che il versetto continua: «… e chi salva la vita di una persona è come se avesse salvato tutta l’umanità». Mantenere in vita l’umanità diventa la questione cruciale per ogni vero credente nel Dio della vita.
Claudio Monge
NOTE:
1 C. Monge – A. Cortesi (dir.), Sulle sponde del Mediterraneo: Geopolitica, guerre, religioni, Firenze, Nerbini, 2017, p.101
 IT
IT  EN
EN