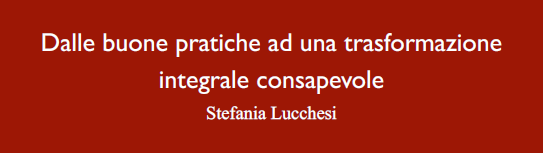
Un possibile percorso
1. La dimensione scientifica
![]() Di fronte alla ormai evidente e pervasiva crisi ambientale che sta interessando, seppure in misure e modalità differenti, le diverse parti del mondo, fa eco il grido di chi denuncia l’essere umano come primo responsabile di tale processo di degrado, ormai apparentemente inarrestabile.
Di fronte alla ormai evidente e pervasiva crisi ambientale che sta interessando, seppure in misure e modalità differenti, le diverse parti del mondo, fa eco il grido di chi denuncia l’essere umano come primo responsabile di tale processo di degrado, ormai apparentemente inarrestabile.
Certamente l’uomo ha una sua responsabilità nei confronti dell’ambiente e numerosi studi scientifici documentano che la componente antropica (modalità di gestione delle risorse naturali e stili di vita) ha un’incidenza sempre più rilevante sugli equilibri che regolano le dinamiche ambientali (Doglioni e Peppoloni, 2020; Ripple e al., 2019).
Tuttavia se la connessione tra azione dell’uomo e modificazioni dei sistemi naturali esiste, nella maggior parte dei casi, è più arduo quantificarne con precisione l’intensità ed individuare correlazioni dirette tra i due fattori a causa dell’elevato grado di complessità dei sistemi naturali. Ancor più incerto è determinare il loro effetto a lungo termine, nell’ordine delle decine di anni, e a scala globale.
A tale scopo la ricerca scientifica indaga le relazioni sistemiche tra fattori naturali e fattori antropici, nel tentativo di descrivere i possibili scenari futuri circa il nostro pianeta. Pertanto è da sottolineare che ogni risultato e deduzione di carattere quantitativo, seppure frutto di analisi scientifiche, deve sempre indicare e tenere in conto il grado di attendibilità con il quale è stato determinato (es. la deviazione standard in termini probabilistici). Ne sono un esempio gli studi di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di grandi infrastrutture o l’IPCC sul clima (IPCC Working Group, 2022) che hanno quindi solo la pretesa di fare proiezioni probabilistiche sulle possibili conseguenze dell’impatto antropico, al fine di mettere in atto adeguate misure di sicurezza per la prevenzione del rischio o la minimizzazione degli effetti dannosi.
2. La dimensione sociologica
A partire dal presupposto che l’essere umano ha la capacità di incidere con la sua azione sull’ambiente, e che esiste una grande complessità all’interno dei vari sistemi naturali, è necessario cercare di comprendere, quali scelte operare per la tutela del nostro pianeta e come attuarle. Oltre al supporto conoscitivo ed esperienziale della scienza, sono da considerare i fattori motivazionali che orientano le scelte individuali e collettive dei soggetti (consumatori e risparmiatori) quali, ad esempio, gli stili di vita. È pertanto fondamentale valutare, anche dal punto di vista psico-sociologico, quali criteri e fattori entrano in gioco, a livello personale e comunitario, nella scelta di determinati comportamenti e la messa in atto di buone pratiche a tutela dell’ambiente. In particolare sarà importante comprendere come passare dall’impegno personale ad un impegno condiviso che coinvolga anche il resto della società e determinare quindi una vera transizione ecologica a scala globale.
3. Le differenti tipologie di azione
La diffusione e il moltiplicarsi di messaggi e propagande a favore dell’ambiente può avere un valore provocatorio, di stimolo per prendere consapevolezza del problema, ma se questo non si trasforma in azioni concrete, può assumere un carattere ambiguo, o addirittura controproducente, rendendo inefficaci e inconsistenti i messaggi e poco credibili le persone che li promuovono, rischiando di cadere in un ecologismo di facciata.
Le azioni che un soggetto (economico) può mettere in atto a favore della tutela dell’ambiente possono essere fondamentalmente di due tipologie: ridurre l’impatto negativo (la cosiddetta “impronta ecologica”), attraverso un comportamento per lo più passivo, o incrementare l’impatto positivo attraverso la valorizzazione o promozione del territorio, mediante un comportamento attivo, partecipativo e creativo (Becchetti, 2022). I due approcci non sono in antitesi ma, anzi, i loro effetti si amplificano, se combinati tra loro.
Analogamente, anche a livello di mercato, esistono differenti orientamenti: soluzioni finalizzate ad un minore spreco di risorse (risparmio, riuso e riciclo), il consumo di prodotti “green” che rispondono a specifici criteri ecosostenibili (es. alimenti da agricoltura biologica, trasporti ecologici, investimenti etici,…) oppure proposte che valorizzano l’ambiente e le sue risorse (slow-food, turismo sostenibile, investimenti a favore degli SDGs [Sustainable Development Goals], cura del patrimonio naturale e culturale, iniziative di sensibilizzazione).
4. Le motivazioni dei soggetti e l’intersezione del sistema
Le motivazioni che spingono un soggetto ad agire a favore della tutela dell’ambiente possano inoltre essere sia estrinseche che intrinseche. Nel primo caso l’interesse è sostanzialmente “utilitaristico” in quanto ha come finalità un maggiore vantaggio personale (es. dieta vegetariana per la propria salute) o un minore danno personale (es. risparmio energetico con conseguente riduzione dei costi). In entrambi i casi il beneficio nei confronti dell’ambiente è indiretto, in quanto è conseguenza della scelta primaria che ha, come obiettivo principale, l’interesse personale.
Nel caso, invece, delle teorie del bene comune (Colombi, 2016) il soggetto mostra una certa sensibilità e interesse verso l’ambiente e pertanto le motivazioni saranno più chiaramente estrinseche, seppure per diversi motivi (es. per interesse del proprio territorio o delle generazioni future).
Analogamente alle motivazioni personali, anche il sistema economico e politico può fare fronte alla crisi ambientale attraverso due tipologie di azioni: scoraggiando azioni dannose per l’ambiente attraverso sanzioni, oppure incentivando azioni di miglioramento a favore dell’ambiente, attraverso specifici finanziamenti o agevolazioni fiscali, promuovendo azioni di cittadinanza attiva e mettendo quindi maggiormente in gioco la capacità decisionale dei soggetti.
Non meno importante è considerare la relazione con altri fattori interconnessi all’ambiente socialmente sostenibile, e da cui non si può prescindere per perseguire una sostenibilità ecologica integrale, infatti “un vero approccio ecologico si trasforma sempre in un approccio sociale, che deve integrare giustizia e discussioni ambientali, ascoltando al contempo tanto il grido della terra che il grido dei poveri” (LS: 49).
5. L’incidenza di stili di vita e buone pratiche
È riconosciuto come la messa in atto di buone pratiche sia il primo passo verso il cambiamento. Tale cambiamento “dal basso”, talvolta definito anche “voto con il portafoglio” (Becchetti, 2020), può infatti avere un potere diffusivo in quanto può diventare stimolo per altri, soprattutto collettività, imprese, enti e comunità che condividono le stesse motivazioni nel cercare di attuare nuovi stili di vita e nuovi paradigmi economici. Tuttavia è da tenere presente la biodiversità sociale e culturale che implica la necessità di una certa creatività: infatti non esistono formule o buone pratiche “certificate” da esportare tali e quali in contesti diversi, ma è riconosciuta la bontà di tali prassi nel creare reti e alleanze tra diversi operatori (stakeholders e shareholders) con la finalità di accrescere il bene comune.
Le variabili in gioco sono molte, ma la possibilità o meno di diffondersi di buone pratiche dipendono dal contesto socio-politico, dalla distribuzione demografica, dalla coesione sociale, dalla qualità di vita della popolazione, dalla capacità cooperativa della stessa. Le ricerche dell’OCTS (Osservatorio internazionale per la coesione e inclusione sociale) evidenziano come, negli ultimi anni, nel contesto italiano, ci sia stato un incremento notevole della diffusione di pratiche di consumo responsabile sia a livello di singoli cittadini (Forno, 2020), sia a livello comunitario (cfr. 49° Settimana Sociale dei cattolici italiani di Taranto 2021).
Significativo inoltre è il fatto che una fascia sempre più rilevante di giovani sia identificata come “green generation”: sensibilità, entusiasmo e creatività, tipiche del mondo giovanile, saranno importanti se impiegati, insieme a specifiche competenze, nel portare avanti iniziative concrete di sostenibilità, che combinano uno sviluppo economico, tecnologico ed umano con la sostenibilità socio-ambientale.
6. Transizione vs. trasformazione
Nell’ambito di un processo di cambiamento, in generale, è possibile riconosce non solo elementi oggettivi che definiscono un orientamento con finalità differenti rispetto alle precedenti, ma anche una componente personale di trasformazione.
Si può quindi riconoscere un cambiamento di tipo “transazionale” e uno di tipo “trasformativo”. Nel primo caso si tratta di un cambiamento esclusivamente a livello tecnico che interessa solamente la realtà oggettiva percepita dall’esterno; nel secondo caso, invece, il cambiamento è capace di “modificare emozioni e idee, di incidere sulle relazioni e sui contesti, sui processi organizzativi e forse, nel lungo periodo, sul sistema sociale più ampio” (Marrone, 2022).
Per favorire quindi il passaggio da azioni legate esclusivamente ad una trasformazione di opportunità o imposte dall’esterno, ad una trasformazione più consapevole, radicale e durevole nel tempo, è fondamentale una trasformazione culturale, supportata da un’adeguata formazione.
Un’educazione interdisciplinare, comprensiva anche dell’educazione ad un pensiero ecologico, sembra quindi costituire un passaggio fondamentale per potere innescare processi trasformativi autentici e a lungo termine
L’educazione ambientale quindi, nella prospettiva di una formazione integrale, sia conoscitiva, sia applicativa, può costituire il primo passo per suscitare interesse alla messa in atto di buone pratiche, non solo per timore di un futuro catastrofico, ma per amore della vita nella sua pluralità di forme (Bruno, 2021).
Ancora una volta, la prospettiva è quella dell’interconnessione: tra l’agire dell’uomo e il sistema-Terra, tra le diverse scienze e gli ambiti di vita, tra la dimensione individuale e quella sociale, tra una transizione “dal basso” e una transizione “dall’alto” (Becchetti, 2022).
7. Conclusioni
Accrescere la coscienza ecologica a partire dalla conoscenza (Doglioni e Peppoloni, 2016) è il primo indispensabile elemento di cui prendersi cura. Ad esso deve affiancarsi la responsabilità e il cambiamento personale, portati avanti attraverso stili di vita e buone pratiche a favore della sostenibilità socio-ambientale, che avranno maggiore efficacia se sostenute da un’adeguata trasformazione culturale e un cambio di paradigma sul fronte ambientale, economico e sociale, a scala sia locale che mondiale (LS: 114,202).
Infine non si tratta solo di definire e censire le buone pratiche, ma di “metterle in rete e di far sì che diventino ambasciatrici di un'economia diversa e di un'ecologia integrale in modo da creare un'alleanza tra amministratori virtuosi, imprese sostenibili, cittadini, reti della società civile, parrocchie, per promuovere il progresso verso il bene comune" (Becchetti, 2021).
Stefania Lucchesi
Riferimenti bibliografici:
Becchetti, L., L' economia tra il venerdì e il sabato. Le buone pratiche del cittadino consum-attore. Vita e pensiero, ed. Univ. Cattolica sacro Cuore, Milano 2020, pp. 152.
Becchetti, L., Intervento alla 49a Settimana Sociale dei Cattolici italiani, Taranto, 21-24 ottobre 2022.
Becchetti, L., La rivoluzione della cittadinanza attiva, ed. EMI, 2022, pp. 184.
Bruno, R.T, Educare al pensiero ecologico per un apprendimento efficace e duraturo, ENEA ed., Energia, ambiente e innovazione, n. 2, 2021, pp.23-25. Doi: 10.12910/EAI2021-035
Colombi, C., Economia è comunità, ed. Aracne, Canterano (RM) 2016, pp. 37-50.
Doglioni, C. e Peppoloni, S., Pianeta Terra. Una storia non finita, ed. Il Mulino, Bologna 2016, pp. 115-140.
Forno, F., Il consumo critico e le disuguaglianze, in: Mattioli, A. e Tintori, C. eds., Patto per una nuova economia, ed. ITL srl, Milano 2020, pp. 85-97.
Francesco, Laudato sì’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015.
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (AR6-WG2). Sixth Assessment Report assesses the impacts of climate change, 2022.
Marrone, D., Processi di cambiamento e leadership, Settimana News, 23/08/2022, EDB Bologna 2022.
Ripple, W.J., Wolf, C., Newsome, T.M. et al., World Scientists’ Warming of a climate emergency, in: Bio-Science, vol. 70 (1), 2020, pp. 8-12.
 IT
IT  EN
EN 











