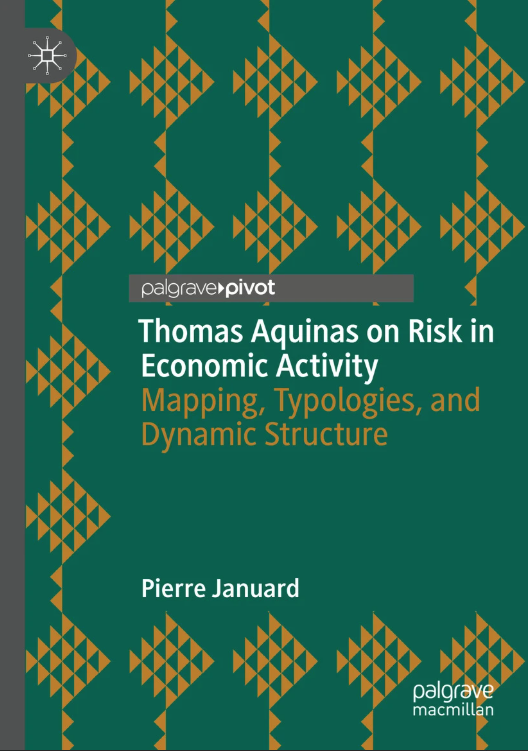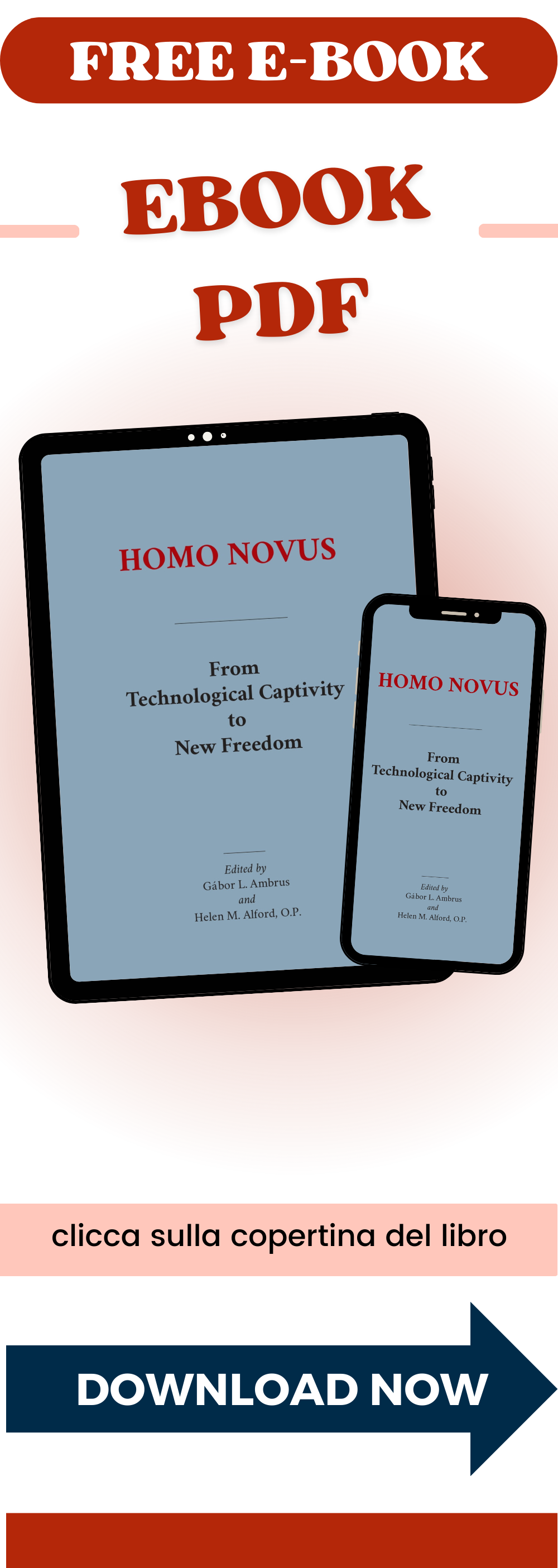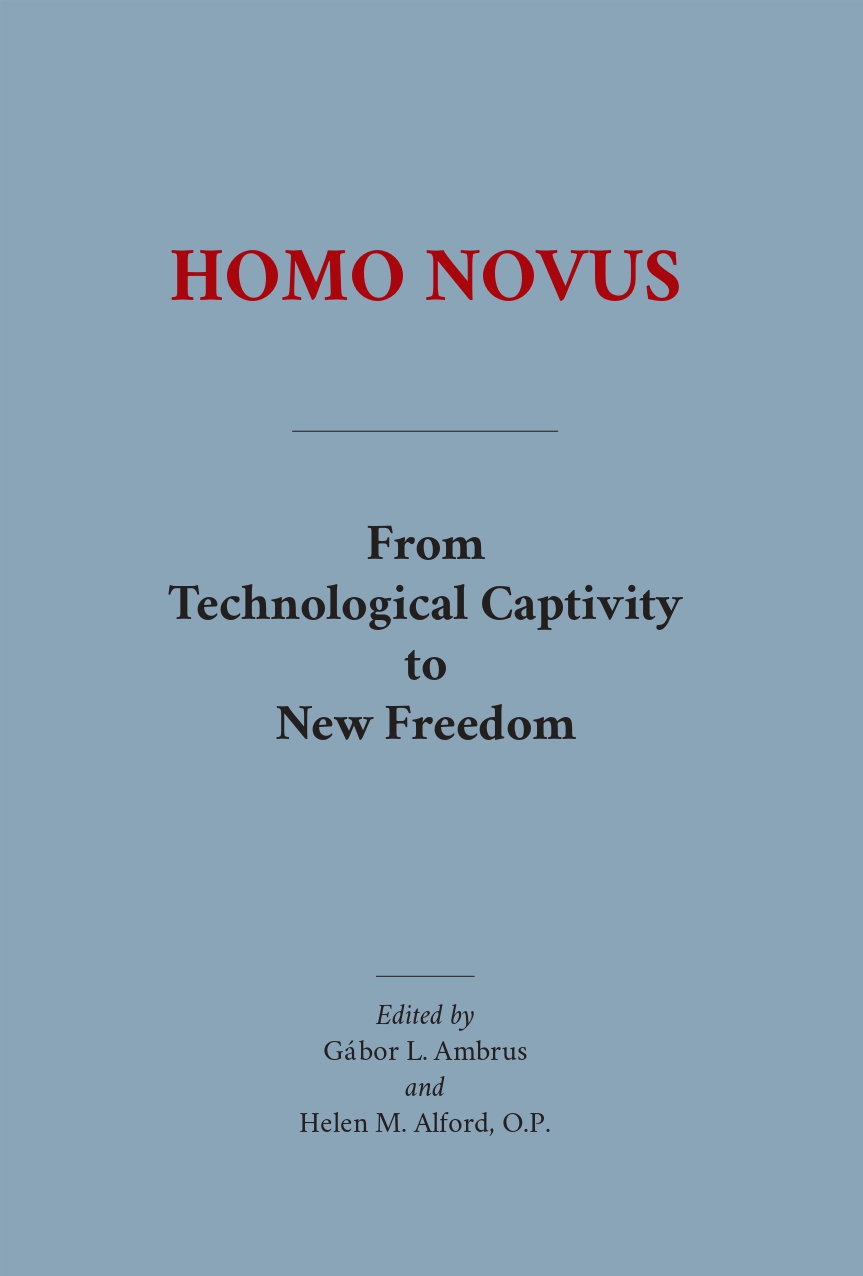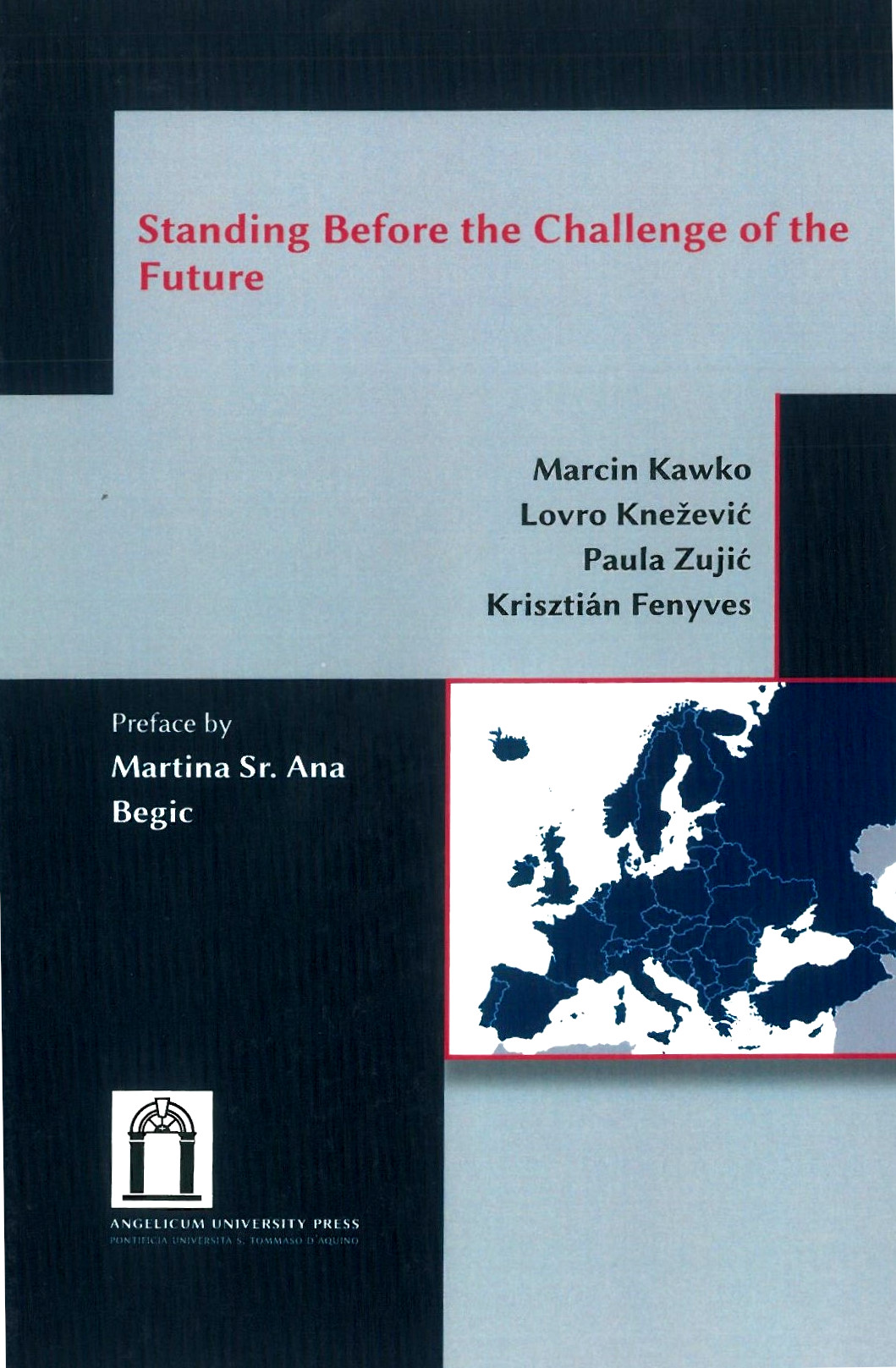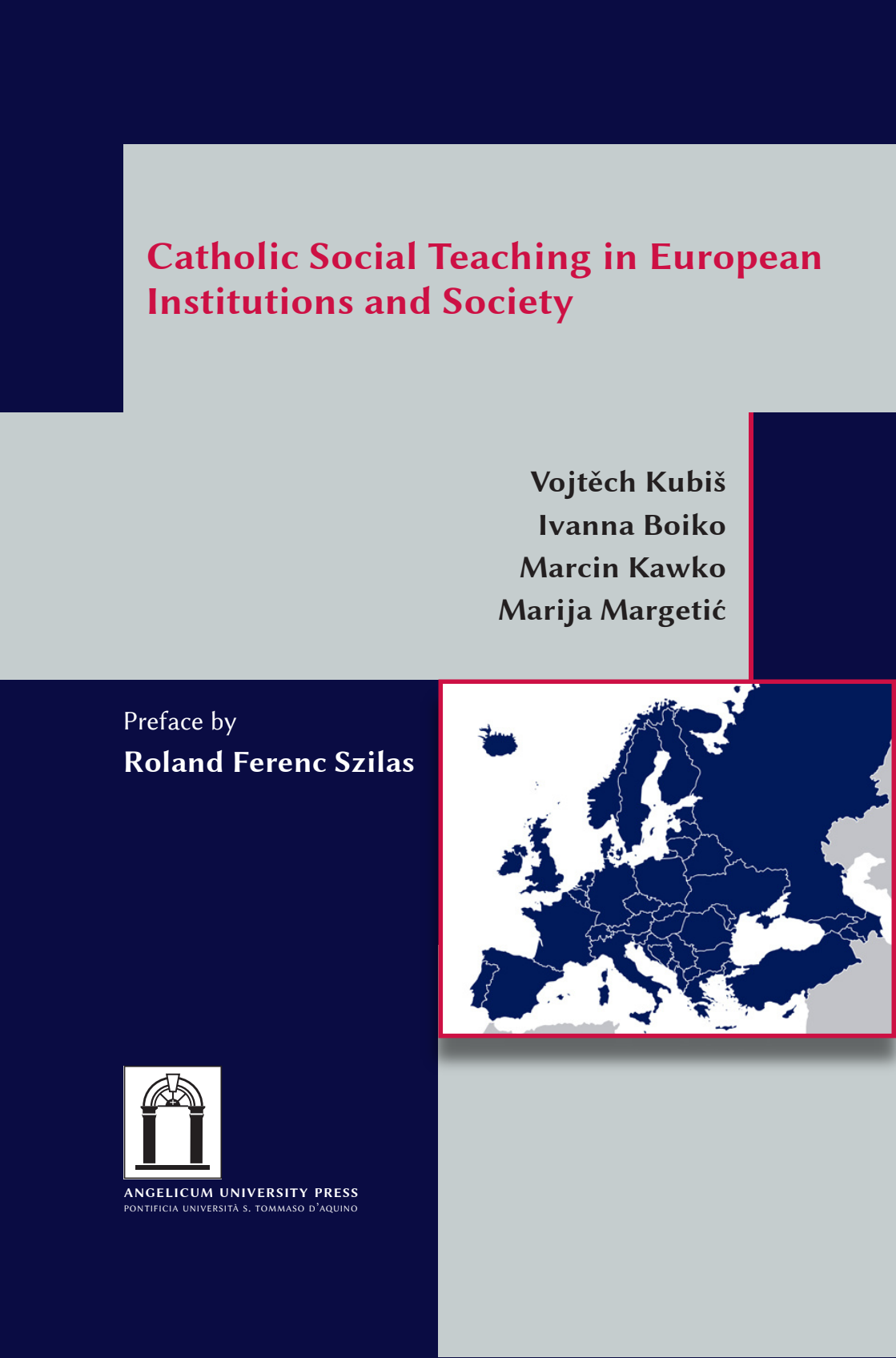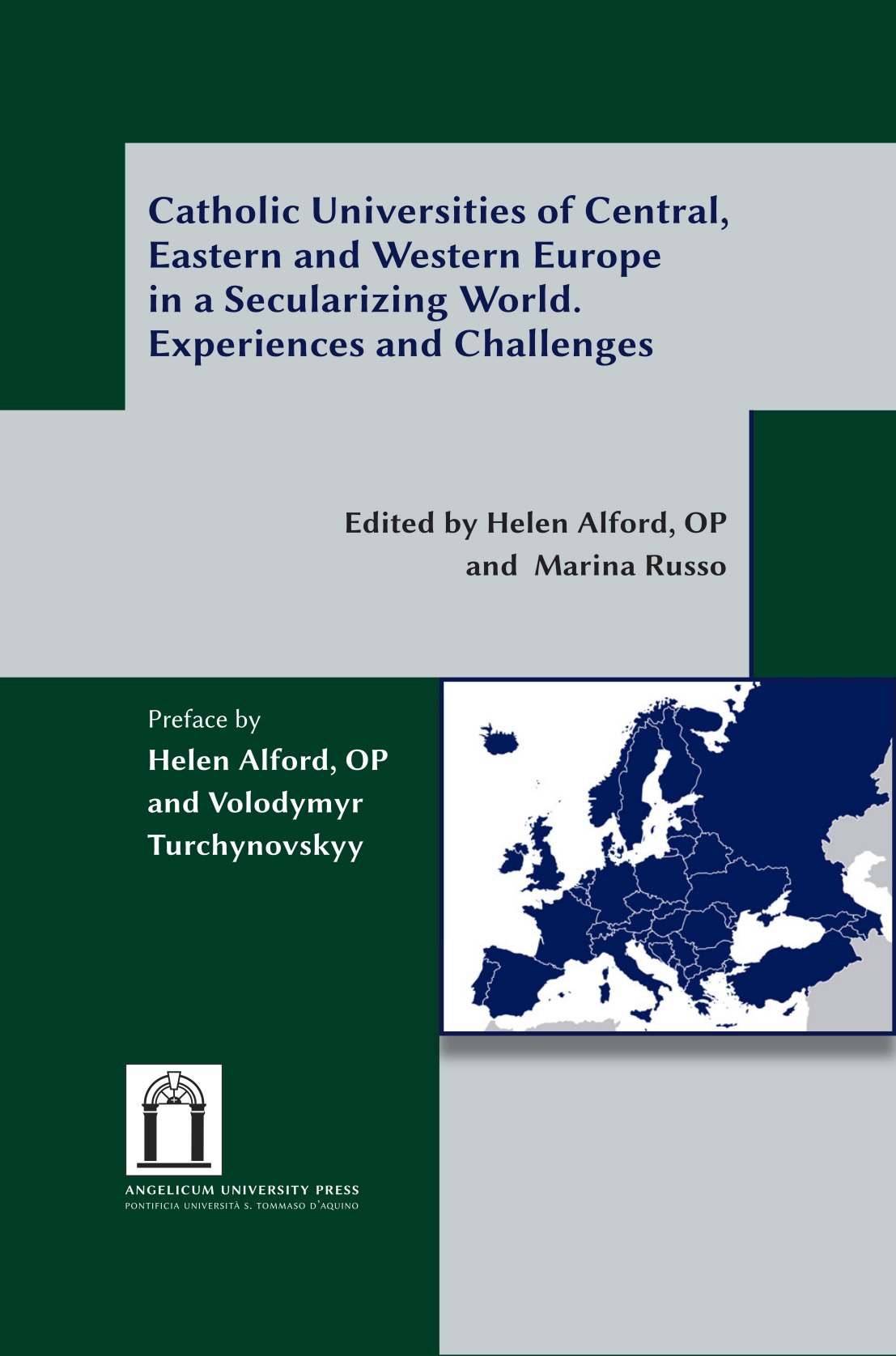1. Duplice lo scopo che assegno a questo intervento. Per un verso, quello di rinverdire una tradizione di pensiero, squisitamente italiana, che affonda le sue radici nell'umanesimo civile del Quattrocento e Cinquecento, una tradizione che è continuata fino al periodo d'oro dell'Illuminismo italiano di scuola sia milanese sia napoletana, e la cui cifra principale è una profonda differenziazione rispetto al ben più noto Illuminismo francese. Per l'altro verso, mi propongo di suggerire una via d'uscita al dibattito, oggi acceso più che mai, circa il futuro dei nostri sistemi di welfare - un dibattito stretto, e perciò isterilito, tra una concezione neo-liberista ed una neo-statalista. Invero, oggi si stanno confrontando, e in certi casi scontrando, due visioni nel modo di concepire quale debba essere il rapporto tra la sfera economica (che possiamo sinteticamente, e con accezione ampia del termine, chiamare mercato) e la sfera del sociale (la solidarietà). Da una parte vi sono coloro che vedono nell’estensione dei mercati e della logica dell’efficienza la soluzione a tutti i mali sociali; dall’altra chi invece vede l’avanzare dei mercati come una “desertificazione” della società, e quindi li combatte e si protegge. La prima visione, considera l’impresa come un ente “a-sociale”: secondo questa concezione, che si rifà ad alcune tradizioni dell’ideologia liberale, il “sociale” è distinto dalla meccanica del mercato, che si presenta come un'istituzione eticamente e socialmente neutrale - nel senso specifico di David Ganthier. Al mercato è richiesta l’efficienza e quindi la creazione di ricchezza, l’allargamento della torta. La solidarietà, invece, inizia proprio laddove finisce il mercato, fornendo criteri per la suddivisone della torta (nella sfera politica), o intervenendo in quelle pieghe della società non raggiunte dal mercato.
mi propongo di suggerire una via d'uscita al dibattito, oggi acceso più che mai, circa il futuro dei nostri sistemi di welfare - un dibattito stretto, e perciò isterilito, tra una concezione neo-liberista ed una neo-statalista. Invero, oggi si stanno confrontando, e in certi casi scontrando, due visioni nel modo di concepire quale debba essere il rapporto tra la sfera economica (che possiamo sinteticamente, e con accezione ampia del termine, chiamare mercato) e la sfera del sociale (la solidarietà). Da una parte vi sono coloro che vedono nell’estensione dei mercati e della logica dell’efficienza la soluzione a tutti i mali sociali; dall’altra chi invece vede l’avanzare dei mercati come una “desertificazione” della società, e quindi li combatte e si protegge. La prima visione, considera l’impresa come un ente “a-sociale”: secondo questa concezione, che si rifà ad alcune tradizioni dell’ideologia liberale, il “sociale” è distinto dalla meccanica del mercato, che si presenta come un'istituzione eticamente e socialmente neutrale - nel senso specifico di David Ganthier. Al mercato è richiesta l’efficienza e quindi la creazione di ricchezza, l’allargamento della torta. La solidarietà, invece, inizia proprio laddove finisce il mercato, fornendo criteri per la suddivisone della torta (nella sfera politica), o intervenendo in quelle pieghe della società non raggiunte dal mercato.
Agli antipodi di questa visione troviamo l’altro approccio, che vede l’impresa come essenzialmente anti-sociale. Questa concezione, che ha tra i suoi teorici autori come K. Marx e K. Polanyi, e come espressione oggi più visibile alcune delle componenti del “popolo di Seattle”, si caratterizza invece per concepire il mercato come luogo dello sfruttamento e della sopraffazione del debole sul forte (Marx), e la società minacciata dai mercati: “il mercato avanza sulla desertificazione della società” (Polanyi). Da qui il loro appello a “proteggere la società” dal mercato (e dalle imprese multinazionali, in particolare, con l'argomento che i rapporti veramente umani (come l’amicizia, la fiducia, il dono, la reciprocità non strumentale, l’amore, ecc.), sono distrutti dall’avanzare dell'area del mercato. Questa visione, che pure coglie alcune dinamiche dei mercati reali, tende a vedere l’economico e il mercato come di per sé disumanizzanti, come meccanismi distruttori di quel “capitale sociale” indispensabile per ogni convivenza autenticamente umana oltre che per ogni crescita economica.
La visione del rapporto mercato-società tipica dell’Economia Civile, che in questa sede intendo avanzare, affonda le sue radici nel pensiero classico e in particolare nell’Umanesimo Civile Italiano. Si tratta di una visione che si colloca in una prospettiva radicalmente diversa rispetto alle due oggi dominanti. L'idea centrale e di conseguenza la proposta dell’Economia Civile è quella di vivere l’esperienza della socialità umana, della reciprocità e della fraternità all’interno di una normale vita economica, né a lato, né prima, né dopo. Essa ci dice che i principi “altri” dal profitto e dallo scambio di equivalenti possono trovare posto dentro l’attività economica. In tal modo si supera certamente la prima visione che vede l’economico (i mercati) come luogo eticamente neutrale basato unicamente sul principio dello scambio di equivalenti, poiché è il momento economico stesso che, in base alla presenza o assenza di questi altri principi, diventa civile o in-civile.
Ma si va oltre anche l’altra concezione che vede il dono e la reciprocità appannaggio di altri momenti o sfere della vita civile, una visione questa – ancora oggi radicata in non poche espressioni del Terzo Settore – che non è più sostenibile. E ciò per almeno due ragioni. Primo, in mercati globalizzati la logica dei “due tempi” (prima le imprese producono, e poi lo “Stato” si occupa del sociale), su cui è fondato il rapporto tra economia e società (si pensi al Welfare State), non funziona più, perché è venuto meno l’elemento base di quella visione, e cioè il nesso stretto tra ricchezza e territorio, su cui tutto il sistema sociale era stato pensato in Occidente, e in Europa in modo particolare. Oggi questo meccanismo si è spezzato, sotto l’incedere della globalizzazione dei mercati. All’impresa è chiesto di diventare sociale nella normalità della sua attività economica. Secondo, l’effetto “spiazzamento”. Se il mercato, e più in generale l’economia diventano solo scambio strumentale, si entra dentro uno dei paradossi più preoccupanti di oggi. La “moneta cattiva scaccia la buona”: è una delle più antiche leggi dell’economia (applicata alle monete). E’ questo un meccanismo che ha una portata più vasta, e agisce, ad esempio, tutte le volte in cui motivazioni intrinseche (come la gratuità) si confrontano con motivazione estrinseche (quali il guadagno monetario): le cattive scacciano le buone. Lo scambio basato solo sui prezzi, solo sul contratto strumentale, scaccia altre forme di rapporti umani. Così il mercato – se è solo questo – sviluppandosi “erode” la condizione del suo stesso esistere (cioè la fiducia e la propensione a cooperare).
Le nostre società hanno bisogno di tre principi autonomi per potersi sviluppare in modo armonico ed essere quindi capaci di futuro: lo scambio di equivalenti (o contratto), la redistribuzione della ricchezza e la reciprocità. Tutte le società conoscono questa struttura “triadica”; in certe società può non esistere il mercato, ma certamente esistono forme di ridistribuzione del reddito e soprattutto esiste il dono come attività simbolica che rafforza il senso di appartenenza alla comunità.
Cosa succede infatti quando uno dei tre principi viene meno? Se si elimina la reciprocità abbiamo il sistema economico del welfare-state del dopoguerra di marca inglese (Beveridge e Keynes). Il centro del sistema è lo Stato benevolente. C’è il mercato che produce con efficienza e lo Stato che ridistribuisce secondo equità quanto il mercato ha prodotto. Se si elimina la ridistribuzione ecco il modello del capitalismo caritatevole. Il mercato è la leva del sistema, e deve essere lasciato libero di agire senza intralci (il cosiddetto neoliberismo). In questo modo il mercato produce ricchezza, e i “ricchi” fanno “la carità” ai poveri, “utilizzando” la società civile (che quindi viene deformata) e le sue organizzazioni (le charities e le Foundations). Infine, l’eliminazione dello scambio di equivalenti produce i collettivismi e comunitarismi di ieri e di oggi, dove si vive volendo fare a meno della logica del contratto (anche a costo di inefficienze e sprechi). La storia finora ci ha insegnato che solo piccole comunità riescono a svilupparsi senza questo principio.
2. L’umanesimo civile fu un particolarissimo, breve, periodo della storia italiana che esercita ancora oggi il suo fascino, e continua a rappresentare un decisivo punto di riferimento culturale, perché fu il risultato di una felice alchimia tra i valori dell’antichità, classica e cristiana, e le nuove esigenze politiche, culturali ed economiche che in quegli anni irrompono sulla scena dell’Occidente. Oggi sappiamo che non è possibile comprendere la genesi dell’economia civile e più in generale dell’economia politica senza fare i conti con l’umanesimo civile italiano e la sua civiltà cittadina. Ripartire idealmente nella ricostruzione della tradizione dell’economia civile dall’Umanesimo significa allora cercare di raccordare l’economia contemporanea con la sua storia millenaria: significa mostrare che la riflessione sull’economico non è un fungo che spunta all’improvviso nella stagione della modernità, ma una nuova fioritura di un albero secolare, che può, ancora, rifiorire.
L’“età dell’oro” dell’Umanesimo civile è senza dubbio la Toscana della prima metà del Quattrocento. I suoi maggiori esponenti e interpreti furono Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Léon Battista Alberti e Matteo Palmieri, Antonino da Firenze. E’ un’età che vede a Firenze una concentrazione straordinaria di artisti, da Brunelleschi, Masaccio e Donatello, Botticelli, Della Robbia, Beato Angelico.
All’umanesimo sono normalmente associati due elementi base: la riscoperta della cultura classica (greca e latina) e la necessità, per una vita pienamente umana, della vita civile. Il secondo elemento costituisce dunque più tipicamente l’umanesimo civile. La stagione dell’umanesimo civile non coincide con tutto l’umanesimo, poiché solo il suo primo momento merita l’aggettivo civile, prima che alla fine del Quattrocento prendesse il sopravvento l’anima individualista, platonica, contemplativa, solitaria e magica (di un Pico della Mirandola o di un Ficino), chiudendo di fatto la stagione del primo umanesimo civile, con l’affermazione dell’idea di individuo, cioè di un soggetto "separato" dagli altri individui e a fortiori dalla comunità.
Le due anime dell’umanesimo (quella civile-aristotelica e quella individualista-platonica) daranno vita a tradizioni diverse nelle scienze sociali moderne: quella individualista, che sfocerà nell’edonismo e nel sensismo del Settecento (ripreso poi dalla scienza economica neoclassica di fine ottocento); quella dell’economia civile che, pure nel Settecento, avrà in Hutcheson, Paolo Mattia Doria, Genovesi, Beccaria, Verri e Adam Smith i suoi principali rappresentanti, e che oggi, come un fiume carsico, sta di nuovo riemergendo.
Con l’umanesimo civile, si ebbe una straordinaria rivalutazione della dimensione terrena e relazionale dell’essere umano, dalla famiglia, alla città, allo stato: sono molti i trattati sulla vita civile, in risposta ai trattati sulla vita solitaria (Petrarca) dei secoli passati. Si riscoprono i classici del pensiero antico, Cicerone e Aristotele su tutti, ma l’atteggiamento degli umanisti civili nei confronti della cultura è attraversata dall’esigenza di un filosofare che sia scuola di vita, meditazione seria e profonda dei problemi di vita, proprio come sarà, quasi quattro secoli dopo, con Genovesi e l’economia civile.
Per gli umanisti, anche in reazione al pensiero dominante nell’epoca dalla quale stavano uscendo, la sola vera virtù è virtù civile, la sola vita veramente umana è la vita activa: “la virtù è a disposizione di tutti” (P. Bracciolini). Non c’è quindi virtù nella vita solitaria, ma sono nella città: l’uomo, “debole animale, per sé insufficiente, raggiunge la sua perfezione solo nella civile società” (Leonardo Bruni, introduzione alla traduzione italiana della Politica di Aristotele).
Non deve quindi stupire che Bruni, Alberti, Bernardino da Siena, o Poggio Bracciolini si scaglino contro i detrattori della vita economica e delle ricchezze, proponendo tesi sull’utilità sociale delle ricchezze e sull’eterogenesi dei fini che solo nel ’700 diventeranno di dominio comune. Resta comunque molto chiaro a questi autori che la ricerca dell’interesse personale, non si trasforma automaticamente e magicamente in bene comune: la ricerca degli obiettivi privati si trasforma in ben-vivere sociale solo all’interno della civitas: non c’è economia civile senza leggi, istituzioni e virtù civili, è questo uno dei principali messaggi della tradizione italiana, nella quale gli economisti erano anche giuristi e viceversa (si pensi, in età moderna, ai milanesi Beccaria o Romagnosi). E’ la civiltà cittadina - vero e proprio modello di ordine sociale che si afferma in questo periodo - che rende possibile che la ricerca del tornaconto individuale non inneschi meccanismi distruttivi del tessuto civile, e che i mercati, custoditi e alimentati dalle altre forme della vita civile e spirituale siano pro e non contro la comunità.
La stagione dell’umanesimo civile fu breve, troppo breve. L’esperienza della libertà e della repubblica cedette il passo alle Signorie e alle monarchie assolute, che subito si tradussero in un’epoca di autoritarismi ben lontani dalla libertas florentina della prima metà del quattrocento, e da quella cultura cittadina. Infatti non è un caso che con la fine del quattrocento la riflessione sulla vita civile subisce un arresto, e lo stesso umanista non è più l’uomo politico e impegnato come lo erano stati Bruni o Palmieri, ma un free lance, non più inserito né in universitas né in città, ma individuo solitario, girovago da una corte europea ad una altra. Anche la riflessione sulla felicità diventa ora una ricerca sulla felicità individualista ed epicurea, come i vari trattati di questo periodo sulla felicità stanno ad indicare: Marsilio Ficino, Filippo Beroaldo, Piero Valeriano, Lorenzo de’ Medici o Pico della Mirandola, tutti, seppur in modo diverso, scrivono che la felicità va cercata nella fuga dalle creature e dalla città, e che la vita in comune non può portare che sofferenze.
Così tra l’umanesimo civile e la modernità si è consumata una rottura: l’esperienza della vita civile si è fermata alle soglie della filosofia moderna. Nella quale, come è noto, la concezione della dinamica intersoggettiva acquista un ruolo centrale: la socialità, la vita civile, è qualcosa di estrinseco, di transitorio, di accidentale: “Studiando le grandi correnti del pensiero filosofico europeo riguardo la definizione di ciò che è umano, si giunge ad una conclusione inaspettata: la dimensione sociale, l’elemento della vita in comune, non è generalmente considerato necessario per l’uomo” (T. Todorov). Quali sono le ragioni del mancato incontro tra vita civile e modernità? Perché quest'ultima ha posto il proprio fondamento nell’individualismo?
3. All’aurora della modernità, si affermò una concezione dell’uomo visto come un essere individualista, guidato in ogni sua azione deliberata dall’amor proprio, frenato soltanto dall’incontro-scontro con gli interessi degli altri. Tipica di questo periodo di transizione dall’Umanesimo alla modernità (il Seicento e la prima parte del Settecento) è la domanda: “perché gli uomini scelgono di vivere in società?”, come a dire che è pienamente ammissibile che possa esistere un uomo isolato prima del rapporto con gli altri. Questa visione esclude dunque che il rapporto con l’altro sia connaturale all’essere umano, il quale, in realtà, non conosce vita altra da quella sociale. Posizioni simili le troviamo nel razionalismo cartesiano e nella “Monadologia” di Leibniz, che ci ricorda come ogni persona sia “un mondo a parte, autosufficiente, indipendente da ogni altra creatura”. Certo, si riconosce bensì il fatto che la vita reale è sociale, nel senso di associata, ma nella dinamica interpersonale si coglie soprattutto il rischio della morte stessa dell’individuo. Per esprimere questo paradosso Kant conia l’espressione “insocievole-socievolezza”, che caratterizzerebbe in maniera esemplare la condizione dell’uomo all’alba della modernità.
Per comprendere come la nascente economia politica e civile affronterà questo paradosso, è molto importante guardare da vicino il pensiero di due autori, Thomas Hobbes e Bernard de Mandeville, ai quali si deve la risoluzione del paradosso della vita in comune attraverso la rinuncia alla vita civile. Come è noto, per Hobbes ciò che gli uomini hanno in comune è la loro “uccidibilità” generalizzata, e cioè il fatto che chiunque può essere ucciso da chiunque altro. Il conflitto, la competizione, la lotta per sopraffare l’altro e conquistare il potere è la condizione ordinaria degli uomini, mentre la pace e la concordia sono stati temporanei. La paura dunque è il fondamento della vita in comune. Emblematiche, e lontanissime dall’Umanesimo civile e dalla tradizione classica, sono le prime pagine del De Cive (1642) di Hobbes: “La maggior parte di quelli che hanno scritto attorno agli Stati, presuppongono o richiedono, come cosa che dev’essere rifiutata, che l’uomo è un animale sociale, zòon politikòn, secondo il linguaggio dei greci, nato con una certa natural disposizione alla società. … Questo assioma, benché comunemente accettato, è completamente falso. … Noi non cerchiamo i compagni per qualche istinto della natura, ma cerchiamo l’onore e l’utilità che essi ci danno: prima desideriamo il vantaggio, poi i compagni. … “ ([1999], p. 48).
Siamo al polo opposto rispetto ad Aristotele, san Tommaso, Genovesi, o Smith, e all’idea di cittadino tipica dell’umanesimo civile. Non una società civile che nasce dalla composizione di persone naturalmente socievoli, ma una società-stato che può solo esistere se un patto artificiale – un contratto sociale - la crea e un “Leviatano” la mantiene con la forza. Nel radicalismo di Hobbes troviamo però anche un’intuizione capace di darci conto del perché il pensiero moderno abbia preso le distanze dall’Umanesimo civile: le guerre di religione e la violenza dei nascenti stati nazionali (il pensiero di Hobbes si forma durante la durissima “guerra dei trent’anni”), mostravano un uomo moderno liberato bensì dai lacci del feudalesimo ma incapace di dar vita a società pacifiche e felici. Davanti ad un tale spettacolo, la soluzione che Hobbes vide come possibile per evitare la guerra di tutti contro tutti fu quella di rinunciare al rapporto interpersonale, delegando la mediazione intersoggettiva allo stato-Leviatano; in altre parole, rinunciò al civile per salvare il politico inteso come sfera dello statuale.
L'altro attacco all’ottimismo degli autori civili (in Inghilterra rappresentati soprattutto dal filosofo Shaftesbury e dalla sua teoria sulle virtù) fu quello di Mandeville, con la sua celebre Favola delle Api (1714), il cui sottotitolo racchiude il messaggio centrale dell’autore: vizi privati, pubblici benefici. La favola narra infatti la triste storia di un alveare di api egoiste che, grazie alla loro avarizia e disonestà, vivevano nell’abbondanza e nel benessere. Ad un certo punto le api si convertono e diventano oneste, altruiste e virtuose. In breve tempo l’alveare precipita nella miseria. Rispetto a Hobbes, qui l’attacco alle virtù civili viene sferrato da una prospettiva diversa: non solo non è vero che l’uomo è un “animal civile” – come aveva asserito Leonardo Bruni - portato dalla sua natura al rapporto con gli altri, ma Mandeville arriva a sostenere che anche qualora lo fosse, o lo diventasse per la cultura e l’educazione ricevute, dovrebbe comunque tenere a freno le sue virtù, perché esse sono negative per la vita della società. È il vizio che porta il bene-vivere sociale, non la virtù: “frode, lusso e orgoglio devono vivere, finché ne riceviamo i benefici. … La semplice virtù non può far vivere le nazioni nello splendore. Chi vuol far tornare l’età dell’oro deve tenersi pronto per le ghiande come per l’onestà”. Le virtù, secondo Mandeville, sono benefiche solo nelle piccole comunità (come la famiglia o il villaggio), e se le grandi società volessero fondarsi sulle virtù civiche sarebbero destinate a restare sempre nella miseria e nell’indigenza, a sperimentare assieme “l’onestà e le ghiande”.
Hobbes e Mandeville furono i due autori con i quali i fondatori dell’economia moderna dovettero maggiormente confrontarsi. Dopo le loro critiche radicali non era più possibile fondare un’economia che volesse chiamarsi politica o civile, che volesse mostrare la “civiltà” e il ruolo civilizzante dell’economia, senza prendere sul serio quelle loro obiezioni di fondo. Invero, in una società come quella descritta da Hobbes e Mandeville non c’è posto per l’economia civile, che, come abbiamo visto, si fonda proprio sulle virtù civiche e sulla natura socievole dell’essere umano il quale è spinto ad incontrarsi, anche nel mercato, con gli altri. Va però detto che l’attacco di Hobbes, e forse ancor più quello di Mandeville, ha finito con l'esercitare un certo fascino sui primi economisti: pur non volendo condividere l’impianto di fondo delle loro visioni dell’uomo e della società, Smith, Genovesi, o Galiani non potevano negare che Hobbes e ancor più l’autore della Favola della Api cogliessero qualche aspetto di verità.
La principale strada che i primi economisti seguirono, sia in Scozia, sia in Francia sia in Italia, fu una rifondazione dell’etica, che tenendo conto delle critiche degli autori individualisti, fornisse nuove ragioni al civile e alla socialità. Non è quindi vero - come normalmente raccontano i libri di testo - che l’economia moderna nasce emancipandosi, anzi separandosi, dall’etica: dopo Hobbes e Mandeville ciò non era più possibile; essa nasce piuttosto sulla rifondazione di una nuova etica, che consentisse all’economia di ritornare civile nonostante Hobbes e Mandeville. E non a caso questa rifondazione avvenne attorno alla metà del 1700: si dovette cioè attendere un nuovo periodo di riforme e di pace (si pensi, ad esempio, alla Napoli di Vico e Genovesi sotto il riformatore Carlo III di Borbone), perché potesse rinascere, ed essere credibile, una nuova riflessione razionale sulla vita civile.
L’operazione da loro tentata - operazione che accomuna le varie scuole classiche di economia politica - fu quella di oltrepassare Hobbes e Mandeville, raccogliendo alcune delle loro critiche, ma portando il discorso su di un piano superiore: mostrare, infatti, che la società civile è proprio quell’insieme di stili di vita, di regole e di istituzioni che fa sì che la natura ambivalente dell’essere umano, la sua insocievole-socievolezza, possa essere orientata al bene comune. Riconobbero che nella “grande società”, la moderna società commerciale, non si può far troppo affidamento sulla benevolenza, perché l’uomo “reale” è tendenzialmente portato all’interesse personale (e in ciò stavano dalla parte dei critici); l’interesse personale, però, all’interno della vita civile, non è più considerato un “vizio” perché è visto congiuntamente all’interesse degli altri, cioè all’interesse pubblico (e in ciò stavano dalla parte degli umanisti civili).
L’economia moderna, politica (inglese) e civile (italiana), nacque quindi inserita all’interno di una ricca e complessa antropologia, che espresse la ricerca dell’interesse personale come una passione compatibile con l’interesse degli altri. Non opposero all’interesse la benevolenza o l’altruismo, ma dissero che l’interesse personale è solo una faccia della medaglia: l’altra è occupata dagli interessi degli altri: “L’utile, quella gran molla delle azioni umane, ed il ben essere a cui ognuno aspira, faran sempre correre gli uomini là ove l’utile ed il ben essere viemmeglio e più facilmente s’incontrano. … Che ciascuno resti persuaso, che per rinvenire il proprio bene bisogna cercarlo nel procurare quello de’ suoi simili” (Giuseppe Palmieri, 1788, corsivo aggiunto).
4. Nonostante quello che una certa vulgata della storia del pensiero economico ha lasciato intendere per lungo tempo, il pensiero di Adam Smith è molto più vicino alla tradizione umanista di quanto si racconti: è anch’esso economia civile. Questa interpretazione di Smith come “economista civile” non è molto diffusa, in particolare tra gli economisti che continuano ancora oggi a citare di Smith la frase forse più celebre del pensiero economico, scorporandola però dal contesto del suo pensiero: “non è dalla benevolenza del macellaio, del fornaio e del birraio che ci aspettiamo il nostro pranzo ma dalla considerazione del loro interesse; non ci rivolgiamo al loro senso di umanità ma al loro egoismo, e non parliamo loro delle nostre necessità ma dei loro vantaggi”.
Una frase, questa, che presa a sé stante ci farebbe subito collocare Smith dalla parte di Mandeville o Hobbes: dov’è la reciprocità, dove sono le virtù civili, in questo discorso? Ed è infatti quanto per molto tempo si è fatto, scrivendo la storia dell’economia politica. Se però abbiamo la pazienza di inoltrarci un poco nella lettura dell’intero capitolo della Ricchezza delle Nazioni (del 1776) dal quale è tratto il brano citato, e se poi addirittura collochiamo il pensiero di Smith all’interno della sua più generale teoria morale, le cose si complessificano e diventano molto più interessanti per il nostro discorso.
Risalendo di qualche riga dalla frase del “macellaio” e prendendo così il discorso di Smith al suo nascere, ci accorgiamo che egli inizia parlando della “propensione a scambiare e a barattare una cosa con un’altra”, cosa che per Smith è “uno dei principi più tipici della natura umana”, al punto che “nessuno ha mai visto un cane scambiare un osso con un altro cane” (p. 15). E per questo motivo quando un cagnolino vuole ottenere qualcosa dal padrone può solo cercare di convincerlo scodinzolando e salterellando attorno a lui. La propensione a scambiare con gli altri è dunque per Smith una tipica espressione della socialità umana, che si può esprimere nella sua pienezza solo nella società civile, dove esiste la divisione del lavoro e ciascuno ha un costante bisogno di ottenere qualcosa dagli altri – non potendo provvedere da solo o con la sua famiglia a tutti i suoi bisogni. Smith riconosce che il modo più naturale e umano di ottenere le cose dagli altri sarebbe la reciprocità, l’amicizia e l’amore (come nella famiglia): ma nella grande società “la durata di tutta la vita ci basta appena a guadagnarci l’amicizia di pochi”. Quindi l’amicizia non basta per poter ottenere ciò di cui abbiamo bisogno dagli altri, la carne dal macellaio il pane dal fornaio e la birra dal birrario. In una società civilizzata, quindi, l’amore scambievole o l’amicizia – che pur continuano a svolgere una loro specifica e essenziale funzione – non sono più sufficienti per farci procurare le cose necessarie alla vita. Ecco allora davanti a noi due alternative: vivere come il cagnolino o il mendicante che per il loro pasto “dipendono dalla benevolenza del macellaio”, oppure “scambiare e commerciare” con gli altri. E se scegliamo di scambiare invece di mendicare, nella grande e civile società non potremo fare affidamento primariamente sulla benevolenza e sull’amore degli altri concittadini per soddisfare i nostri bisogni, ma ciascuno “potrà più probabilmente riuscirvi se può indirizzare il loro egoismo a suo favore” (p. 16). Il mercato è quindi per Smith un meccanismo provvidenziale. Esso ci permette di ottenere pacificamente dagli altri le cose che ci servono anche se non tutti sono nostri amici. Ecco perché la frase del macellaio citata sopra continua dicendo che “nessuno, tranne il mendicante, decide di dipendere principalmente dalla benevolenza dei suoi concittadini” (p. 16); e quell’avverbio “principalmente” ci dice che anche la visione economica di Smith attribuisce un posto all’amore e alla reciprocità (siamo quindi lontani da Mandeville), pur riconoscendo, forse con un velo di amarezza, che nella società moderna l’amore reciproco non è sufficiente, e occorre cercare meccanismi sussidiari: ecco così che l’esistenza del mercato che opera all'interno della società civile da una parte evita l’insinuarsi tra le pieghe dell’insufficienza dell’amore scambievole la guerra o il sopruso (l’altra possibilità sempre presente in questi scrittori umanisti civili), e, dall’altra parte, allontana lo scenario di un mondo composto di pochi benevolenti e da moltitudini di mendicanti “assistiti” (come era quello dal quale l’Europa stava, con fatica, uscendo).
Siamo quindi in piena continuità con la tradizione dell’umanesimo civile (anche se, rispetto a Vico e Genovesi, con minori radicamenti nel messaggio cristiano), tradizione che vede il mercato come luogo di sviluppo civile e umano: luogo di rapporti orizzontali tra persone “alla pari”, le quali possono incontrarsi e scambiare, guardandosi in faccia con pari dignità. Ovviamente c’è in Smith la consapevolezza del ruolo essenziale dello Stato (pensiamo all’enfasi da lui posta sulla diffusione dell’istruzione) nel creare le condizioni perché l’uguaglianza tra gli attori del mercato sia effettiva e sostanziale.
Se poi scaviamo più in profondità nel pensiero di Smith, e guardiamo anche alle sue opere filosofiche, soprattutto alla sua Teoria dei Sentimenti Morali, pubblicata originariamente nel 1759, prima quindi del suo trattato di economia (ma, non a caso, aggiornata e ripubblicata in successive edizioni fino al 1790, anno della sua morte), vi ritroviamo tutti i temi tipici di quella tradizione. La fede pubblica e le virtù civili, ad esempio, sono molto presenti nel suo pensiero, anche se in lui è molto forte l’esigenza di sottolineare il ruolo positivo dell’estensione dei mercati per rafforzare fiducia e virtù civili. In un brano delle sue Lezioni universitarie a Glasgow (1763) troviamo: “Ogniqualvolta che il commercio è introdotto in un paese, con esso arrivano anche onestà e puntualità” (p. 538), arrivando a dire che il successo commerciale degli olandesi dipendeva dal fatto che in Europa erano il popolo “più fedele alla parola data”. Quindi anche se in Genovesi troviamo l’enfasi sulla direzione opposta del ragionamento (“costruisci la fede pubblica e poi fiorirà il mercato”: il Regno di Napoli, sotto questo punto di vista, non era la città di Glasgow), pure in Smith abbiamo una stretta relazione tra mercato e fede pubblica: l’una è vista intrecciata con l’altro, e senza l’uno l’altra non fiorisce.
Ma particolarmente bella e “civile” è la sua antropologia, la sua visione dell’essere umano che è alla base dell’intera sua costruzione teoretica. Essa è costruita attorno alla categoria del fellow-feeling, cioè il bisogno innato nella persona umana di immedesimazione con l’altro, di corrispondenza di sentimenti con il prossimo. Ciò emerge già dalle prime righe della sua Teoria dei Sentimenti Morali: “Per quanto l’uomo possa essere considerato egoista nella sua natura ci sono chiaramente alcuni principi che lo fanno interessare alla sorte degli altri, e che gli rendono necessaria l’altrui felicità”. E in un altro passaggio troviamo un’intuizione molto profonda e ricca: “Quale maggiore felicità di essere amati e sapere di meritare di essere amati?” (p. 113).
Sorge spontanea la domanda: nella vulgata ufficiale dell’economia, che fine ha fatto l’anima civile di Smith, così importante come abbiamo visto? Dobbiamo riconoscere che essa in buona parte è stata smarrita durante il cammino delle moderne scienze sociali. Se infatti noi guardiamo al modo di intendere oggi l’economia (sia come teoria che come applicazioni operative), i pilastri tipici dell’economia civile - virtù, socialità, felicità – sono quasi del tutto assenti. Perché?
Una ragione è che gli economisti successivi a Smith si sono ricollegati ora all’una ora all’altra componente della sua complessa opera ma disarticolandole fra di loro. Di fatto, quindi, né le letture di sinistra (interessate alla sua teoria dei prezzi basata sul lavoro, o agli aspetti alienanti della divisione del lavoro) né quelle di destra (che hanno fatto di Smith il paladino di tutti i liberismi, di ieri e di oggi), hanno reso giustizia alla complessità della sua opera. Solo negli ultimissimi anni si è giunti ad una comprensione nuova del pensiero di Smith: si pensi ad esempio ad A. Sen; ma le nuove interpretazioni di un pensiero non hanno effetto retroattivo sulle conseguenze teoretiche e pratiche che quelle letture parziali hanno prodotto in questi due secoli. Così nel XIX secolo e per buona parte del XX secolo ci si è rifatti a Smith per rivendicare la necessità del tornaconto individuale affinché si dia una buona scienza economica (dimenticandone l’antropologia e la sua visione complessiva dell’azione umana e della società); d’altra parte, come reazione ad una lettura di Smith di questo tipo, sono nati movimenti di pensiero che contrappongono all’interesse individuale l’altruismo, e all’individualismo il collettivismo, perdendo di vista che la teoria relazionale di Smith e la sua economia erano ben altra cosa.
L’economia civile di Leonardo Bruni, Leon Battista Alberti, Antonino da Firenze, Vico, Genovesi, Romagnosi e Smith non è però morta. In questi due secoli essa ha continuato a scorrere, come fiume carsico, nel sottosuolo delle dottrine economiche ufficiali; in alcuni momenti è riemersa, alimentando il pensiero di alcuni economisti, e anche importanti (un nome per tutti è quello dell’inglese Alfred Marshall): tutti brani di storia dell’economia civile che ancora deve essere scritta.
5. A partire dalla prima metà dell’Ottocento, la visione civile del mercato e, più in generale, dell’economia scompare sia dalla ricerca scientifica sia dal dibattito politico-culturale. Parecchie e di diversa natura le ragioni di tale arresto. Ci limitiamo ad indicare le due più rilevanti. Per un verso, la diffusione a macchia d’olio, negli ambienti dell’alta cultura europea, della filosofia utilitarista di Jeremy Bentham, la cui opera principale, che è del 1789, impiegherà parecchi decenni prima di entrare, in posizione egemone, nel discorso economico. E’ con la morale utilitaristica – non si dimentichi che l’utilitarismo è una teoria etica – che prende corpo dentro la scienza economica dominante l’antropologia iper-minimalista dell’homo oeconomicus e con essa la metodologia dell’atomismo sociale.
Per l’altro verso, l’affermazione definitiva della società industriale che fa seguito alla rivoluzione industriale. Quella industriale è una società che produce merci. La macchina predomina ovunque e i ritmi della vita sono meccanicamente cadenzati. L’energia sostituisce, in gran parte, la forza muscolare e da’ conto degli enormi incrementi di produttività, che a loro volta si accompagnano alla produzione di massa. Energia e macchina trasformano la natura del lavoro: le abilità personali sono scomposte in componenti elementari. Di qui l’esigenza del coordinamento e dell’organizzazione. Si fa avanti così un mondo in cui gli uomini sono visualizzati come “cose”, perché è più facile coordinare “cose” che non uomini, e nel quale la persona è separata dal ruolo che essa svolge. Le organizzazioni, in primis le imprese, si occupano dei ruoli, non delle persone. E ciò avviene non solamente all’interno della fabbrica, ma nella società intera. Il ford-taylorismo costituirà poi il tentativo (riuscito) più alto di teorizzare questo modello di ordine sociale. L’affermazione della “catena di montaggio” trova il suo correlato nella diffusione del consumismo; donde la schizofrenia tipica dei “tempi moderni”: da un lato, si esaspera la perdita di senso del lavoro (l’alienazione dovuta alla spersonalizzazione della figura del lavoratore); dall’altro lato, a mo’ di compensazione, si rende il consumo opulento. Il pensiero marxista e le sue articolazioni pratiche ad opera del movimento socialista si adoperano in vario modo, come sappiamo, per offrire vie d’uscita ad un tale modello di società.
Dal complesso intrecciarsi e scontrarsi di questi due insiemi di ragioni ne è derivata una conseguenza importante ai fini del nostro discorso: l’affermazione, tuttora dominante e forte più che mai, di due opposte concezioni del mercato. L’una è quella che lo vede come un “male necessario”, cioè come un’istituzione di cui non si può fare a meno, perché garanzia di progresso economico, ma pur sempre un “male” da cui guardarsi e pertanto da tenere sotto controllo. L’altra è quella che considera il mercato come luogo idealtipico per risolvere il problema politico, proprio come sostiene la posizione liberal-individualistica, secondo cui la “logica” del mercato deve potersi estendere, sia pur con gli adattamenti e raffinamenti del caso, a tutti gli ambiti della vita associata – dalla famiglia, alla scuola, alla politica.
Non è difficile cogliere gli elementi di oggettiva debolezza di queste due concezioni tra loro speculari. La prima – stupendamente resa dall’aforisma “Lo Stato non deve remare, ma stare al timone” – si appoggia sull’argomento della lotta alle ineguaglianze: solo interventi dello Stato in chiave redistributiva possono ridurre la forbice fra individui e fra gruppi sociali. Le cose però non stanno in questi termini. Le disuguaglianze nei nostri paesi avanzati, che erano diminuite dal 1945 in poi, sono tornate scandalosamente a crescere negli ultimi vent’anni e ciò nonostante i massicci interventi dello Stato in economia. (In Italia, lo Stato intermedia circa il 50% della ricchezza prodotta nel paese). Conosciamo certamente le ragioni di ciò: dall’ingresso nei processi produttivi delle nuove tecnologie al fenomeno della globalizzazione; ma il punto è capire perché la ridistribuzione perequatrice non può essere un compito esclusivo dello Stato. Il fatto è che la stabilità politica è un obiettivo che, nelle condizioni attuali, non si raggiunge con misure di riduzione delle ineguaglianze, ma con la crescita economica. La durata e la reputazione dei nostri governi democratici sono assai più determinate dalla loro capacità di accrescere il livello della ricchezza che non dalla loro abilità di ridistribuirla equamente tra i cittadini. E ciò per la semplice, ma tragica, ragione che i “poveri” non vanno a votare, o ci vanno relativamente meno, e dunque non costituiscono una classe di stakeholders (i portatori di interessi) capace di impensierire la ragion politica. Ecco perché, oggi, occorre intervenire anche sul momento della produzione della ricchezza e non solo su quello della ridistribuzione se si vuole contrastare l’aumento endemico delle disuguaglianze.
Cosa c’è che non regge nell’altra concezione del mercato, oggi efficacemente veicolata dal pensiero unico della one best way? C’è che non è vero che la massima estensione della logica (liberal-individualistica) del mercato accresce il benessere per tutti. Non è vera, cioè, la metafora secondo cui “una marea che sale solleva tutte le barche” – nelle scienze sociali forse nulla è più pericoloso delle metafore, soprattutto quelle sbagliate! Chi crede a quella metafora ragiona così: poiché il benessere dei cittadini dipende dalla prosperità economica e poiché questa è associata all’estensione delle relazioni di mercato, la vera priorità dell’azione politica dovrebbe essere quella di assicurare le condizioni per la fioritura massima dei mercati. Se ne trae che il welfare state quanto più è generoso tanto più agisce come vincolo alla crescita economica e quindi alla diffusione di benessere. Donde la raccomandazione di un welfare selettivista che si occupi solamente di coloro che la gara di mercato lascia ai margini. Gli altri, quelli che riescono a rimanere entro il circuito virtuoso della crescita, provvederanno da sé alla propria tutela. Ebbene, senza ricorrere ad argomenti raffinati, è la semplice osservazione dei fatti a svelarci l’aporia che sta alla base di tale linea di pensiero: crescita economica (cioè aumenti sostenuti di ricchezza) e progresso civile (cioè allargamento degli spazi di libertà delle persone) non riescono più a marciare insieme. Come dire che all’aumento del benessere (welfare) non si accompagna più un aumento della felicità (well-being): restringere la capacità di partecipare all’attività economica di chi, per una ragione o l’altra, resta ai margini del mercato, mentre non aggiunge nulla a chi vi è già inserito, produce un razionamento della libertà, che è comunque deleterio per la felicità di tutti, per la “pubblica felicità”.
Le due concezioni di mercato che abbiamo or ora criticato, tra loro diversissime quanto a presupposti filosofici e a conseguenze politiche, hanno finito col generare, a livello di cultura popolare, un risultato a dir poco paradossale – ovviamente non intenzionale. Si tratta dell’affermazione di un’idea di mercato antitetica a quella della tradizione di pensiero dell’economia civile. Un’ idea, cioè, che vede il mercato come meccanismo fondato su una duplice norma: l’impersonalità delle relazioni di scambio (tanto meno conosco della mia controparte tanto maggiore sarà il mio vantaggio, perché gli affari riescono meglio con gli sconosciuti!); il comportamento esclusivamente auto-interessato di tutti coloro che prendono parte al gioco di mercato (con il che “sentimenti morali” come la simpatia, la reciprocità, la socialità etc. se pure vengono riconosciuti, non viene attribuito loro uno spazio nell’arena del mercato uno spazio in cui manifestarsi concretamente). E’ così accaduto che la progressiva e maestosa espansione delle relazioni di mercato nel corso dell’ultimo secolo e mezzo ha finito con il rafforzare quell’interpretazione pessimistica del carattere degli esseri umani che, come abbiamo visto nel paragrafo 3, era stata teorizzata da Hobbes e da Mandeville: solo le dure leggi del mercato riuscirebbero a domarne gli impulsi perversi e le pulsioni di tipo anarchico. La visione caricaturale della natura umana che così si è imposta ha contribuito ad accreditare un duplice errore: che la sfera del mercato coincide con quella dell’egoismo, con il luogo in cui ognuno persegue, al meglio, i propri interessi collettivi e, simmetricamente, che la sfera dello Stato coincide con quella della solidarietà, del perseguimento cioè degli interessi collettivi. E’ su tale fondamento che è stato eretto il ben noto, ma assai fragile, modello dicotomico Stato-mercato: l’identificazione dello Stato con il pubblico e del mercato (luogo delle sole imprese che operano per il profitto) con il privato.
Ma vi è di più. Quel che è peggio è che l’uscita di scena della prospettiva dell’economia civile, del mercato come veicolo di civilizzazione, ha costretto quelle organizzazioni della società civile oggi universalmente note come non profit o terzo settore, a definire la propria identità in negativo rispetto ai termini di quella dicotomia: come “non Stato” o “non mercato”. Si consideri una realtà come quella nordamericana, dove, per tutto un insieme di ragioni, l’istituzione Stato non ha mai giocato un ruolo determinante nel forgiare l’ordine economico di quella società. In un contesto del genere se un soggetto della società civile vuole intervenire in ambito economico con la produzione di beni o servizi senza però perseguire l’obiettivo del profitto non ha altra scelta che chiamarsi “non profit”. In tal senso, gli enti non profit si connotano come non mercato, perché quest’ultimo è occupato totalmente dagli enti for profit. Non è privo di interesse ricordare che nel Nordamerica la stragrande maggioranza delle organizzazioni non profit sono nate per iniziativa di imprenditori for profit e non già da associazioni, come in Europa. Tanto è vero che scuole, università, ospedali, fondazioni conservano il nome del loro fondatore o benefattore, quasi sempre un uomo d’affari. Si consideri ora l’Europa, dove lo Stato ha sempre esercitato un ruolo importante nella sfera economico-sociale (non si dimentichi che il welfare state è tipica invenzione e realizzazione europea). In tale quadro, le organizzazioni della società civile che hanno voluto emergere come alternativa alla modalità di fornitura pubblico-statale dei servizi di welfare hanno dovuto caratterizzarsi come non Stato. Non avrebbe avuto senso, infatti, che si chiamassero non profit, dal momento che anche l’ente pubblico è un soggetto non profit. Di qui l’espressione terzo settore: un settore che è, appunto, terzo dopo il mercato e lo Stato.
Non vi è chi non veda come questa sistemazione teorica lasci (tutti o quasi) insoddisfatti. Non solamente perché da essa discende che il terzo settore può tutt’al più aspirare ad un ruolo residuale e di nicchia, ma anche perché tale ruolo sarebbe comunque transitorio. Come ha recentemente affermato Hansmann – uno dei “guru” americani della teoria del non profit – quelle non profit sono “transitional organizations” (organizzazioni transitorie che nascono per soddisfare nuovi bisogni non ancora raggiunti dal mercato), destinate, col tempo, a scomparire oppure a convergere sulla forma di impresa capitalistica. Su cosa poggia una “certezza” del genere? Sulla acritica accettazione del presupposto secondo cui la forma naturale di fare impresa è quella capitalistica e dunque che ogni altra forma di impresa deve la propria ragion d’essere o a un “fallimento del mercato” oppure a un “fallimento dello Stato”. Quanto a dire che se si potessero rimuovere le cause generatrici di quei fallimenti (le asimmetrie informative; l’incompletezza dei contratti; i mal funzionamenti della burocrazia e così via) si potrebbe tranquillamente fare a meno del terzo settore, come già più di un osservatore e studioso va dicendo.
In definitiva, una volta supinamente accolto il principio della naturalità dell’individualismo, e in particolare dell’homo oeconomicus, si ha che l’unico banco di prova per l’organizzazione non profit è quello dell’efficienza: solamente se essa dimostra di essere più efficiente dell’impresa privata e/o dell’impresa pubblica ha titolo per continuare ad operare e quindi ad essere rispettata. Ma dove conduce un modo di ragionare del genere? A far diventare l’efficienza il principio universale e unico da porre a fondamento dell’ordine sociale.
6. Si pone la domanda: per quali ragioni, in anni recenti, questa concettualizzazione del non profit e del terzo settore ha cominciato ad entrare in crisi? Ne indichiamo due, quelle che ci paiono più rilevanti. La prima ha a che vedere con la crisi del modello tradizionale di welfare state, una crisi che ha definitivamente aperto la strada alla cosiddetta welfare society. La necessità e l'urgenza della transizione dal welfare state alla welfare society sono qualcosa di ormai culturalmente acquisito anche nella società italiana. Si tratta di un risultato certamente importante di cui andare "orgogliosi". Basti pensare che ancora pochi anni fa, ciò non si sarebbe potuto dire. Va dunque riconosciuto che la battaglia condotta affinchè nel titolo V della nostra Costituzione venisse esplicitamente inserito il principio di sussidiarietà in senso orizzontale ha prodotto e va producendo i frutti sperati. La sfida che ora va raccolta però è come dare concreta realizzazione alla welfare society. Tre, basicamente, sono i modelli oggetto di discussione e di confronto, in sede sia teorica sia politica. Il primo è il modello del "compassionate conservatorism" (il conservatorismo compassio-nevole), come viene chiamato nella letteratura anglosassone, secondo cui l'attenzione ai bisogni e alle necessità di chi resta indietro nella gara di mercato è affidata, in primis, alla filantropia e all'azione volontaria e, in secundis, allo stato che interviene sulla base di schemi marcatamente selettivistici. Il secondo modello è quello neo-statalista : lo stato deve conservare il monopolio della committenza , pur rinunciando , in tutto o in parte, al monopolio della gestione dei servizi di welfare. E' in ciò il fondamento del cosiddetto welfare-mix: nella effettiva erogazione dei servizi, lo stato - o meglio, l'ente pubblico - deve avvalersi della collaborazione e del concorso dei soggetti del terzo settore, ma questi devono intervenire ex post, cioè nella fase della implementazione delle decisioni prese a livello politico. Infine, v'è il modello civile di welfare - come a noi piace chiamarlo - secondo cui alle organizzazioni della società civile va riconosciuta una soggettività, non solo giuridica, ma anche economica. Ebbene se si vuole arrivare ad un welfare plurale - e non accontentarsi del solo welfare mix - è necessario che le organizzazioni della società civile possano godere di autonomia e indipendenza, soprattutto economica.
Concretamente, questo significa che il welfare civile deve riconoscere ai soggetti della società civile quella capacità, vale a dire quell’empowerment che consente loro di diventare partners attivi nel processo di programmazione degli interventi e nella adozione delle conseguenti scelte strategiche. In altri termini, non basta riconoscere al portatore di bisogni il diritto all'esercizio della voce. Il passaggio culturale da favorire è allora quello dalla libertà come potere di autodeterminazione - secondo cui la libertà di scelta è valutata per ciò che essa ci consente di fare o di ottenere - a quello della libertà come potere di autorealizzazione, come potere cioè di scegliere non solo il mezzo per un dato fine, ma anche il fine stesso. E questo perchè mentre la negazione della libertà come autodeterminazione ci sottrae utilità, la negazione della libertà come autorealizzazione ci toglie dignità; il che è certamente più grave.
La seconda ragione dell'odierna ripresa di interesse al discorso dell'economia civile è quella che concerne la questione, piuttosto seria, della disoccupazione che, come sappiamo da recenti studi empirici sulla felicità, è forse la causa maggiore di infelicità delle persone. Pur non costituendo un fenomeno nuovo nella storia del mondo occidentale, il problema occupazionale ha assunto oggi forme e caratteri che non sono ascrivibili a quelli precedenti. La dimensione quantitativa del problema così come la sua persistenza nel tempo fanno piuttosto pensare a cause di natura strutturale, legate alle caratteristiche dell’attuale passaggio d’epoca, quello dalla società fordista alla società post-fordista. Cinquant’anni fa, J.M. Keynes giudicava la disoccupazione di massa in una società ricca una vergognosa assurdità. Oggi, le nostre economie sono tre volte più ricche rispetto ad allora. Keynes avrebbe dunque ragione di considerare la disoccupazione attuale tre volte più assurda e pericolosa, perché in una società tre volte più ricca, l’ineguaglianza e l’esclusione sociale che la disoccupazione provoca è, almeno tre volte, più disgregante. Quel che è peggio è che la disoccupazione pare sia diventata lo strumento per la prosperità economica: chi licenzia non è tanto l’impresa in crisi, ma quella in salute che vuole dilatare il proprio margine di competitività. E’ proprio questo che fa problema: la disoccupazione non più come sintomo o effetto di una situazione di crisi, ma come strategia per competere con successo nell’epoca della globalizzazione.
Ebbene, è ormai diffuso il convincimento che un ordine sociale che supinamente incorporasse tra i suoi meccanismi di funzionamento un tale uso strategico della disoccupazione non sarebbe moralmente accettabile, né – si può aggiungere – economicamente sostenibile. Dobbiamo allora chiederci se invece di affrontare la questione a spizzico, allineando suggerimenti e misure disparate, tutti in sé validi ma ben al disotto delle necessità, non sia indispensabile riflettere sulle caratteristiche di fondo dell’attuale modello di crescita per ricavarne linee di intervento meno rassegnate e incerte. La nostra tesi è che la disoccupazione di oggi è la conseguenza di una organizzazione sociale incapace di articolarsi nel modo più adatto a valorizzare le risorse umane a disposizione. E’ un fatto che le nuove tecnologie della Terza Rivoluzione Industriale liberano tempo sociale dal processo produttivo, un tempo che l’attuale assetto istituzionale delle nostre società trasforma in disoccupazione. In altro modo, l’aumento, a livello di sistema, della disponibilità di tempo – un tempo utilizzabile per una pluralità di usi diversi – continua ad essere utilizzato per la produzione di merci (o di servizi alla produzione delle merci) di cui potremmo tranquillamente fare a meno e che invece siamo "costretti" a consumare, mentre non vengono prodotti beni e servizi che vorremmo consumare negli ammontari desiderati. Il risultato di questo stato di cose è che troppi sforzi ideativi vengono indirizzati su tentativi sempre più illusori di creare nuove occasioni di lavoro effimere o precarie anziché impiegati per riprogettare la vita di una società post-industriale fortunatamente capace di lasciare alle “nuove macchine” le mansioni ripetitive e quindi potenzialmente capace di utilizzare il tempo così liberato per impieghi che allarghino gli spazi di libertà dei cittadini. Eppure, ancora diffusa (e creduta) tra gli esperti è l’idea che si possa intervenire con successo sulla disoccupazione operando sui rimedi tradizionali, quelli cioè che sono stati applicati in tempi più o meno recenti per far fronte alle tre grandi categorie di disoccupazione: quella associata all’alto costo del lavoro; quella da carenza di domanda effettiva; quella tecnologica.
Non v’è alcun dubbio che nella situazione odierna tutti e tre i tipi di disoccupazione sono presenti e dunque che una riforma dei metodi di finanziamento dell’assistenza sociale e /o una riforma dei sistemi di tassazione che riducesse il carico fiscale del lavoro dipendente contribuirebbe a ridurre la prima tipologia di disoccupati. E’ del pari vero che una politica di rilancio degli investimenti pubblici sulla linea suggerita dal “Piano Delors” varrebbe a ridurre la disoccupazione Keynesiana. Così come intervenendo con le cosiddette politiche attive del lavoro (le varie forme di flessibilità) si andrebbe a intaccare la disoccupazione tecnologica. Ma tutto ciò - posto che fosse fattibile - non sarebbe comunque sufficiente per giungere ad una società della piena occupazione. E' a questo punto che entra in scena la proposta dell'economia civile.
7. Vado a concludere. I punti sollevati in questa presentazione rinviano tutti ad una questione, per così dire, ultima: come risolvere quello che è stato chiamato il paradosso della felicità tipico delle nostre società avanzate: la crescita del reddito non solo non sempre conduce ad un aumento di felicità, ma può addirittura provocarne una diminuzione. Il fatto è che la felicità non proviene solamente dai beni e servizi che il denaro è capace di comprare - come invece è vero con l'utilità. Il denaro serve bensì, ma vi sono altre "cose" che servono molto di più: i beni relazionali, come li abbiamo definiti nella lezione precedente. Ebbene, le promesse che le nostre società di mercato fanno di una felicità che dipende dal consumo di beni posizionali porta a sacrificare il consumo dei beni relazionali per poter conseguire il reddito monetario necessario per acquistare i primi. (Si pensi al tempo crescente che il cosiddetto secondo e terzo lavoro rubano alle relazioni familiari e ai rapporti di amicizia). Ma siccome la felicità dipende in gran parte da questi beni sacrificati, ne deriva il paradosso per il quale abbiamo sempre più ricchezze, ma siamo sempre meno felici, proprio come tanti Re Mida che muoiono di una fame che l'oro non può saziare. In buona sostanza, utilità e felicità non sono la medesima cosa, perché la prima è la proprietà della relazione tra uomo e cose (i beni, i servizi, infatti, sono utili); mentre la felicità è la proprietà della relazione tra persona e persona.
Il tradimento di un discorso economico "vecchio stile" sta tutto qui: far credere - soprattutto ai giovani - che per essere felici basti cercare di aumentare l'utilità. Eppure, mentre si può essere dei massimizzatori di utilità in solitudine (come il Robinson Crusoe della celebre storia), per essere felici bisogna essere almeno in due – una verità, questa, che la tradizione dell’economia civile aveva capito fin dalle sue origini, ricordandoci che la felicità o è pubblica o non è. A scanso di equivoci, non si vuole qui dire che la produzione e il consumo di "cose", cioè di utilità, sia un male e dunque che hanno ragione i sostenitori del modello pauperista. Tutt'altro! Piuttosto, si vuol dire che le nostre società di oggi non sono sufficientemente "avanzate", perché non consentono, nei fatti, una vera libertà di scelta, la quale non è semplicemente la scelta all'interno di un menu preconfezionato, ma è, in primo luogo, la scelta dello stesso menu. E in ciò il senso ultimo della proposta dell'economia civile.
Riferimenti bibliografici:
Borzaga C., Fazzi L., Azione volontaria e processi di trasformazione del settore non profit, Milano, Angeli, 2000.
Garin E., (1988), La cultura del rinascimento, Il Saggiatore, Milano.
Garin E., (1994) [1947], L’umanesimo italiano, Laterza, Bari.
Hobbes Thomas, De Cive. Elementi filosofici sul cittadino, a cura di T. Magri, Editori Riuniti, Roma 1999.
Bruni L., Pellagra V., Economia come impegno civile, Città Nuova, Roma, 2002.
Mandeville B. de, La favola delle api, a cura di T. Magri, Laterza, Bari, 1987.
Margalit A., La società decente, Milano, Baldini e Castoldi, 1998.
Donati P. (a cura di), La società civile in Italia, Milano, Mondadori, 1997.
Sacco P., Zamagni S. (a cura di), Complessità relazionale e comportamento economico, Bologna, Il Mulino, 2002.
Calmieri G., Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli, Pirotta e Maspero, Milano, 1788.
Palmieri M., (1981), [1440], Della vita civile, Olscki, Firenze.
Patrizi F., (1553), La città felice, Venezia
Zamagni S., Non profit come economia civile, Bologna, Il Mulino, 1998.
Smith Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
Oxford University Press, 1976. Prima edizione 1776.
Smith Adam, Lectures on Jurisprudence. Oxford University Press, 1978. Prima edizione manoscritta 1763.
Smith Adam, The Theory of Moral Sentiments. Oxford University Press, 1976. Prima edizione 1759.
Sugden R. e Bruni L., “Trust and Social capital in the work of Hume, Smith and Genovesi”, in Economics and Philosophy, n. 16, 2000.
Todorov T., (1998), La vita in comune, Nuova Pratiche Editrice, Milano.
Nota
* Per un'esposizione più ampia e articolata del tema qui sviluppato rinvio a S. Zamagni e L. Bruni, Lezioni di Economia Civile, Editoriale VITA, Milano, 2003.
 IT
IT  EN
EN