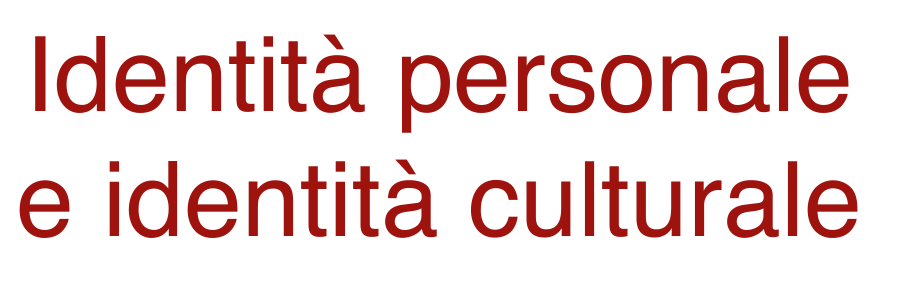


ANTONINO URSO TERESA DI BONITO
 “La sfera - dice il Papa - può rappresentare l'omologazione, come una specie di globalizzazione: è liscia, senza sfaccettature, uguale a se stessa in tutte le parti. Il poliedro ha una forma simile alla sfera, ma è composta da molte facce. Mi piace immaginare l'umanità come un poliedro, nel quale le forme molteplici, esprimendosi, costituiscono gli elementi che compongono, nella pluralità, l'unica famiglia umana. E questa sì è una vera globalizzazione. L'altra globalizzazione - quella della sfera - è una omologazione". (Verona 2014, 3° Festival della dottrina sociale).
“La sfera - dice il Papa - può rappresentare l'omologazione, come una specie di globalizzazione: è liscia, senza sfaccettature, uguale a se stessa in tutte le parti. Il poliedro ha una forma simile alla sfera, ma è composta da molte facce. Mi piace immaginare l'umanità come un poliedro, nel quale le forme molteplici, esprimendosi, costituiscono gli elementi che compongono, nella pluralità, l'unica famiglia umana. E questa sì è una vera globalizzazione. L'altra globalizzazione - quella della sfera - è una omologazione". (Verona 2014, 3° Festival della dottrina sociale).
 Con il modello del poliedro si superano e si rispettano tutte le differenze culturali, personali, etniche, religiose, sessuali.
Con il modello del poliedro si superano e si rispettano tutte le differenze culturali, personali, etniche, religiose, sessuali.
Diversi autori considerano la migrazione come un grande rischio: da una parte, in ragione della condizione economica e sociale in cui si collocano gli individui e i gruppi migranti; dall’altra, per il fatto di minare l’integrità identitaria del soggetto, attraverso uno shock culturale tale da produrre dei disturbi psichici. L’assistenza psicologica ai migranti è certamente un’impresa difficile e necessita, per l'accennata complessità delle problematiche compresenti, di formazioni e specializzazioni molteplici. La stessa relazione clinica non si presenta come un semplice contatto tra due singoli, ma racchiude un ponte tra due mondi, ognuno dei quali riproduce le proprie conoscenze, le personali credenze e le singole attese.
Anche se la comprensione dell’esperienza psicologica dei migranti non necessita di una psicologia ad hoc, essa non può che fondarsi su conoscenze specialistiche che necessariamente rinviano allo sviluppo dell’essere umano, mettendo in evidenza le diverse variabili in gioco: il ruolo delle interazioni con l’ambiente familiare, il carattere strutturante delle relazioni sociali, i legami tra il funzionamento affettivo, cognitivo e sociale, le dinamiche dei rapporti interpersonali e intergruppo, i meccanismi della costruzione del sé e dell’identità, il ruolo delle inserzioni sociali ed altre ancora.
Grazia Biorci del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - IRCRES (Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile afferma che: “Tra le variabili che più spesso si riscontrano nei colloqui terapeutici introduttivi, vi sono le situazioni di difficoltà di percezione di se stessi dentro di sé e in relazione al mondo esterno. Il disagio che ne deriva sono momenti di scollamento in cui l’individuo si sente spaesato e rischia di sviluppare delle tecniche o delle modalità di sopportazione o superamento del disagio che possono sfociare in comportamenti usualmente reputati devianti o violenti. Molto spesso le lunghe separazioni, ma anche i ricongiungimenti, sono fonte di grandi tensioni nelle persone immigrate. Questi eventi, infatti, impongono un periodo difficile nel quale si devono riconoscere gli altri, parenti anche strettissimi, si deve tentare la ricostruzione del contatto e della relazione fra persone che, pur legate da parentela o da grande affetto, hanno percorso, tuttavia, una parte del cammino da soli e distanti dal proprio ambiente nativo” ("Verso una pragmatica interculturale: l'espressione e l'interpretazione del disagio psicologico degli immigrati", RiMe, 2009, p. 214).
Un bambino piccolo non sa ancora bene chi sia (è una specie di piccolo caos); alla ricerca di una propria identità, inizia a connotarsi e a significarsi rispecchiandosi nello sguardo e nel comportamento dei suoi genitori, in base alle loro aspettative: potremmo dire in base alle maschere che il padre o la madre gli fanno indossare, quando egli non è ancora in grado di definire ed esprimere la propria identità. Abbiamo usato il termine "maschera" perché in tutte le tradizioni simboliche conosciute la maschera assolve alla funzione principale di fornire una identità a chi se ne serve e che si utilizza per esigenze rituali, comunitarie o sociali quando, per qualche motivo, non si può o non si vuole mostrare il proprio vero volto (dunque la propria identità). Il termine persona si riferisce ad un essere che possiede specifiche, spiccate e appropriate caratteristiche individuali: di un uomo dotato di personalità si dice che è una persona nel senso proprio del termine; persona in latino, derivandolo dal greco pròsopon, non a caso significa maschera.
Con il termine maschera o persona la psicologia analitica junghiana intende l’aspetto che l’individuo assume nelle relazioni sociali e nel rapporto con il mondo, cioè l’immagine che fornisce quale rappresentazione pubblica. La maschera / persona crea uno spazio psicologico di versatilità necessario a rispondere alle necessità esistenziali: l’atteggiamento verso l’esterno è un “saper stare al mondo” che prevede un soggetto che ha delle competenze e conosce i fondamenti della propria costruzione culturale. La maschera è anche un mediatore tra l’Io e il mondo esterno: essa esprime la possibilità dell’individuo di adattarsi all’ambiente sociale, culturale e umano, di presentarsi e al contempo di nascondersi. La funzione psicologica che Jung chiama Persona è una maschera che ha, tra gli altri, lo scopo di far emergere dall’indifferenziato, nel tempo, quello che siamo veramente, e di rappresentarlo.
Dal punto di vista psicologico la maschera rappresenta un filtro tra la coscienza individuale e l’esterno, inteso come coppia, famiglia, società. C’è una maschera dove c’è una relazione, un’interazione umana: solo quando siamo da soli non ne abbiamo bisogno, forse. Ogni maschera con il suo specifico aspetto, ognuna con la propria funzione, una maschera per ogni situazione e per ogni stagione del nostro umore: se ne siamo consapevoli, le maschere ci aiutano ad immedesimarci nei vari ruoli a cui la società ci chiama, ad agire e relazionarci nel nostro ambiente di vita. Quando sono presenti un sufficiente equilibrio emotivo e una adeguata conoscenza di sé, è possibile entrare ed uscire dalle maschere senza forzature ed in modo armonico, consapevoli in ogni momento di chi siamo, di come ci stiamo muovendo e della direzione nella quale stiamo andando. Le maschere diventano così strumenti al nostro servizio, arricchimento ed espressione della nostra personalità; al contrario, finché l’individuo non conosce se stesso non può riconoscere neanche le proprie maschere, rischiando di esserne dominato da esse.
Quando manca un reale contatto con se stessi, con i propri sentimenti, con le personali istanze e aspirazioni, in assenza quindi di comprensione e di significato, l’individuo si incancrenisce in un’unica modalità espressiva, indossando la stessa arida maschera. La persona che “diventa” il proprio ruolo sociale o familiare, il proprio lavoro, la propria missione, si identifica con la maschera in modo così totalizzante da dimenticare che sotto ci sia mai stato qualcos’altro. L’identità non è però solo una caratteristica appartenente al singolo: può anche essere propria di una specifica comunità, come pure della società intera.
Individuo e società infatti sono in reciproco rapporto duale: la società partecipa alla costruzione dell’identità di ciascuno, mentre l’individuo contribuisce a trasformare la società, intesa nelle sue declinazioni di istituzioni, organizzazioni e gruppi. Individuazione e sviluppo psicosociale quindi poggiano su una doppia fondazione transpersonale: la matrice culturale di base e la matrice del gruppo familiare. Derivato dal latino “mater”, “madre”, il concetto di matrice è fondamentale nella teoria foulkesiana: l’ipotetica trama di comunicazioni e di relazioni in un dato gruppo, un costrutto teorico il cui scopo è mettere in luce l’esistenza di trame psichiche comuni da cui traggono senso le vicende dei singoli, uno sfondo comune condiviso. Essa costituisce una vera e propria rete di rapporti, che rappresenta il reticolo interpersonale complessivo formato dai membri di un gruppo nel loro reciproco relazionarsi.
L’autore distingue la matrice di base, dinamica e personale - intendendo quella fondata sulle proprietà biologiche della specie, ma anche sui valori e sulle relazioni saldamente radicati e trasmessi culturalmente - dal costrutto sovrapersonale che si costituisce all’interno del gruppo, rappresentando la visualizzazione di quanto avviene nel qui-e-ora in termini anche di comunicazione inconscia. Foulkes diede il nome di matrice personale ai processi soggettivi che riguardano l'individuo a partire dalla personale esperienza costitutiva in qualità di componente di un gruppo, familiare e culturale.
Si può quindi sostenere che non solo la famiglia ma anche la cultura, sin dal concepimento intenziona il soggetto nascente secondo le forme dell’identità da essa istituite e tramandate.
Ne consegue che un adeguato processo d’integrazione conduce ad una estensione di ciò che consideriamo costitutivo della nostra identità; detto in altri termini, possiamo aumentare il numero delle nostre radici, estendere il personale senso di appartenenza e diventare capaci di interagire senza timore anche con individui che hanno appartenenze diverse.
La società contemporanea appare profondamente segnata da pratiche sociali e culturali che hanno prodotto non solo l’indebolimento di quei legami che derivano dal senso di appartenenza e dalla partecipazione alla vita collettiva, ma anche - come esito conclusivo del processo di progressiva distruzione del senso psicologico di comunità - isolamento, anomia, segregazione. Nel passato chi era afflitto da problemi che la vita gli faceva esperire come singolo individuo, aveva la possibilità di significarli e condividerli all’interno di un contenitore saldo e capace; per quanto tragici, i suoi guai potevano apparire come incidenti di un percorso accidentato e difficile, in un paesaggio sostanzialmente integro: ci sarebbe sempre stata una Chiesa, una Patria, uno Stato, un Paese d’origine a riconoscerlo, a fornirgli un posto, ad accoglierlo quando smarrito.
Questa percezione di qualcuno (Chiesa, Stato, Comunità) disposto a riconoscerci, assegnarci un posto, accoglierci ed aiutarci, è difficile già per chi cresce nel proprio Paese d’origine, nella propria città e quartiere; per un migrante, che vive lontano dalle proprie radici e spesso persino dalla propria famiglia, questo aiuto appare impossibile.
Se mettersi in viaggio significa lasciare persone care, luoghi nei quali si è vissuti, cose e abitudini familiari, allora la migrazione implica necessariamente una frattura, un distacco forzato da qualcuno (familiari, amici) e da qualcosa (la casa, il quartiere, il luogo di lavoro).
Ma non solo: migrare significa implicitamente di più. Significa abbandonare tutti gli involucri che hanno protetto sino a quel momento: il ventre materno, il parco dei giochi di bambino, la famiglia, il gruppo di amici, i tanti luoghi della socializzazione (il bar, la piazzetta, la strada del passeggio, il circolo). Lasciare tutto per dirigersi altrove, in luoghi lontani dalle immagini consuete, dagli odori e dai suoni familiari, da tutte quelle sensazioni che si è imparato a conoscere e che costituiscono i solchi e i primi tracciati della storia personale, l'impalcatura grazie alla quale il codice del funzionamento psichico ha preso gradualmente forma, sino ad arrivare a compiersi e a stabilizzarsi. Il risultato è quello di trovarsi a metà strada tra due culture, quella di provenienza e la nuova che accoglie. È inevitabile vivere sulla pelle le molte contraddizioni che ne derivano; conseguenze possono essere la voglia di rifiutare in toto la nuova cultura o, viceversa, il tentativo di integrarsi pienamente, tra la paura di essere rifiutati in ragione della propria diversità e la tentazione di rifiutare le proprie origini. In modo aristotelico, la soluzione più funzionale e adeguata sarà quella di riuscire a trapiantare le proprie radici dalla realtà di origine alla nuova, senza rinunciare a se stessi, alla propria identità, ma anzi aprendosi agli innesti provenienti dal nuovo humus ambientale, relazionale e culturale.
Le diverse comunità migranti cercano di riprodurle lontano, mentre le comunità “tristi” e “minimali” le vedono come minaccia a ciò che è “vicino”, come rischio e come futuro insopportabile.
Una situazione nuova e inusuale crea spesso incertezza e smarrimento e richiede un tempo di adattamento più o meno prolungato a seconda della personalità di chi la affronta e dei luoghi nei quali prende forma. Così il migrante che arriva in terra straniera, quando entra in contatto con la società che lo ospita, sperimenta frequentemente un fastidioso senso di disagio di fronte all’ignoto. È ricorrente che avverta un sentimento di estrema solitudine, in quanto lontano da familiari e amici, sradicato dalle sue tradizioni e proiettato in un mondo a lui estraneo. Privato della propria identità culturale e invischiato in una realtà che spesso fatica a comprendere e dalla quale spesso non è compreso, facilmente si trova a sperimentare l'indifferenza, quando non l'intolleranza e l'ostilità, del nuovo ambiente.
Winnicott considera l’eredità culturale come un’estensione dello «spazio potenziale» tra l’individuo e il suo ambiente. L’uso di tale spazio è subordinato alla formazione di uno spazio fra due: tra l’Io e il Non-Io, tra il Dentro (gruppo di appartenenza) e il Fuori (gruppo ricevente), tra il Passato e il Futuro. L’emigrazione ha quindi bisogno di uno spazio potenziale che gli serva da luogo di transizione e da tempo di transizione, tra il “paese - oggetto materno” e il nuovo mondo esterno. Se la creazione di un spazio siffatto non avviene, si determina una rottura nel rapporto di continuità tra l’ambiente circostante e il Sé.
L’«oggetto transazionale» viene vissuto come qualcosa che non è creato e controllato soggettivamene e neppure separato e trovato, ma che in qualche modo si trova nel mezzo. La frattura che si genera può essere paragonata all'assenza prolungata dell’oggetto desiderato dal bambino, che facilmente conduce alla perdita delle capacità di simbolizzazione e al bisogno di ricorrere a difese più primitive. La madre crea quello che Winnicott definisce l’ambiente di holding: uno spazio fisico e psichico in cui il bambino è protetto senza sapere di esserlo, in modo che proprio questa dimenticanza costituisca la base dalla quale potrà partire spontaneamente per le esperienze successive. Parimenti l'emigrante, con la perdita dei personali oggetti rassicuranti, subisce forzosamente una diminuzione delle proprie capacità creative; il loro recupero dipenderà dalla possibilità di elaborare lo stato di deprivazione e dalla personale capacità di superarlo.
Ancora prima di giungere nel paese straniero, in realtà, alcuni elementi possono almeno in parte definire il carattere e l’esito del progetto migratorio: le ragioni della partenza, la motivazione al viaggio, la concezione della migrazione, la cultura d’origine. L’impatto con una società distante dall'Eldorado prefigurato prima della partenza e che invece il più delle volte è inaccogliente e inospitale, distrugge le attese e le speranze del migrante; questi facilmente potrà sperimentare un profondo senso di disagio psicologico, espresso attraverso un malessere che non di rado arriverà a somatizzare (talvolta arrivando persino a sviluppare un vero e proprio disturbo mentale) e che spesso lo condurrà alla fuga dal nuovo ambiente - percepito come ostile - e al ritorno in patria, da sconfitto.
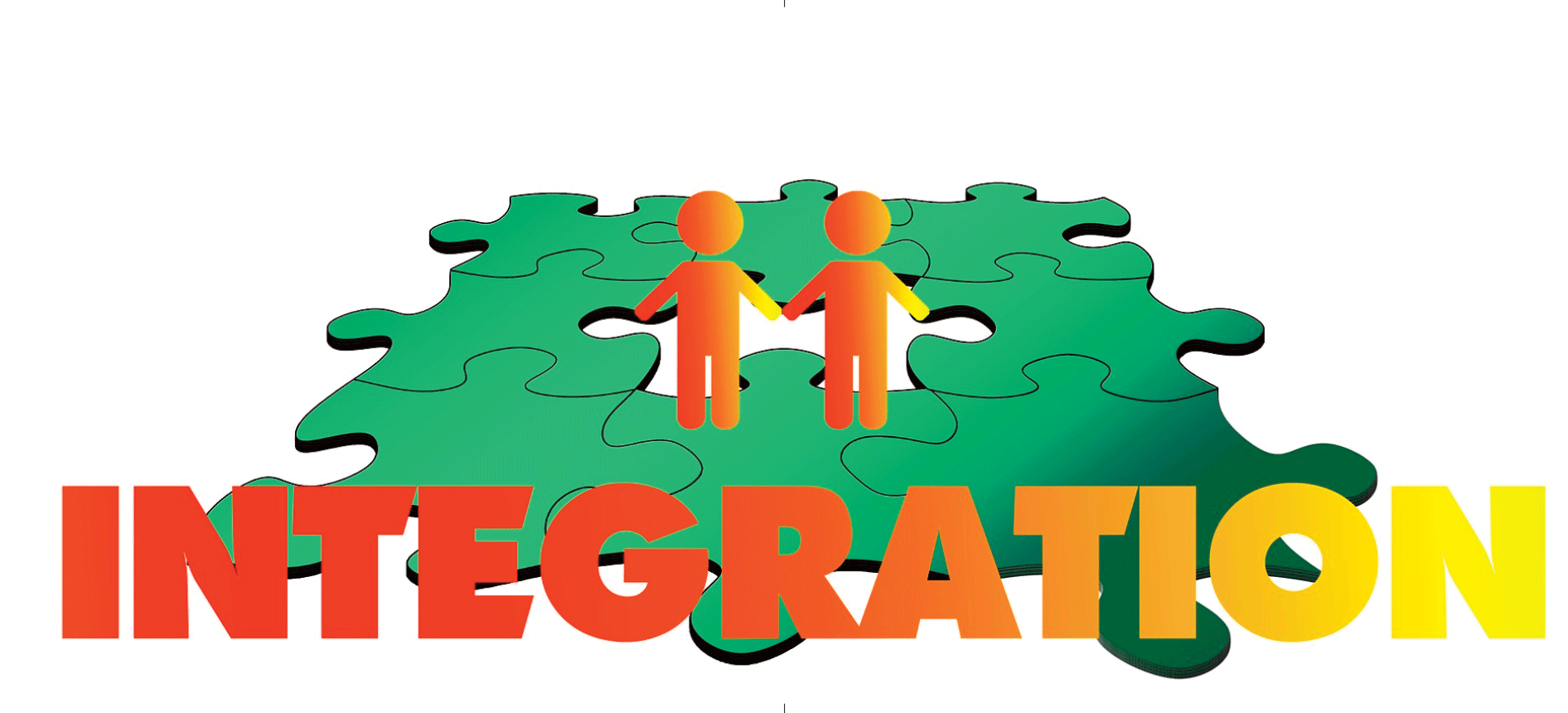
L’immigrato richiama categorie d’inclusione ed esclusione sociale quali quelle di “cittadino” e di “straniero” (interno alla società come partecipante allo sviluppo economico, ma esterno in quanto non cittadino). Essere dentro significa sentirsi appartenente al gruppo nel quale ci si rispecchia, poiché ci si sente accettati ed amati. L’appartenenza si trasforma così in difesa dal nemico comune: ci si unisce nell’idealizzazione di un “ente” comunemente riconosciuto come superiore, al quale offrire la propria dipendenza condivisa (in questo caso la Patria, la religione, le associazioni e così via.). Il dentro, quindi, è concepibile solo se si configura un fuori, inteso come estraneità simbolizzata, come “nemico”. Tutto ciò che è fuori è concepito come diverso, come altro da sé, come forestiero, come minaccia. Verso “l’altro” si vive un duplice atteggiamento che va dall’attrazione, dal desiderio di esplorazione e di conoscenza, alla rabbia distruttiva, all'invidia, alla sfida. Tale ambivalenza è presente tanto a livello sociologico che a livello culturale e psicologico. Dalle testimonianze emerge come – anche quando la partenza dal proprio Paese è una libera scelta – siano presenti, al contempo, sentimenti di paura e di colpevolezza per aver abbandonato la propria patria, la propria famiglia. La migrazione si manifesta quindi come elemento critico - generativo tanto di una serie di potenziali vantaggi (come l’accesso a una nuova opportunità di vita, di speranza e di orizzonti), quanto di un insieme di difficoltà e di tensioni. L’impatto con la nuova cultura dunque abbisogna necessariamente di un dato tempo di assestamento e di riflessione, che consenta al nuovo arrivato di conoscere il nuovo contesto e di adattarvisi. C’è un’identità inquietante e inaccettabile – quella dell’ “altro da sé” – che smentisce, relativizza e rende precaria la percezione della propria, una volta rassicurante e, con essa, le certezze dell’esistere. Un'identità precaria è quella data dalla condizione di dover continuamente ri-negoziare la propria immagine nel teatro delle relazioni sociali, come ha mostrato Ervin Goffmann, o nel gioco che presiede l’interiorizzazione del modo in cui gli altri ci vedono, come ha mostrato George Herbert Mead.
L’emigrazione è certamente una delle circostanze della vita che più espongono la persona a forme di disorganizzazione psichica; tuttavia, laddove l’individuo possieda sufficienti capacità di elaborazione cognitiva, riuscirà a superare la crisi e potrà persino assumerla quale occasione di “rinascita”: l'uomo vecchio si immerge interamente nel fonte battesimale per riemergerne come un uomo nuovo, in una sorta di "ri-creazione".
La maschera, oltre ad avere lo scopo di far emergere le individualità, può avere anche una funzione difensiva. E’ proprio durante questi momenti di messa in discussione personale che si attiva più che mai il bisogno di una maschera provvisoria, che  fornisca la consapevolezza che la personalità non sia frammentata, inter-rotta, bensì ancora unita, legata, per evitare di sprofondare nel caos dal quale potrebbe non più uscire. Spesso questa maschera provvisoria e difensiva è rigida, il più delle volte ha la forma della nevrosi; ciononostante talvolta è proprio grazie ad essa che l’individuo riesce a percepirsi ancora come un’entità coesa, un’identità, come spiega magnificamente Pirandello attraverso le sue opere. Nel momento in cui l’individuo esce dallo stato di caos, la maschera cambia: diventa più flessibile, quasi camaleontica, e si presenta come uno degli elementi psichici che più di altri può aiutare la persona ad entrare in rapporto con il mondo - tanto interno a sé quanto esterno -, rappresentando in tal modo un fattore di adattamento sano.
fornisca la consapevolezza che la personalità non sia frammentata, inter-rotta, bensì ancora unita, legata, per evitare di sprofondare nel caos dal quale potrebbe non più uscire. Spesso questa maschera provvisoria e difensiva è rigida, il più delle volte ha la forma della nevrosi; ciononostante talvolta è proprio grazie ad essa che l’individuo riesce a percepirsi ancora come un’entità coesa, un’identità, come spiega magnificamente Pirandello attraverso le sue opere. Nel momento in cui l’individuo esce dallo stato di caos, la maschera cambia: diventa più flessibile, quasi camaleontica, e si presenta come uno degli elementi psichici che più di altri può aiutare la persona ad entrare in rapporto con il mondo - tanto interno a sé quanto esterno -, rappresentando in tal modo un fattore di adattamento sano.
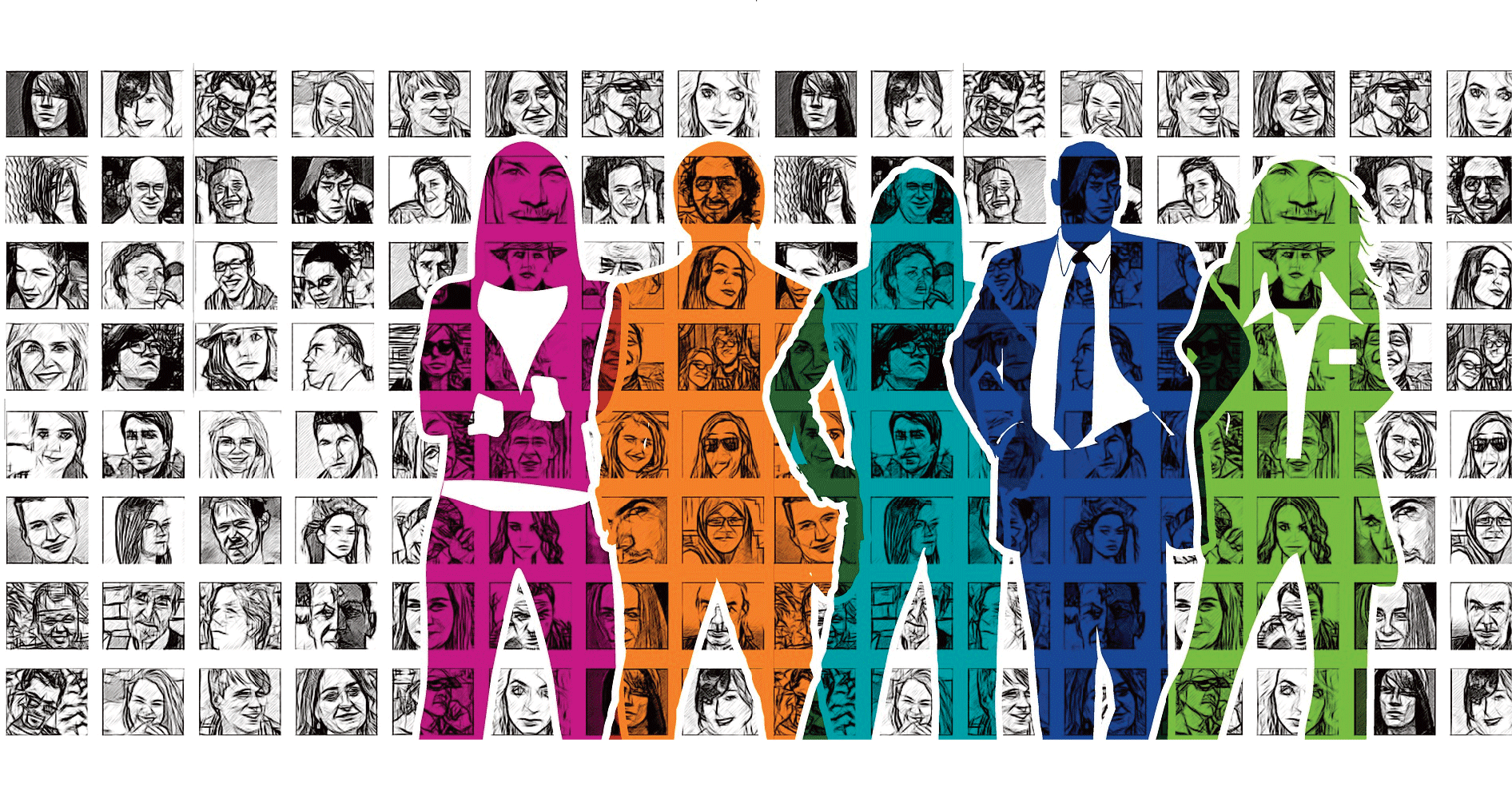
BIBLIOGRAFIA
Biorci G. "Verso una pragmatica interculturale: l'espressione e l'interpretazione del disagio psicologico degli immigrati", RiMe, 2009.
Di Bonito T. e Urso A.“Migrazione: etica sociale e accoglienza psicologica” in Oikonomia, rivista di etica e scienze sociali, 1, Febbraio 2014, 29-35.
Urso A."Depressione e Felicità" in Scienze del Pensiero e del Comport. (ISSN 1826 - 4662), Roma, 13 (12/2011).
Urso A. "Comunicazione e socialità. Alla base del senso dell’esistenza" in Favorini A.M. e Russo F. (a cura di) Relazioni e Legami nell'Esistenza Umana, la Lezione di Viktor E. Frankl (ISBN 9788820473013), Franco Angeli, Milano, 2014.
Urso A. e Crosthwaite A. (a cura di) "Appartenenza ed Identità", Anicia, 2016.
Urso A. "Maschera e Psicoterapia", Anicia, 2017.
 IT
IT  EN
EN 



















